giovedì 10 febbraio 2022 (revisione: 11 febbraio 2022 alle ore 21:59:08)
Corneli vs. Roasio
Chi scrisse le liste di proscrizione degli emigranti politici italiani in URSS
Spezzoni di una trasmissione RAI 3, non indentificata (con spezzoni di una precedente trasmissione a cura di Enzo Biagi del 1983), con interventi di Dante Corneli, Antonio Roasio (piuttosto silenzioso) e di Nazareno Scarioli (evidentemente di archivio, dato che Scarioli muore nel 1964), della storica Elena Dundovich e dello storico Giancarlo Lehner, e con ricordi degli eredi Luciana De Marchi, Parisina Baccalà, Vladimiro Bertazzoni, Nella Masutti e altri non idenficati. Verso la fine del primo video si veda la requisitoria di Corneli, Roasio presente, su chi scrivesse i fascicoli personali degli emigranti politici. Per quanto abbia constatato esaminando gli elenchi di emigranti poiltici conservati nei fascicoli del PCdI conservati negli archici del Comintern, le accuse di Corneli sono del tutto confermate, vedi mio articolo Gli Elenchi.
recuperato da YouTube
recuperato da YouTube
recuperato da YouTube
giovedì 22 aprile 2021 (revisione: 28 marzo 2024 alle ore 13:21:29)
Pons 2021. Appunti di lettura
Silvio Pons, I comunisti italiani e gli altri, Einaudi, Torino, 2021.
TESTO DI PONS PRESENTE PER COMODITÀ DI RIFERIMENTO.
LETTURA CONSIGLIATA MEDIANTE ACQUISTO DEL LIBRO O SERVIZIO DI PRESTITO DA REMOTO VIA MLOL
- su Silvio Pons, vedi il post su il suo libro su Berlinguer;
- Pons ha una particolare attenzione alle ricerche di archivio, aiutata probabilmente da una ovvia facilità di accesso agli archivi del PCI conservati presso la FIG di Roma, ma anche da una notevole familiarità con i fondi del RGASPI di Mosca, e nel corso della sua carriera di ricercatore ha scoperto e reso noto molti documenti assai interessanti. Non mi sembra che in questo libro per il centenario del PCI citi documenti di nuova scoperta, ma diversi merita comunque segnalarli, per indicarne uno le note conservate a Mosca di un colloquio dell'ottobre 1944 tra Stalin e Churchill, in cui il primo rassicura il secondo che "Togliatti non è un politico incline a imbarcarsi in «avventure» senza sbocco", vedi. Il libro non comprende una appendice documentaria, e per i documenti conservati a Mosca non viene indicato se siano stati pubblicati, o se siano almeno disponbili in copia presso la FIG. (Per i documenti citati si cerchi 'Rgaspi' nelle note del testo di Pons, i link attivi collegano ai passi in cui ai documenti ci si riferisce).
- 'I comunisti italiani e gli altri' offre una ricostruzione complessiva della storia del PCI sicuramente assai interessante. "Gli altri" del titolo rinvia alla esplicita impostazione di fondo, quella di leggere il comunismo italiano in una "un’ottica internazionale", e più esattamente sottolineando e studiando modi, prassi e dinamiche della "costruzione di senso dei nessi tra identità nazionali e appartenenze internazionali". In questo il libro io credo sia benvenuto, perché affronta con grande attenzione, senza inutili e ormai del tutto anacronistiche reticenze, e il beneficio di decadi di studi post collasso dell'URSS, la vexata quaestio dei rapporti del PCI con l'URSS, o meglio, più correttamente, dei rapporti con l'articolato complesso dei partiti comunisti nel mondo, dal 1921 fino al 1989.
Assunto ma anche risultato dell'ampia ricostruzione di Pons è che il PCI appartenne a la rete transnazionale del comunismo (reale) mondiale, 'gli altri' del titolo è da intendere riferirsi a gli altri partiti comunisti (ed eredi della Terza internazionale). A quella rete, il PCI partecipò e vi fece riferimento, dal 1921 e fino alla fine, condividendone i riti, le dinamiche, anche centrifughe, e i suoi vincoli, pur nelle difficoltà e contrarietà, e forse soffrendo di qualche periodo di separazione in casa. (Dalla ricostruzione di Pons risultano del tutto artificiose eventuali letture per cui il PCI sarebbe via via diventato una forza genericamente progressista, positivamente eclettica, con rapporti a 360º -e da considerare sullo stesso piano-con liberal-democratici statunintensi, socialdemocratici europei, cattolici democratici, vari terzomondisti e anche, ma tra i tanti, i comunisti).
Stante questa impostazione, ci può domadare come quella preferenza e correlato senso di appartenenza si formò, e poi, nelle varie fasi, si mantenne o si indebolì ; e poi anche con quali modalità di fondo il PCI si mosse in quelle relazioni preferenziali, con quali risorse, con quali capacità di lettura della realtà dei problemi del comunismo nel mondo, secondo quali strategie e tattiche, e secondo quali capacità di una loro rielaborazione e autocorrezione, e poi credendo a quali principi a carattere universalistico e con quale comprensione, nelle varie fasi, dei vincoli e/o delle possibilità che quella appartenenza imponeva e rispettamente concedeva. - La prima sezione della prima parte, I. Rivoluzione ed egemonia, è dedicata al formarsi ed evolversi della posizione di Gramsci nel contrasto tra PCdI e bolscevici russi, fino al noto scambio epistolare con Togliatti del 1926. Su quest'ultimo trovo interessante la conclusione di Pons: Gramsci non era ``volto ad affermare soltanto ragioni di principio e di politica nazionale del Pcd’I", Togliatti "non faceva valere esclusivamente ragioni di disciplina", ambedue ragionavano in termini internazionalisti, ma mentre "Gramsci si convinse che la frattura della vecchia guardia bolscevica potesse compromettere la risorsa simbolica rappresentata dallo Stato sovietico, quale condizione essenziale dell’egemonia internazionale [...]". Togliatti "non condivise questa persuasione e puntò invece sulla concreta solidità rappresentata dalla forza della maggioranza raccolta attorno a Stalin" (Per descrivere la posizione di Gramsci, Pons usa la nozione gramsciana di egemonia, anche se questa fu formulata e teorizzata da Gramsci stesso più tardi, durante la prigionia). Non sono invece convinto che la ricostruzione complessiva di Pons rappresenti adeguatamente come si sviluppò il contrasto contro Bordiga, l'evolversi delle stesse posizioni di Gramsci e le sue motivazioni, il peso -nell'affermarsi di Gramsci- della volontà della dirigenza bolscevica, e quindi i costi politici che ciò comportò in Italia tra il 1922 e il 1926, in particolare del come la diatriba, da una parte, sfibrò il PCd'I, limitandone l'azione in Italia, probabilmente più di quanto in genere si consideri e, da l'altra parte, non aiutò neppure una qualche forma di azione comune con i socialisti (questa seconda è questione annosa che Pons non affronta, forse perché fuori dall'impostazione di studio che si è dato).
- Tradizionale e non convincente l'esposizione di Pons degli anni difficili, i terribili anni dal 1935 alla guerra nazista contro l'URSS, tra Stalinismo e antifascismo; in particolare Pons è troppo accondiscendente con il ruolo di Togliatti, il protagonista del suo racconto. Una qualche cautela, innanzitutto, Pons avrebbe dovuto mostrare nel riconoscere che molti passaggi sono ancora oscuri, e che diversi momenti di quegli anni delle biografie dei diversi protagonisti del comunismo italiano sono ancora da puntualizzare con la necessaria acribia, che le biografie più o meno ufficiali presenti in voci di enciclopedia, dizionari biografici, e libri di memorialistica sono tutte alquanto (auto)censurate se non del tutto omertose, e in gran parte da riscrivere. Sarebbe forse stato utile riconoscere che una ricerca sistematica delle fonti nascoste negli archivi, sopratutto russi ma non solo, non è mai stata compiuta in modo sistematico ed esauriente, e non tanto per difficoltà oggettive o chiusura degli archivi. Appare francamente censurabile che non siano ricordati per nome gli italiani emigranti politici in URSS, periti fucilati nel poligoni di tiro di Butovo o nel gulag di Severo-Vostočnyj, e lo stesso si può dire per l'omissione di ricordare Romano Cocchi, i motivi del suo dissenso, il suo destino. Raccontare il 1938 ricordando l'arresto di Robotti e non la promozione di Roasio nel centro ristretto di organizzazione creato nell'Agosto 1938 (Roasio vi fu insieme a Grieco, Berti e Di Vittorio), significa minimizzare oltre il lecito il ruolo di Togliatti in quei frangenti e ripetere acriticamente una ricostruzione di comodo e autoassolutoria che risale di fatto ai brevi cenni autobiografici di Togliatti stesso (su tutto ciò vedi il mio articolo Gli Elenchi).
Relata alla questione di quanto Togliatti sapesse e/o condividesse della stagione delle fucilazioni, è la difficile ricostruzione delle (presunte?) difficoltà di Togliatti a Mosca tra il 1940 e il 1941, tra la (presunta?) ostilità delle sorelle Schucht e qualche commento avverso da dirigenti del PCE (Díaz, Ibárruri) che Pons ricorda. L'episodio della missiva delle Schucht, su cui Pons ha scritto un articolo, va forse ancora riletto con ulteriore attenzione all'esatto svolgersi della vicenda Gramsci negli ultimi anni della sua vita, e in particolare al coinvolgimento dell'Ambasciata sovietica a Roma in modi più quotidiani e determinanti di quanto la scarsa documentazione nota (mai ritrovata le carte diplomatiche sovietiche e neppure quelle della sorveglianza italiana a Formia) rilevi. Una qualche difficoltà di Togliatti, in quanto italiano, dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia all'URSS (giugno 1941, ma l'attacco alla Grecia è dell'ottobre precedente) credo fosse nell'ordine delle cose, e può spiegare qualche attenzione in più da parte sovietica. Si dovrebbe forse consultare sistematicamente le carte della Bloageva, se ancora presenti negli archivi, per capire quanto i commenti ostili furono presi sul serio.
Più significativa l'interpretazione delle presenza di Togliatti in Spagna. La letteratura sulla guerra civile spagnola è assai ampia, e io ne ho minima conoscenza, per cui mi è difficile esprimermi. La domanda a monte è quanto le modalità della presenza sovietica in Spagna furono motivate, da un certo momento in poi (se non da subito) dal riorientamento della politica estera sovietica al patto con la Germania nazista, e nel caso quanto Togliatti se ne fece portatore ed esecutore. Difficile valutare i commenti di Pons circa il (presunto?) orientamento di Togliatti (e di Dimitrov) a formulare una politica più antifascista che anticapitalista negli anni prima della guerra, tema che Pons espone intrecciato a quello delle diverse opinioni sulla inevitabilità della guerra stessa, tema quest'ultimo che io però direi in gran parte da trattare su un altro piano. La narrazione di Pons avrebbe beneficiato di una esposizione più esplicita sia del significato e plausibilità ideologica delle diverse posizioni possibilmente in campo, sia delle diverse possibili interpretazioni degli atti e delle parole di Togliatti, e inoltre anche di una analisi più completa dei documenti, che il taglia e cuci di brevi citazioni fuori contesto non aiuta (leggi comunque l'articolo di Togliatti sul significato delle rivoluzione spagnola qui). Nelle parole di Togliatti, Pons tende a leggerci una analisi differenziata, scevra da schematismi e prefigurazione delle (presunta) novità politiche nel secondo dopoguerra italiano, ma a me pare che, tolte le frasi di propaganda, Togliatti descriva la situazione come quella di una rivoluzione democratico-borghese non assimilabile al '17, e il sottotesto potrebbe quindi ben essere stato quello che non era detto valesse la pena compromettersi in Spagna più di tanto, un sottotesto del tutto compatibile con i tatticismi di Stalin.
Pons conclude il capitolo affermando che con "la guerra di Hitler a Est[si prefigura] la possibilità di un riscatto [per cui] le visioni, le analisi e le identità legate all’antifascismo costituivano una risorsa essenziale", chiusa io direi fin troppo generosa nei confronti di Togliatti, che più plausibilmente egli mi sembra debba invece essere ricordato per chi in modo convinto condivise modalità decisionali e scelte di fondo (e abilità tattiche) del gruppo dirigente staliniano come quelle che meglio potevano permettere il successo dell'URSS, e quindi del movimento comunista, nella competizione mondiale, e per questo del tutto giustificate, come appunto già nello scambio epistolare con Gramsci, nella stessa formulazione di Pons sopra citiata. - Ampia, ricca di dettagli, e con una tacita ma chiara attenzione alla storiografia anche più critica, è la narrazione della storia del PCI del secondo dopoguerra Influenze: internazionalismo e nazione (1943-1964. III. «Partito nuovo» e guerra fredda. Non potendo commentare la presentazione di ciascuno dei numerosi eventi ricordati da Pons, può forse essere sufficiente cogliere alcune conclusioni della sua ricostruzione. In effetti, la narrazione di Pons cerca un difficile equilibrio tra ii due poli, le ben note Scilla e Cariddi delle storia del PCI: le relazioni con l'URSS e quella che viene qui detta, con formulazione un poco ambigua, ``l’assunzione di una prospettiva legalitaria e parlamentare'' (io intendo che Pons attribuisca a Togliatti l'assunzione di una prospettiva di rispetto della democrazia pluralista, benché le espressioni non siano del tutto sinonime). Su modi, tempi, ruolo e idee del ritorno di Togliatti in Italia (e sulla svolta di Salerno), e poi anche in seguito, la sintesi di Pons è comunque che Togliatti ``mantenne una intesa a distanza con Stalin, risolutamente contrario ad azioni rivoluzionarie nei paesi sotto il controllo anglo-americano, che avrebbero potuto mettere a rischio la formazione della sfera d'influenza sovietica e i rapporti con le potenze alleate''. Su l'altro polo, la tesi principale mi sembra sia che ``a caratterizzare il progetto togliattiano [fu] più ancora che lo slogan di una «via italiana» al socialismo e la vaga idea della «democrazia progressiva», [il] carattere di massa [del partitto nuovo], rivolto a penetrare i diversi strati della società senza vigilare troppo la propria purezza ideologica''. Su il carattere di massa, la discussione credo debba essere più di storia sociale che di storia politica: la domanda del perché milioni di persone aderirono al PCI nel secondo dopoguerra non può essere risposta solo o sopratutto nei termini della scelta di un partito aperto e di massa. L'adesione fu il risultato dell'impatto emotivo del crollo statuale, dell'esperienza resistenziale e della violenza tedesca, e forse anche della difficile elaborazione della condizione di paese liberato e occupato allo stesso tempo dagli alleati; vi fu l'impatto delle migrazioni interne e della urbanizzazione di massa con il corollario della vita di fabbrica, e forse anche di una qualche serendipity delle precedenti mobilitazioni di massa fascista, e della forma mentis che in quelle si era in qualche modo formata. Analisi di questo tipologia, non facili ma imprenscindibili per capire, sono assenti dalla presentazione di Pons, con il rischio io credo di attribuire troppa efficacia al momento esplicitamente politico, e ai meriti di questa o quella strategia. Francamente, non credo che alcuna tra le figure apicali del PCI, per quanto purista, non sia stata ben contenta e rassicurata dall'ampio successo di adesioni. Il tema del partito di massa non credo sia derimente per una comprensione delle tensioni di fondo.
Il rapporto con l'URSS è ovviamente la vexata quaestio della storiografia del PCI, e si può formulare con una qualche variante di una domanda controfattuale, per esempio: cosa sarebbe stato dell'assunzione della `prospettiva legalitaria e parlamentare' se Togliatti si fosse trovato ad agire nelle condizioni di uno dei paesi di quella che in quegli anni diventò l'Europa dell'Est? Ovvero quanto quell'assunzione era di principio, o comunque emerse da un qualche articolato ripensamento ideologico, e non fu sopratutto solo tattica, per quanto con proiezione temporale indeterminata, nelle condizioni date dei rapporti di forza (militare, più che politica) date? Sicuramente Pons sa di simili obiezioni, e forse avrebbe dovuto discuterle con maggiore attenzione (per quanto sia sempre difficile discutere proposizioni controfattuali). Per esempio, Pons da ampio spazio al timore togliattiano di una prospettiva greca, con due sottointesi: che con quel timore Togliatti dimostrò la profonda sua adesione alla via parlamentare, e che dovette contrastare quella parte del Partito, non marginale, seriamente attratta da una avventura insurrezionalista. Ma la corrispondenza ai fatti storici di ambo quegli assunti non mi sembra cosìevidente. Per esempio chi tra i presunti legalitari e i presunti insurrezionalisti fu più simpatetico a un Gomulka, che una qualche forma di pluralismo cercò di mantenere nella Polonia del dopoguerra? O anche, mentre il frasario di un Kardelj, nel 1946-48, era certo del peggior estremismo, l'esperienza jugoslavia era fin dalla guerra piuttosto indipendente e perfino qualificabile come una `via nazionale' , e quind i presunti insurrezionalisti italiani, per quella via, non espressero di fatto una qualche autonomia nazionale forse più seria di quel si ammette? O anche, io non vedo tutta quella evidenza che un Secchia non si sia reso conto che sarebbe stato un suicidio un qualsiasi tentativo di colpo di mano, anche solo nel Nord-Est, anche perché, per quanto ingenuo, anche Secchia avrà capito da subito che le relazioni tra Mosca e Belgrado erano tendenzialmente conflittuali -Pons stesso cita, da un documento interno del 1945 credo da lui ritrovato, vedi, un Togliatti che già paventa un conflitto tra URSS e Jugoslavia. Il timore di avventure alla greca non credo fu una vera preoccupazione, e comunque dimostrerebbe in Togliatti solo una particolare attenzione alle cautele della stessa dirigenza sovietica, piuttosto che adesioni di principio alla via parlamentare. Tra le sicure omissioni di Pons quella di non ricordare il ruolo di un Vidali come segretario del Partito Comunista del Territorio Libero di Trieste, sicuramente di nomina moscovita, sicuramente su posizioni non secchiane ma piuttosto togliattiane, sicuramente una vicenda che mostra come vi fu anche una `fortunata' convergenza tra gli ambienti della difesa dell'italianità e interessi sovietici di egemonia del movimento comunista, in cui Togliatti poteva trovare facile gioco.
Pons si sofferma su molti episodi relativi alla vicenda del Cominform, dalle significative scelte delle delegazioni, al discorso `estremista' di Togliatti alla riunione del novembre 1949, ove ``Togliatti assunse consapevolmente la responsabilità di porsi in prima linea nell’internazionalismo staliniano della guerra fredda'' (ma per capire quel passaggio bisognerebbe forse sapere di più sulla veloce parabola di Andrej Ždanov, e di come allora la potè leggere Togliatti stesso). Pons enfatizza l'episodio della opposizione di Togliatti ad esser nominato alla guida del Cominforn (siamo nel 1951), che appare in effetti il primo dissenso esplicito di Togliatti con una preferenza di Stalin. Togliatti via da Roma, il partito in mano a Secchia e Longo, forse la storia del PCI sarebbe stata diversa, più primitiva e marginale, o forse solo più militante ma non per questo meno autonoma e creativa. E comunque le ragioni della contrarietà di Togliatti potrebbero essere state più prosaiche che la difesa di una idea di Partito nuovo, come suggerisce Pons. A Mosca intanto la rete di relazioni, anche protettive, di Togliatti degli anni '30 era dissolta- Dimitrov e la Blagoeva tornati finalmente in Bulgaria, Manuil'skij Ministro degli esteri fantoccio in Ucraina, la Stassova defilata- e poi sopratutto Togliatti vi avrebbe trovato uno Stalin con condizioni di salute in declino e tendenze definitivamente paranoidi. Anche senza scomodare le sue convinzioni politiche, Il carattere sempre e comunque cauto del dirigente italiano gli suggerì sicuramente di preferire la guida di un partito la cui base di militanti lo venerava come il `migliore' a una carica internazionale che tutti sapevano fittizia, e che infatti svanì senza notizia e rimpianti nel giro di pochi anni. Non si può escludere che Togliatti, per quanto stalinista, si avvide che si era al crepuscolo del dittatore, e si tenne lontano per evitare di essere coinvolto e travolto nella resa dei conti che poteva ben prevedere si sarebbe avuta da lì a poco. - Dove andò e/o cercò di andare il PCI dopo Stalin, fino alla morte di Togliatti? La sezione dedicata a quegli anni, IV. Policentrismo e decolonizzazione, si conclude con una apologia del memoriale di Yalta, riassunto con venature crepuscolari come la presa d'atto della crisi del mondo socialista: ``Il testamento politico di Togliatti [...] chiudeva un’intera epoca del comunismo, riconoscendo la crisi dell’interdipendenza stabilita sino allora tra la grande potenza dell’Unione Sovietica, la «superiorità» del suo sistema sociale, l’espansione politica e statuale del «campo socialista» e l’emergere del mondo postcoloniale.''. Mi sembra che Pons condivida la valutazione che molti dirigenti del PCI, e non solo Togliatti e la vecchia guardia, rimasero scettici su tutta l'esperienza di Chruščëv., e per alcuni aspetti del tutto contrariati, come dimostra la discussione nel PCI dopo il XXII Congresso del Pcus, che Pons correttamente ricorda, quando Togliatti bloccò ogni discussione su il destino degli italiani spariti nelle fucilazioni del 1937-38. (Con il senno di poi, risulta anche del tutto sorprendente che nessuno del PCI approfittò del viaggio di Chruščëv negli USA del 1959, per instaurare dei rapporti diretti con almeno qualche personalità USA, se non della politica, almeno in ambienti accademici, o sindacali.). Alcuni sparsi elementi che Pons cita qua e là fanno pensare che Togliatti abbia intuito da subito il via via crescente ruolo di Suslov, e si sia comportato di conseguenza, forse per quanto possibile perfino favorendolo, e sarebbe interessante raccogliere documentazione ulteriore per capire se così fu. Mentre le considerazioni di Togliatti nel memoriale testimoniano di una visione geopolitica ampia e articolata (ma forse non eterodossa, che si dovrebbe verificare cosa e come si discusse, magari anche con una certa libertà, nelle think tank sovietiche di allora), i fatti furono che comunque, ammesso anche avesse una aspirazione policentrica, Togliatti lasciò il partito di fatto schierato con Mosca nei principali dissidi, e né pensò che potesse essere possibile e/o desiderabile né agì per costituire un polo comunista a Roma, equidistante da Mosca, Belgrado e Pechino, ovvero emancipato dal rapporto preferenziale con Mosca.
- Infine, circa la terza parte finale Trasformazioni: il tramonto dell’internazionalismo (1964-1984), in cui Pons espone una cronaca ricca ma forse ancora da meditare storiograficamente, indico solo alcune passaggi che non mi convincono.
Pons scrive di Amendola: ``Amendola riteneva che il movimento comunista occidentale si trovasse in un vicolo cieco e che per questo fosse necessario il progetto di un nuovo partito del movimento operaio in chiave europea. Egli aveva però appreso la lezione di Togliatti contro il rischio di sopravvalutare l’esperienza italiana e manteneva fermo il legame con l’Unione Sovietica, limitandosi ad accentuare il giudizio sulla fine del suo modello universale13.''. La proposta di riunificarsi con i socialisti, o almeno con tutti quelli che non fossero dichiaratamente ostili, era stata già di Lenin, e su quella proposta Gramsci si emancipò da Bordiga; e poi si ritrova negli anni '30 in alcuni scritti di Egidio Gennari, dirigente dimenticato ma non secondario. Ed è complementare alla considerazione che in Occidente le cose non sarebbero andate come nel '17 russo, pure non estranea alle riflessioni di Lenin. Amendola si inseriva in una tradizione quindi piuttosto antica e costitutiva, anche se forse modulandola con propri toni moderati, e non vi era in essa una tensione tra prospettive contrapposte, o almeno non una che non fosse presente fin dagli anni '20.
Della segreteria Longo, di cui vedi il post di commento alle monografie di Höbel, Pons scrive: `` Longo seguí le principali coordinate impostate da Togliatti e sviluppò le reti di relazioni del PCI ma nella sua azione è difficile vedere le tessere di un progetto ispirato al policentrismo, che del resto non gli era stato congeniale neppure negli anni precedenti. L’effetto immediato, come appare anche dalle memorie di Carlo Galluzzi,[...] fu quello di un riavvicinamento ai sovietici, che tendeva a ricomporre il relativo distanziamento creato dal «memoriale» di Togliatti. A questo fine Longo incontrò Brežnev nel marzo 1966 al XXIII Congresso del Pcus''. In effetti la lettura del libro di Galluzzi mi lascia ben altra impressione. Il problema non è del tutto secondario, stante che si tratta di capire, per esempio sul lato italiano, il ruolo comunista nella mancata unificazione socialista e nel fallimento della presidenza Saragat.
Sicuramente interessante risulta la documentata cronologia dei viaggi e contatti internazionali del PCI e in particolare di Berlinguer, sia durante il triennio 1975-1977, a sostegno del tentativo di partecipare al governo italiano -un passaggio storico a cui Pons ha dedicato numerose pagine che meriteranno un post a parte-, sia per gli anni successivi, negli ultimi anni di vita di Berlinguer, dopo il fallimento del compromesso storico: Cina, Cuba, Algeria, Nicaragua, Jugoslavia. Di questi ultimi viaggi, a una prima lettura, sembra potersi dire - non so se leggo troppo nella scansione dei fatti presentata da Pons - che Berlinguer reagì al fallimento della partecipazione governativa in Italia, accentuando il distacco da Mosca (imputando a Suslov e Pomonariev di non averlo sostenuto contro Kissinger?), e cercando di costruirsi una presenza propria, anche oltre l'ipotesi eurocomunista, apparentemete nella speranza, velletaria?, di poter avere una risonanza internazionale allo stesso tempo ampia e autonoma.
Segnalo una curiosità. Secondo un documento interno: ``All’inizio del 1977, Berlinguer fu informato da Ceauşescu che Brežnev aveva esplicitamente invitato i leader dell’Europa orientale a adottare un orientamento intransigente e aggressivo [verso il PCI] , puntando ancora una volta il dito contro l’europeismo dei comunisti italiani ''. L'esistenza di questo canale di informazione Roma-Bucarest corrisponde alla ricostruzione di Stefano Santoro e ad alcuni ricordi di Galluzzi, ed era di fatto di lunga data, ma certo, con il senno di poi, evidenzia limiti profondi della cultura della dirigenza del PCI. - Un ultimo appunto, del tutto tranchant. Dopo una prima lettura, una impressione complessiva è che Pons sia più accondiscente con Togliatti che con Berlinguer. Mi sbaglio?

Indice
I comunisti italiani e gli altri
Visioni e legami internazionali nel mondo del Novecento

Introduzione
Nell’aprile 1951, al culmine della guerra fredda la Cia confezionò un dossier di documenti del Partito comunista d’Italia, risalenti al 1923 e requisiti all’epoca dalla polizia fascista1. I curatori presentavano quelle carte come una rara fonte sugli apparati e le attività illegali e cospirative comuniste, valida piú in generale ai fini di comprenderne modalità e pratiche anche dopo la Seconda guerra mondiale. Ai loro occhi, l’aspetto cruciale era la vastità delle reti documentate, che potevano suggerire qualcosa sulle metodologie investigative da impiegare per combattere la sfida dei “rivoluzionari di professione” nella guerra fredda. Non soltanto i comunisti italiani avevano creato in poco tempo, dopo la fondazione del partito, basi e connessioni a Parigi, a Berlino e in Svizzera. Gli indirizzi in possesso di un dirigente come Umberto Terracini, risultanti dalla documentazione, rimandavano infatti a una «organizzazione estera» molto piú ampia, che oltre a Mosca, Vienna, Praga e altre città europee includeva luoghi come New York, Buenos Aires, Melbourne, Il Cairo, Alessandria. In realtà, i funzionari dell’intelligence americana attribuivano ai comunisti italiani contatti che erano propri del Comintern, già divenuto nei primi anni Venti un’organizzazione dalle dimensioni mondiali. La loro osservazione coglieva però inconsapevolmente un elemento storico essenziale, sebbene fosse viziata da un’evidente psicosi della guerra fredda circa la minaccia rappresentata dalle diramazioni tentacolari del comunismo internazionale. Piú che costituire uno strumento valido per analizzare la «cospirazione» comunista a fini di political warfare, i documenti prodotti nei primi anni Venti da un partito comunista piccolo e perseguitato restituivano i lineamenti di un progetto globale. @
Il presente lavoro si propone di rileggere visioni, legami, protagonisti e momenti principali della storia del comunismo italiano in un’ottica internazionale. In altre parole, il comunismo italiano viene qui visto come un caso di studio nella storia globale del comunismo. È questa una prospettiva sempre piú adottata e discussa. Gli storici hanno esaminato, ad esempio, le ambizioni e le diramazioni del «partito della rivoluzione mondiale» tra le due guerre, i rapporti tra comunismo e movimenti di liberazione anticoloniale, le strategie sovietiche e cinesi nella guerra fredda globale e nel Terzo Mondo2. In un simile quadro innovativo, è rimasta in secondo piano la storia dei comunisti che non furono al potere e che pure costituirono il tassello essenziale di una presenza capillare e diffusa, in quanto combinavano i ruoli di attori nazionali e soggetti non governativi transnazionali. In particolare, l’inserimento del comunismo occidentale nella storia globale del comunismo implica la ricostruzione di molteplici contesti relazionali e temporali, che si estendono a temi quali le concezioni e le pratiche dell’internazionalismo, l’immaginario e la formazione dei militanti e dei dirigenti, le reti stabilite non soltanto in Europa, ma nel mondo coloniale e postcoloniale. Si è detto che gli storici del comunismo avrebbero praticato una storia transnazionale senza saperlo, data la natura stessa del soggetto. È probabilmente vero in alcuni casi. Tuttavia, il dato di fatto è che essi hanno per lo piú trattato quella storia senza assumere davvero una simile prospettiva fino ad anni recenti3.
Il volume ricostruisce un aspetto ben delimitato tra i possibili approcci alla multidimensionalità delle relazioni globali: la cultura politica espressa da personalità e gruppi dirigenti nelle loro visioni dell’ordine europeo e mondiale, nella costruzione di senso dei nessi tra identità nazionali e appartenenze internazionali, nell’approccio ai temi della pace e della guerra. Sotto questo profilo, porre il fuoco sulle élite politiche appare inevitabile. Non soltanto le questioni politiche internazionali sono state nel secolo scorso (e restano anche ai nostri giorni) appannaggio di gruppi ristretti, ma la coscienza stessa del globale è emersa con discontinuità e prevalentemente nell’ambito di élite internazionalizzate per diversi motivi economici, culturali o politici. Nello stesso tempo, il movimento comunista coltivò una costante vocazione pedagogica e sperimentò una osmosi tra il discorso politico dei gruppi dirigenti e l’acculturazione dei militanti. Sotto questa luce, appare inadeguata la contrapposizione tra il sentire dei militanti e le strategie dei leader talvolta impiegata negli studi. Gli stessi miti sovietici della rivoluzione mondiale, del socialismo realizzato e della «potenza pacifica», che furono componente essenziale della cultura internazionalista dei comunisti, si diffusero tra i dirigenti, gli intellettuali o i semplici militanti in forme molto simili, anche se con diversi gradi di consapevolezza.
Come molti altri dirigenti e militanti, i comunisti italiani videro nell’internazionalismo parte essenziale della propria ragion d’essere. Si formarono tra le due guerre praticando gli ambienti del Comintern, anzitutto a Mosca e, in una misura minore, in altre capitali europee. Nella Mosca degli anni Venti fecero un tratto piú o meno decisivo del loro apprendistato politico Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Angelo Tasca, Amadeo Bordiga, Ruggero Grieco, Mauro Scoccimarro, Camilla Ravera, Teresa Noce, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giuseppe Berti. Intrecciarono contatti e rapporti con i leader bolscevichi e con gli emissari del Comintern, che erano parte di una fitta rete transnazionale. L’esperienza dell’esilio iniziò per gli italiani molto presto, a Parigi e a Mosca, dove ai dirigenti si aggiunse un numero cospicuo di militanti fuoriusciti. Togliatti divenne allora un alto dirigente del Comintern e fu plenipotenziario nella guerra di Spagna, che costituí un capitolo cruciale per “rivoluzionari di professione” quali Longo, Vittorio Vidali, Velio Spano, Antonio Roasio e molti altri, come per semplici militanti. Dopo la Seconda guerra mondiale, sotto la leadership di Togliatti, la generazione internazionalista degli anni Venti si integrò con quelle emerse nella militanza antifascista e poi nella Resistenza. I loro esponenti furono, tra gli altri, Giorgio Amendola, Giancarlo Pajetta, Emilio Sereni, Celeste Negarville, Eugenio Reale, Pietro Ingrao, Paolo Bufalini, Mario Alicata, Armando Cossutta, Enrico Berlinguer, Giorgio Napolitano, Alessandro Natta. L’internazionalismo comunista conobbe una continuità tramite le relazioni privilegiate intrattenute con il mondo socialista e antimperialista in espansione grazie alle trasformazioni generate dalla guerra. La storia di questi rapporti e intrecci è stata spesso ridotta a un dato secondario oppure a mera evidenza di una «doppiezza» costitutiva, da entrambi i punti di vista impiegando la nazione come parametro esclusivo di giudizio. In realtà, tale storia fu parte di un progetto globale, che costituí una fonte identitaria, un tessuto connettivo e la stella polare di una visione del mondo incentrata sull’idea della politica come forza demiurgica4.
A differenza dei comunisti francesi, con i quali furono in stretto contatto negli anni dell’esilio, gli italiani non si inserirono in quel progetto tramite il vettore di una grande potenza europea e di una metropoli imperiale5. Sperimentarono la semilegalità, la clandestinità, l’emigrazione e la prigione in un paese precipitato nella dittatura fascista negli anni tumultuosi del primo dopoguerra del secolo. Il loro profilo nel Comintern fu minore e periferico tra le due guerre, sebbene il fatto di avere vissuto e analizzato il laboratorio del fascismo in Italia fornisse un credito politico non indifferente. Il gruppo dirigente originario si dissolse a causa sia della repressione fascista sia della stalinizzazione del Comintern. In questo senso, i comunisti italiani subirono una sorte lacerante, piú ancora di altri, con la differenza che il loro leader riconosciuto restò un esponente del gruppo originario: Togliatti. La disgregazione e lo sradicamento raggiunsero il culmine negli anni tra il Grande Terrore e il Patto tra Stalin e Hitler, anche se proprio le condizioni di marginalità sperimentate da tempo evitarono ai dirigenti italiani (ma non alla comunità degli emigranti in Unione Sovietica) le conseguenze piú devastanti che colpirono altri partiti. Il ruolo internazionale del comunismo italiano divenne rilevante soltanto dopo la guerra, grazie all’influenza di massa acquisita in un paese strategico dell’Europa nel mondo bipolare. Fu allora che i comunisti italiani si ritagliarono un posto importante nel progetto globale comunista, dando vita al principale partito comunista occidentale.
Essere comunisti significò per gli italiani, come per tanti altri, aderire a un progetto politico e compiere insieme una scelta esistenziale, a partire da una critica radicale dell’esistente. I legami con l’Unione Sovietica furono costitutivi di quella stessa identità. La fede nel modello di civiltà sovietico come realizzazione di una società giusta e il conseguente principio di lealtà verso lo Stato socialista alimentarono alle origini il carattere del settarismo, divennero un elemento di forza durante la Seconda guerra mondiale, furono un potente vettore di influenze e insuccessi nella guerra fredda, per costituire infine il classico tallone d’Achille. Tuttavia, i comunisti italiani non ricalcarono sempre l’arsenale ideologico e politico forgiato dagli stati maggiori del comunismo internazionale, i suoi assiomi marxisti e il suo perimetro alternativo alla globalizzazione occidentale. Si proposero a piú riprese come la coscienza critica di una «comunità immaginata» su scala mondiale. La loro peculiarità principale fu la spiccata vocazione intellettuale di gran parte dei dirigenti, molto forte alle origini e mantenuta anche nei ricambi generazionali. Tale qualità fu riconosciuta e apprezzata non soltanto da Lenin, Trockij o Gorbačëv, ma anche da figure quali, ad esempio, Willy Brandt, Léopold Senghor o Deng Xiaoping, oltre che da molti intellettuali occidentali e del Terzo Mondo. Si costruirono cosí la fama di una voce fuori dal coro nel loro modo di essere nazionali e antifascisti, che ne alimentò l’autorità, e nella capacità di costruire reti di relazioni oltre i confini di quella comunità, che li portava a intersecare altre idee e culture internazionaliste. Le coordinate della loro cultura politica conobbero contraddizioni, mutilazioni, conflitti e discontinuità, a dispetto delle autonarrazioni. Tali dinamiche si intrecciarono in un modo indissolubile con l’ascesa e la caduta del comunismo internazionale, non meno che con le vicende nazionali, fino alla metamorfosi terminale del 1989.
Un osservatore empatico e partecipe come Eric J. Hobsbawm, assiduo frequentatore dell’Italia e degli ambienti della sinistra italiana dagli anni Cinquanta in avanti, vedeva i comunisti e gli antifascisti come i protagonisti di una reazione al senso di marginalità culturale e politica del paese che il fascismo aveva aggravato6. L’ambizione di una trasformazione socialista dell’Italia doveva restare nel libro dei sogni. A torto o a ragione, tuttavia, i gruppi dirigenti comunisti si pensarono eredi di una tradizione cosmopolita inserita in una lunga storia italiana, da adattare alle condizioni ideologiche e globali del XX secolo. Essi fecero propria, piú o meno consapevolmente, l’idea annotata da Gramsci in carcere:
Il cosmopolitismo italiano non può non diventare internazionalismo. Non il cittadino del mondo, in quanto civis romanus o cattolico, ma in quanto lavoratore e produttore di civiltà. Perciò si può sostenere che la tradizione italiana dialetticamente si continua nel popolo lavoratore e nei suoi intellettuali, non nel cittadino tradizionale e nell’intellettuale tradizionale. Il popolo italiano è quello che «nazionalmente» è piú interessato all’internazionalismo […]. Il nazionalismo è una escrescenza anacronistica nella storia italiana, di gente che ha la testa volta all’indietro come i dannati di Dante7.
La relazione stabilita da Gramsci tra cosmopolitismo e internazionalismo poté circolare solo postuma, dopo la pubblicazione dei Quaderni del carcere, quando entrambe le nozioni avevano subito un impoverimento dei loro significati, nel pieno della guerra fredda e dello stalinismo. I comunisti restavano però legati, piú di ogni altra cultura politica italiana, a un progetto portatore di influenze, dimensioni e connessioni globali. Le conseguenze furono molto controverse. La primogenitura dell’internazionalismo comunista lasciò il segno sui caratteri originari della Repubblica, spingendo gli avversari politici a dotarsi di relazioni e disegni internazionali competitivi, integrati nel nascente mondo occidentale. L’internazionalizzazione del paese plasmò e cristallizzò fratture profonde e durature della nazione, che imposero la persistenza di blocchi sociali e politici antagonisti e richiesero una costante opera di self-containment esercitata dai leader e dai gruppi dirigenti di entrambe le parti. Tuttavia, Togliatti e i suoi successori si inserirono nel solco di un interesse specifico italiano per l’internazionalismo senza aggettivi, che divenne l’altra faccia della funzione di una integrazione delle masse nella società e nello Stato. Protagonisti di una «guerra di posizione» in Occidente, nel corso del tempo essi si proposero anche come interpreti e mediatori tra il loro paese e le parti del mondo socialiste e antimperialiste. Allacciarono legami con le costellazioni rivoluzionarie dell’universo novecentesco, fecero da catalizzatori delle critiche ai modelli di sviluppo e di consumo occidentali, svolsero funzioni di raccordo oltre le linee di frattura in Europa e nel Mediterraneo. Crearono per alcuni decenni una comunità tra élite politiche, intellettuali e popolo, fondata su visioni del mondo che erano variamente condizionate da mitologie, ma rimandavano anche alla coscienza di realtà piú grandi e sovraordinanti nelle quali inserire l’identità nazionale e i suoi mutamenti.
All’indomani della guerra, l’antifascismo italiano contribuí a liquidare i veleni del nazionalismo e a immaginare un paese piú inserito nelle interdipendenze mondiali rispetto al passato. I comunisti paventarono la nascita dei blocchi internazionali, che Togliatti vedeva a ragione come uno scenario sfavorevole alle proprie ambizioni egemoniche. Furono Alcide De Gasperi e la Dc a compiere le scelte fondamentali per la collocazione internazionale dell’Italia, tramite l’adozione del Piano Marshall, l’adesione all’Alleanza atlantica e la partecipazione alla Comunità Europea. Questo passaggio stabilí l’egemonia delle forze filoccidentali. Il contributo fondamentale di Togliatti fu di evitare una guerra civile italiana, lasciando aperto lo scenario della presenza comunista in un contesto legalitario e parlamentare. L’esempio italiano del partito di massa presentò inoltre implicazioni e lezioni per il movimento comunista, specie dopo la morte di Stalin. La condizione di minorità dei comunisti nella politica nazionale doveva rivelarsi un dato di lungo periodo. Ciò nonostante, le loro visioni volte a riconoscere la portata mondiale della decolonizzazione, con l’emergere di nuovi soggetti fuori dagli schemi binari della guerra fredda, giocarono influenze significative in alcuni momenti. In particolare, essi contribuirono sensibilmente a sollecitare gli orientamenti dell’Italia verso la distensione internazionale e verso il Mediterraneo postcoloniale, costruendo legami con i protagonisti del non allineamento e con vari movimenti di liberazione nel Terzo Mondo.
Piú tardi, sotto la leadership di Berlinguer, seguirono l’ispirazione del socialismo umanistico della «primavera di Praga», rovesciarono la loro opposizione all’integrazione europea e vi aderirono tramite l’idea dell’Europa come nuovo soggetto della politica mondiale. Cosí abbandonarono gradualmente il vecchio internazionalismo, entrando in conflitto con gran parte del loro stesso mondo di appartenenza, e lo riformularono nella visione di un ruolo globale dell’Europa e dei rapporti tra Nord e Sud del mondo, quali orizzonti di senso e agende politiche nel declino dell’ordine bipolare. Tale evoluzione fu parte essenziale del loro consenso nazionale nell’Italia degli anni Settanta. Dopo il fallimento del disegno di accedere alla sfera di governo e creare un’alleanza comunista occidentale, difesero le loro acquisizioni in termini di cultura politica. Il comunismo riformatore italiano si incontrò con il progetto di Gorbačëv e rappresentò uno dei suoi principali interlocutori fino alla fine. L’eredità nazionale di quella cultura politica, specie sotto l’aspetto dell’europeismo, doveva essere tutt’altro che irrilevante, anche dopo la fine della guerra fredda e del comunismo.
In questa luce si vedono bene i caratteri, gli apporti e le aporie della parabola del comunismo italiano. Gran parte dei comunisti in Europa e nel mondo si adoperarono nella loro storia, in modi diversi, per tradurre nazionalmente il loro internazionalismo. Sotto questo profilo, quella italiana fu tra le esperienze di maggior successo, anche su una scala globale. I comunisti italiani sostennero una tensione permanente tra il legame con la propria tradizione incardinata in un progetto alternativo all’internazionalismo liberale, da una parte, e la legittimazione nella nazione politica, vista come la necessaria integrazione di quel progetto, dall’altra. In un’altra ottica, una tensione altrettanto forte si manifestò tra l’appartenenza al mondo socialista, declinata in forme plurali dinanzi alla nascita del mondo postcoloniale, e l’idea di un eccezionalismo italiano, soprattutto legata alle identità cattolica e comunista nella vita del paese. Con il declino del socialismo sovietico, quella tensione si riprodusse tra l’idea di un’europeizzazione, basata sulla prospettiva di un’Europa politica e su una nuova gerarchia valoriale democratica, e la rivendicazione di una diversità identitaria dalle culture politiche riformiste e socialdemocratiche del continente, rivolta a tenere aperta la prospettiva di una trasformazione radicale della società.
Le visioni e i legami dei comunisti italiani seguirono cosí i cambiamenti del secolo e si contaminarono con altri linguaggi e culture, soprattutto quando dovettero fronteggiare il tramonto precoce del progetto globale comunista. Essi mantennero una visione del mondo su basi classiste, immaginandone l’unificazione nel segno del socialismo e del marxismo, ma seppero vedere dinamiche autonome, interdipendenze mondiali, destini comuni dell’umanità. Nemici della democrazia liberale e fautori della «dittatura proletaria» alle origini, parteciparono alla Costituzione repubblicana, pensarono la democrazia di massa, divennero poi difensori dello Stato democratico. Avversarono gli Stati Uniti e l’americanismo ma si adattarono seppure con riluttanza alla società dei consumi, costruirono mitologie sul socialismo sovietico e contribuirono alla successiva delegittimazione del suo modello, criticarono ferocemente il riformismo e furono riformatori nelle loro esperienze di governo. La capacità di cambiare sé stessi fu forse il loro tratto piú rilevante. Tale capacità non si spinse oltre i confini dell’identità comunista prima del crollo del Muro di Berlino, non si emancipò mai completamente dal legame esistenziale con il socialismo sovietico e scontò sempre la difficoltà culturale di comprendere motivi e vettori del «secolo americano». Tuttavia, i comunisti italiani furono parte attiva nel ridefinire la missione internazionalista originaria, contribuendo alla metamorfosi finale della principale tradizione rivoluzionaria del secolo scorso.
L’approccio proposto nel libro porta a tenere in conto storiografie diverse, non sempre dialoganti con gli studi sul comunismo. In particolare, le tendenze a rileggere la storia dell’internazionalismo e del cosmopolitismo nell’ottica inclusiva delle visioni di sovranità, comunità, identità emerse in molteplici ambienti intellettuali, politici e nazionali8. E nello stesso tempo, anche le tendenze a rileggere la storia d’Italia in una chiave volta a valorizzare i suoi fattori e aspetti internazionali, inserendola in contesti globali, transnazionali e interdipendenti inadeguatamente esplorati e considerati in passato9. La storia del comunismo è stata spesso ridotta a un’anomalia, nella storia mondiale come in quella italiana. In realtà, le agende globali del comunismo interagirono a lungo con i principali cambiamenti, conflitti e opzioni del secolo scorso, anche se finirono per soccombere in un groviglio di contraddizioni e antinomie. L’esaurimento del progetto rivoluzionario nato nel 1917 e il fallimento della sua predominante dimensione statalista contribuirono in modo decisivo a liquidare la fede nella politica che aveva animato le menti e i cuori di milioni di persone. Il comunismo ne fu la manifestazione piú estrema, fonte di trasformazioni e tragedie immani, di lotte per l’emancipazione e repressione delle libertà, di speranze nel futuro e profonde disillusioni. Cosí finí per alimentare suo malgrado, come modello negativo, le conseguenze piú dirompenti di una trasformazione profonda nei rapporti tra collettività e individuo avvenuta alla fine del secolo scorso.
Oggi possiamo però vedere come la fine dell’internazionalismo comunista non sia stata un episodio a sé stante. Fu anche il preludio alla crisi profonda di tutti gli internazionalismi emersa nel nuovo secolo, che ha dissolto le illusioni di una facile espansione delle concezioni occidentali dopo il collasso dell’Unione Sovietica. Il nostro tempo conosce uno sviluppo senza precedenti di soggetti, fenomeni e network transnazionali che mettono in questione il ruolo degli Stati. La proliferazione delle istituzioni internazionali ha tuttavia riprodotto l’intreccio e le tensioni secolari con la sovranità nazionale, senza offrire risposte efficaci alle principali sfide globali. In un mondo privo di un ordine egemonico, soggetto a shock e fratture di varia natura, percorso da tendenze neonazionaliste e fondamentaliste, sembra manifestarsi il tramonto di un elemento essenziale della modernità politica: la visione della politica come sfera di attività autonoma e trasformatrice, destinata a svolgersi nell’interazione e compenetrazione tra spazi nazionali e dimensione internazionale. Non sappiamo se le diverse versioni dell’internazionalismo del secolo scorso debbano considerarsi estinte, mentre il mondo transnazionale stenta a emergere. Tuttavia la loro eredità culturale non dovrebbe essere data per finita troppo frettolosamente. Forse può ancora rappresentare una lezione da apprendere in un tempo che vede molti volgere la testa all’indietro, «come i dannati di Dante».
Questo libro è il frutto di un lavoro accumulato nel tempo ma finalizzato nel momento dell’emergenza pandemica che ha colpito l’Italia e il mondo nel 2020. La particolare difficoltà delle condizioni di lavoro ha aumentato ancor piú il mio debito verso numerose persone, fermo restando che il contenuto del libro è esclusivamente una mia responsabilità. Anzitutto sono in debito verso Giovanna Bosman, Dario Massimi e Cristiana Pipitone per il loro aiuto permanente nell’Archivio e nella Biblioteca della Fondazione Gramsci. Debbo un particolare ringraziamento a Gregorio Sorgonà, per il suo competente supporto e la costante disponibilità. In vari momenti e fino alla fine mi ha assistito con scrupolo e lucidità Francesco Giasi. Ho molto beneficiato dei commenti, consigli e apporti di Leonardo Pompeo D’Alessandro, Michele Di Donato, Gianluca Fiocco, Bruno Settis, Molly Tambor. Ho ricevuto suggerimenti utili e puntuali da Paolo Capuzzo, Alessio Gagliardi, Giovanni Gozzini, Nicola Labanca, Sante Lesti. Sono grato a Michele Ciliberto e a Giuseppe Vacca per le loro riflessioni critiche. La mia gratitudine deve estendersi anche a molti altri studiosi e amici che in anni piú o meno recenti hanno stimolato, arricchito e favorito le mie esperienze. Tra questi, vorrei ricordare David Bidussa, Victoria de Grazia, Mario Del Pero, Juliane Fürst, Francesca Gori, Andrea Graziosi, Jonathan Haslam, Mark Mazower, Norman Naimark, Sophie Quinn-Judge, Federico Romero, Mark Selden, Stephen A. Smith, Andrej Sorokin, Antonio Varsori, Arne Westad, Vladislav Zubok. Infine, questo libro non sarebbe stato possibile senza la presenza di Chiara.
Roma, novembre 2020
Elenco delle abbreviazioni
| Apci | Archivio del Partito comunista italiano |
| Avprf | Archiv Vnešnej Politiki Rossijskoj Federacii (Archivio della politica estera della Federazione russa) |
| Cc | Comitato centrale |
| Cee | Comunità economica europea |
| Cgil | Confederazione generale italiana del lavoro |
| Cia | Central Intelligence Agency |
| Cln | Comitato di liberazione nazionale |
| Comecon | Consiglio per la mutua assistenza economica |
| Cominform | Informacionnoe bjuro kommunističeskich i rabočich partij (Ufficio di informazione dei partiti comunisti e operai) |
| Comintern | Kommunističeskij Internacional (Internazionale comunista) |
| Crest | Cia Records Search Tool |
| Dc | Democrazia cristiana |
| Ddr | Deutsche Demokratische Republik (Repubblica democratica tedesca) |
| FG | Fondazione Gramsci, Roma |
| Fln | Front de Libération Nationale (Fronte di liberazione nazionale, Algeria) |
| Frelimo | Frente de Libertação de Moçambique (Fronte di liberazione del Mozambico) |
| Gulag | Glavnoe upravlenie lagerej (Amministrazione centrale dei campi) |
| Ikki | Ispołnitełnyj komitet kommunističeskogo Internacionala (Comitato esecutivo dell’Internazionale comunista) |
| Kgb | Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (Comitato per la sicurezza dello Stato) |
| Kpd | Kommunistische Partei Deutschlands (Partito comunista tedesco) |
| Nara | National Archives Records Administration |
| Nato | North Atlantic Treaty Organization |
| Nep | Novaja ekonomičeskaja politika (Nuova politica economica) |
| Nkvd | Narodnyj komissariat vnutrennich del (Commissariato del popolo per gli affari interni) |
| Olp | Organizzazione per la liberazione della Palestina |
| Onu | Organizzazione delle Nazioni Unite |
| Pcc | Partito comunista cinese |
| Pcd’I | Partito comunista d’Italia |
| Pcf | Parti communiste français |
| Pci | Partito comunista italiano |
| Pcp | Partido comunista português |
| Pcus | Partito comunista dell’Unione Sovietica |
| Pds | Partito democratico della sinistra |
| Politbjuro | Političeskoe bjuro (Ufficio politico) |
| Poum | Partido obrero de unificación marxista |
| Psi | Partito socialista italiano |
| Rdt | vedi Ddr |
| Rft | Repubblica federale tedesca |
| Rgani | Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Novejšej Istorii (Archivio di Stato russo per la storia contemporanea) |
| Rgaspi | Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Social’no-Političeskoj Istorii (Archivio di Stato russo per la storia politica e sociale) |
| Rkp(b) | Rossijskaja Kommunističeskaja Partija (bol’ševikov) (Partito comunista russo [bolscevico]) |
| Seato | Southeast Asia Treaty Organization (Organizzazione del trattato per l’Asia sudorientale) |
| Sed | Socialistische Einheitspartei Deutschlands (Partito socialista unitario di Germania) |
| Spd | Sozial-Demokratische Partei Deutschlands (Partito socialdemocratico di Germania) |
| Urss | Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche |
| Vkp(b) | Vsesojuznaja Kommunističeskaja Partija (bol’ševikov) (Partito comunista dell’Unione [bolscevico]) |
I comunisti italiani e gli altri
per il piccolo Leonardo
PARTE PRIMA
Genealogie: internazionalismo e cosmopolitismo (1917-1941)
Capitolo primo
Rivoluzione ed egemonia
1. Lenin, Wilson e l’ordine mondiale conteso.
L’internazionalismo comunista è stato spesso visto come una conseguenza del disegno leniniano di fondare la Terza Internazionale, dopo la dissoluzione della Seconda, concepito sin da prima della Rivoluzione d’ottobre e messo in atto poco piú di un anno dopo. Si è cosí ricostruita la sua genesi mettendo a fuoco l’azione dei gruppi politici, anzitutto i bolscevichi, che durante la guerra si riunivano in Svizzera per testimoniare il loro rigetto del nazionalismo, l’opposizione alla guerra e la condanna del revisionismo socialista. Tuttavia, molti giovani intellettuali, dirigenti o militanti coinvolti nella politicizzazione di massa della Grande guerra, in Europa come nel mondo coloniale, percepirono autonomamente il senso della dimensione internazionale come spazio progettuale e identitario ineluttabile, intrecciato con la dimensione nazionale. I loro contesti pratici e immaginati presentavano le piú diverse radici, molto oltre i confini ideologici e politici del marxismo e del socialismo anteguerra. La congiuntura della guerra generò ovunque un rivolgimento nei modi di pensare i vettori e le comunità internazionali nel loro rapporto con gli imperi, l’autodeterminazione nazionale e lo Stato-nazione, su una scala paneuropea e globale. Il disegno leniniano di una nuova Internazionale doveva offrire una casa comune e irreggimentare una simile multiformità di radicalismi eterogenei soltanto ben dopo la fine della guerra1. In questa luce dovremmo vedere anche le principali personalità destinate a fondare il Partito comunista d’Italia (Pcd’I), Antonio Gramsci a Torino e Amadeo Bordiga a Napoli. Tale ottica appare essenziale al fine di comprendere meglio alcuni caratteri originali della cultura politica comunista in Italia, destinati a modellarsi, trasformarsi o persistere dopo l’incontro autentico con il bolscevismo.
I commenti di Gramsci e di Bordiga alle rivoluzioni russe del 1917 rivelavano una conoscenza molto limitata e approssimativa del bolscevismo e il tentativo di leggere gli eventi alla luce delle rispettive idee circa le conseguenze della Grande guerra. Gramsci si concentrò sul tema della coscienza di massa e della nascita di una nuova soggettività politica, Bordiga invece sulle antinomie tra socialismo e nazione e tra socialismo e democrazia. In entrambi i casi emergeva una tensione generazionale, una frattura con la tradizione della Seconda Internazionale e un’insofferenza per il provincialismo del socialismo italiano. Qui si fermavano le analogie e iniziavano le differenze, anzitutto perché, come ha classicamente osservato Giuseppe Berti, li divideva la prospettiva di ripristinare un marxismo ortodosso, fatta propria da Bordiga ed estranea a Gramsci2. Alla luce degli studi piú recenti, appare persino fuorviante compiere un parallelo tra le due personalità, dato il posizionamento unico di Gramsci nel dibattito socialista dell’epoca3. Tale singolarità appare soprattutto evidente nel modo di affrontare la politica mondiale e il tema dell’internazionalismo. Il celebre articolo La rivoluzione contro «Il Capitale», scritto poco dopo la Rivoluzione d’ottobre, costituisce un tassello decisivo per la ricostruzione del suo pensiero politico e, nello stesso tempo, per illuminare la percezione diffusa delle ragioni di Lenin contro il marxismo evoluzionista e circa le potenzialità trasformative della politica. «I fatti hanno fatto scoppiare gli schemi critici entro i quali la storia della Russia avrebbe dovuto svolgersi secondo i canoni del materialismo storico. I bolsceviki rinnegano Carlo Marx, e affermano, con la testimonianza dell’azione esplicita, delle conquiste realizzate, che i canoni del materialismo storico non sono cosí ferrei come si potrebbe pensare e si è pensato», scriveva Gramsci. E ancora, «Marx ha preveduto il prevedibile […] non poteva prevedere la guerra europea, o meglio non poteva prevedere che questa guerra avrebbe avuto la durata e gli effetti che ha avuto»4.
Una simile sensibilità antideterministica distingueva sin da allora Gramsci da Bordiga. Questi polemizzò con Gramsci per i suoi argomenti «idealistici» ed elogiò i bolscevichi per essersi staccati da Marx e Engels, ma a proposito dell’«importanza eccessiva» da essi attribuita alla democrazia5. La linea di pensiero che invece li accomunava era l’idea della «dittatura proletaria» come fattore di ordine rivoluzionario in una società devastata dalla guerra. Tutti i seguaci del bolscevismo aderirono alla separazione tra socialismo e democrazia operata da Lenin e dai bolscevichi, basata sul presupposto che la dittatura costituisse un passaggio necessario e una condizione transitoria e che la democrazia liberale non fornisse risposte adeguate al terremoto sociale e alla politica di massa generati dalla guerra. Anche se con un linguaggio molto particolare, Gramsci manifestava un pensiero condiviso, e insieme una prima costruzione mitologica, quando sostenne che i Soviet e il partito bolscevico fossero gli «organismi» integrati del nuovo ordine, capaci di ribaltare gerarchie e rifondarle su una «autorità spirituale», fonte di socializzazione e di una cittadinanza responsabile. «La dittatura», scriveva nel luglio 1918, «è l’istituto fondamentale che garantisce la libertà […]. Non è un metodo da perpetuare, ma permette di creare e solidificare gli organismi permanenti in cui la dittatura si dissolverà, dopo aver compiuto la sua missione»6.
Tuttavia, le prime reazioni indotte dalle notizie sull’Ottobre 1917 non configuravano ancora una precisa visione internazionalista. Furono i 14 punti di Wilson a sollecitare visioni piú definite, in quanto rappresentavano una risposta ideale e politica a Lenin. La polemica attorno alla figura del presidente americano si era già ampiamente sviluppata tra i socialisti, dividendo i riformisti filowilsoniani come Turati e Treves dai critici radicali, tra i quali Bordiga. Fu attorno a questo tema che Gramsci si distinse da tutti. Egli vide meglio la portata mondiale della sfida e usò le armi affilate della propria critica al fine di arginare la fortuna del wilsonismo nel mondo socialista, che stava creando un vero e proprio culto. Con toni profetici, definí Wilson come il «trionfatore della pace» ma ritenendo che «il riconoscimento dell’utilità storica dei massimalisti russi» sarebbe stato «immancabile» perché a essi «la storia riserva un posto di prim’ordine, superiore a quello dei giacobini francesi di quanto il socialismo è superiore alle ideologie borghesi»7. Era trasparente il rigetto integrale dell’esperienza politica europea dell’anteguerra, che coinvolgeva i gruppi dirigenti socialisti, ma soprattutto la proiezione verso una nuova scena mondiale contesa tra protagonisti radicalmente diversi dal passato («Lenin e Wilson sono i due geni politici che la guerra ha messo in prima linea, sulla persona e sull’opera dei quali si fissa l’attenzione della miglior parte rispettivamente del proletariato e della borghesia del mondo»)8. Gramsci si faceva interprete di sentimenti diffusi nell’opinione politica europea e percepiva il dualismo tra due visioni opposte dell’ordine postbellico, ma entrambe innovative, che rapidamente si propagavano su scala globale, implicando un’alternativa tra la pace tramite la rivoluzione socialista e la pace tramite la democrazia liberale. La sua visione di Wilson era quella di una figura progressiva non per motivi ideali, ma perché legata al nuovo vettore mondiale rappresentato dalla potenza americana9.
Il momento internazionalista giunse alla fine della guerra, quando collassarono gli imperi nell’Europa centro-orientale. Le agitazioni sociali e la diffusione dei consigli di fabbrica in Germania costituirono il passaggio decisivo, insieme all’eco dell’intervento anglo-francese nella guerra civile russa in appoggio alla controrivoluzione bianca. Tra la fine del 1918 e l’inizio del 1919, si generalizzò la convinzione di una possibile ondata di sconvolgimenti rivoluzionari, che suscitava speranze e paure. Il crollo del vecchio ordine europeo era una realtà, non un’immaginazione. L’idea che la rivoluzione sociale in Europa e l’autogoverno dei lavoratori fossero piú attuali della costruzione di Stati democratici corrispondeva a percezioni diffuse. La replica di quanto accaduto in Russia un anno prima costituí uno scenario credibile sia per le forze di governo sia per le avanguardie rivoluzionarie, che ricrearono nel cuore dell’Europa l’opposizione tra l’Assemblea costituente e la «dittatura del proletariato». La repressione del movimento spartachista nel gennaio 1919 fu un’azione preventiva del governo Ebert, nata dalla paura di perdere il controllo della situazione e destinata a incentivare la militarizzazione e l’ideologizzazione del conflitto sociale10. L’identificazione nella causa rivoluzionaria in Russia o in Germania e in Ungheria recava la motivazione di avere un riferimento internazionale sinora mancato ai gruppi politici impegnati, in Italia come altrove, nella contestazione delle leadership socialiste. Tuttavia la questione era molto piú radicale e investiva le basi esistenziali della politica. Si trattava di una professione di fede che rivelava come la rivoluzione russa generasse soprattutto tra i giovani dell’epoca un immaginario costitutivo di orientamenti, passioni, identità. Le narrazioni sulla rivoluzione russa ebbero un rapido impatto divisivo sull’universo socialista del vecchio continente e presero altrove l’aspetto di mediazioni culturali e politiche transnazionali, dal Medio Oriente all’Asia centrale, dalla Cina all’America Latina. Gramsci approfondí la lettura ideale della Repubblica dei Soviet come uno «Stato organico» e un fattore di ordine nel caos dell’ex impero russo. A suo modo di vedere, l’originario impianto dei consigli dava vita a una struttura solida e complessa che nella congiuntura storica della guerra civile si affermava tramite la forza dell’Armata rossa, ma prefigurava anche una statualità proletaria nascente11.
Tanto «L’Ordine Nuovo» a Torino quanto «Il Soviet» a Napoli manifestarono aspettative per la nascita di un nuovo internazionalismo. Diverse furono però le letture dell’ordine internazionale e le valutazioni di una figura centrale come Wilson. Al momento del trionfale viaggio in Europa del presidente americano, accolto da folle oceaniche a Roma, Parigi e Londra, Gramsci osservò che questi era «il centro di un incanto sociale, che lo ha innalzato al culmine di una gerarchia di prestigio democratico che opera non solo nei paesi alleati, ma anche nei paesi germanici, in Ungheria e nel mondo slavo aggiogato alla fortuna degli imperi centrali. Moltissimi socialisti, anche fra i compagni italiani, non sono riusciti a sottrarsi all’incanto». Wilson godeva di «una autorità sulle coscienze che ha indotto molti socialisti, inconsciamente, a subordinare alle sue parole la concezione politica propria, la concezione internazionalista della storia del mondo». Cosí Gramsci stabiliva un rapporto di simmetria e una dialettica chiarificatrice tra wilsonismo e leninismo, una vera e propria metafora del salto di qualità nel conflitto tra mondo capitalistico e movimento operaio. Il progetto wilsoniano della Lega delle Nazioni prospettava, a suo giudizio, «le competizioni per la conquista economica dei mercati alla produzione degli organismi industriali borghesi» che potevano acquistare «un respiro piú ampio, di vastità mondiale». Il modo per combattere il rischio di subalternità al nuovo assetto globale prefigurato dal capitalismo liberale americano era tenere fermo il nesso dialettico tra quel processo e la nascita di una «Internazionale proletaria»12. Una simile impostazione era invece estranea a Bordiga, che riteneva l’«utopia» di Wilson espressione della «estrema difesa» del dominio di classe, un semplice «diversivo» contro la rivoluzione socialista13.
In realtà, l’internazionalismo wilsoniano esprimeva una nuova forma di potere imperiale dotata di capacità espansiva ed egemonica senza precedenti14. I primi mesi del 1919 furono l’apice del “momento wilsoniano” sulla scena mondiale e rivelarono “l’internazionalizzazione del nazionalismo” nel mondo coloniale. Il linguaggio dell’autodeterminazione promosso dal presidente americano, con tutta la sua genericità, circolava ben oltre i nuovi Stati-nazione dell’Europa centro-orientale. Le aspettative di un’applicazione del principio di autodeterminazione nazionale agli imperi francese e britannico costituirono un formidabile vettore di mobilitazione e di internazionalizzazione in India, in Cina e altrove15. Mentre il progetto wilsoniano apparve a molti l’unica autentica soluzione emergente dal caos della Grande guerra, i proclami universalisti del bolscevismo conoscevano un ridimensionamento nel teatro della guerra civile russa, che poteva far implodere la rivoluzione entro i territori di confine eurasiatici e dell’Europa centro-orientale. Lo stesso Gramsci vedeva profilarsi «un blocco compatto anglosassone» ispirato al liberismo e pronto a impiegare la Società delle Nazioni come «la finzione giuridica di una gerarchia internazionale della classe borghese», che annunciava una conferenza di pace destinata a registrare «la rivoluzione suprema della società moderna, la genesi della unificazione capitalistica del mondo»16. Sotto questo profilo, non è una forzatura affermare che gli scritti gramsciani dopo la fine della guerra mostrino una visione globale, quale componente essenziale della ricostruzione di una cultura politica.
I rivoluzionari italiani non parteciparono alla Conferenza che istituí l’Internazionale comunista a Mosca nel marzo 1919 e ne ebbero persino notizie vaghe. Tuttavia, la simultaneità tra la nascita del Comintern e la fine del «momento wilsoniano» nella primavera-estate del 1919 rafforzò le loro argomentazioni. Gramsci non perse l’occasione per ironizzare sulla «iconoclastia» rapidamente diffusasi tra i nazionalisti italiani, ma non solo tra essi, quando Wilson prese posizione contro la cessione della città di Fiume all’Italia. Questo era soltanto un episodio minore nel tramonto della fortuna mondiale di Wilson, decretata dal suo rifiuto di applicare il principio dell’autodeterminazione al mondo coloniale. La Società delle Nazioni nasceva fortemente segnata da un impianto eurocentrico e antibolscevico, rivolto a emarginare e contenere la rivoluzione in Russia17. In un simile contesto, il nesso dialettico stabilito da Gramsci tra l’internazionalismo wilsoniano e quello leniniano acquisí nuovi orizzonti di senso. L’opposizione tra Lenin e Wilson esaltò l’elemento cosmopolitico del progetto ordinovista. È facile constatare come i primi fascicoli della rivista «L’Ordine Nuovo» componessero il tessuto di una costante interazione tra il collasso degli assetti tradizionali della società italiana, la politicizzazione delle masse operaie, la crisi dell’ordine liberale europeo e il problema di costruire un ordine internazionale radicalmente nuovo. Mentre la conoscenza del leninismo era ancora indiretta e affidata a mediatori transnazionali dell’epoca, come il giornalista americano Max Eastman, Gramsci tenne per alcuni mesi una rubrica intitolata «Vita internazionale».
Il suo esordio rimarcava la connessione ormai avvenuta nelle coscienze tra le dimensioni nazionale e internazionale, tanto da poter dire non esistesse individuo incapace di comprendere «come il destino di ogni singolo uomo sia connesso alla forma dello Stato nazionale, alla forma dell’equilibrio internazionale in cui gli Stati si coordinano e si subordinano». Una simile connessione segnava, in un linguaggio marxista sui generis, «le colonne d’Ercole delle possibilità storiche della classe capitalistica», in quanto implicava il crollo della «organizzazione della civiltà mondiale». «Gli Stati liberali metropolitani», scriveva Gramsci, «si disfanno all’interno, nello stesso tempo in cui il sistema delle colonie e delle sfere d’influenza si sgretola». Il punto di frattura principale sarebbe stato il crollo dell’impero britannico, con il conseguente «avvento integrale e permanente della civiltà socialista nella storia del genere umano»18. L’aspetto visionario della sua scrittura non escludeva affatto una dimensione analitica. Anche impiegando immagini apocalittiche, Gramsci non disegnava scenari meccanici e inevitabili. Egli seguiva lo schema suggerito dal Comintern, che raffigurava un inasprimento delle contraddizioni del capitalismo mondiale destinato a creare un groviglio di tensioni ingovernabili, ma non vedeva soltanto la spirale distruttiva. Riprendendo il filo dei commenti precedenti, lesse la scelta anglo-americana di instaurare una «pace punitiva» contro la Germania come la genesi di una «egemonia del blocco anglosassone nel mondo» che non era destinata a dissolversi facilmente19. Anzi, «l’unità del mondo nella Società delle Nazioni» e il «monopolio del globo» esercitato dal capitalismo britannico e americano implicavano una trasformazione epocale, la fine della sovranità dello Stato-nazione ottocentesco. L’Italia era, a suo giudizio, un caso evidente di «morte dello Stato»20. Piuttosto che accentuare le contraddizioni irrisolvibili del passaggio dalla supremazia britannica a quella americana nel mondo, Gramsci intravedeva una nuova forma di potere economico e geopolitico. Perciò egli non si limitava a denunciare l’autodeterminazione come un inganno per sviare la lotta di classe. Riteneva invece che quell’idea fosse un’illusione pericolosa alla luce delle trasformazioni globali del dopoguerra, in quanto esse tendevano a confliggere con la sovranità nazionale. In questo senso, la sua visione non era identificabile con la vulgata antimperialista che già il Comintern emanava e che fu raccolta soprattutto da Bordiga nei suoi aspetti catastrofici e deterministici.
La nascita della Repubblica dei Consigli in Ungheria fu la conferma delle potenzialità sprigionate dalla rivoluzione russa. Anche i seguaci italiani del bolscevismo la lessero cosí e incardinarono il loro modo di pensare sull’alternativa tra rivoluzione e controrivoluzione21. La visione gramsciana si incentrava sull’Europa ma pose l’accento sulla connessione con le agitazioni e le rivolte nel mondo coloniale. «La lotta è su un piano mondiale», scriveva, senza mancare di notare come l’Armata rossa avesse raggiunto «il confine della Persia e dell’Afghanistan» controllando «i nodi stradali verso l’India, il Turkestan, l’Asia minore» e poteva stimolare «con ben piú efficace opera di persuasione dei tedeschi, la rivolta delle plebi musulmane contro i mercanti sfruttatori della cristianità»22. Al momento della Pace di Versailles, nel linguaggio dei comunisti si era largamente stabilito il canone della «lotta di classe» su scala mondiale. Cosí essi lessero il conflitto sulla pace tra l’Intesa e la Germania23. L’osservatorio internazionale dell’«Ordine Nuovo» si sviluppò ospitando scritti di figure di primo piano del Comintern, quali Sen Katayama o Sylvia Pankhurst. L’impronta gramsciana continuò però a lasciare segni. La sua motivazione per aderire al Comintern rimandava ai temi della coscienza sociale e della statualità, che significavano un distacco radicale dalle istituzioni tradizionali del socialismo prebellico. La nuova Internazionale non era infatti «un ufficio burocratico di leaders» ma «una coscienza storica della massa» e «una rete di istituzioni proletarie che dal loro seno stesso esprimono una gerarchia complessa e ben articolata». Solo cosí essa si sarebbe davvero opposta alla coalizione di Stati dell’Intesa, ora che «il Reich socialdemocratico» era stato incorporato «nel sistema economico-politico mondiale controllato dal capitalismo anglosassone»24. In questo senso, agli occhi di Gramsci, il «partito della rivoluzione mondiale» non era al tempo stesso, automaticamente, il «partito della guerra civile», secondo la formula dei bolscevichi, ma piuttosto la principale forza deterrente contro lo scivolamento della civiltà umana nell’abisso.
La caduta del regime di Béla Kun in Ungheria e della Repubblica di Baviera non scosse troppo le convinzioni dei comunisti, anche perché la tarda estate 1919 annunciò la fine dell’accerchiamento dello Stato bolscevico nella guerra civile russa. Essi non si dettero pienamente conto dei motivi che avevano portato all’insuccesso della rivoluzione ungherese. La mobilitazione nazionalista e il rigetto di larghi strati sociali verso la violenza dei poteri rivoluzionari, specie nelle campagne dell’Europa centrale, apparvero loro come aspetti marginali. Il problema della tenuta degli ordinamenti sociali europei non rientrava nella loro ottica. Le incongruenze della pace e la sopravvivenza dei rivoluzionari russi contribuirono in un modo decisivo a consolidare questo atteggiamento. La stampa del Comintern fece il suo primo test propagandistico proprio con la campagna contro Versailles. Gramsci lesse però gli eventi a suo modo. Senza curarsi troppo di fornire un’interpretazione di stampo marxista, guardò agli scenari geopolitici sotto il profilo delle passate influenze e dei conflitti per la supremazia in Europa, collegandoli all’influenza della Russia, persino nello scoppio della Grande guerra e nel suo esito, dal momento che la vittoria dell’Intesa era stata favorita dalla fuoriuscita unilaterale decisa dai bolscevichi. Ora la rivoluzione russa aveva «per cosí dire preso il posto della guerra, come fatto caratteristico e dominante della attuale situazione europea», specie in Germania e nell’ex impero austro-ungarico. In questa luce, l’edificio di Versailles gli pareva precario e mancante di un credibile ordinamento nell’Europa centro-orientale. L’impegno delle classi dirigenti europee nel soffocare il focolaio rivoluzionario era di per sé il segno del suo impatto: «Tumulto dei Ciompi, jacquerie del Medioevo francese, moti anabattisti di Germania, Comune parigina del ’71 sono innocenti fuochi fatui in suo confronto. Il proletariato dei due mondi ha istintivamente preso coscienza dell’assoluta novità e dell’importanza decisiva dell’esperimento russo». Diversamente dai bolscevichi, Gramsci non stabiliva un’analogia con la Francia rivoluzionaria, salvo menzionare la paura delle classi dirigenti europee. Pensava invece che la Russia rivoluzionaria sarebbe stata «per l’Europa proletaria» ciò che era stata la Russia zarista «per l’Europa borghese», vale a dire una custode del nuovo ordine25.
Al momento del primo congresso socialista del dopoguerra e delle elezioni del novembre 1919, la polemica antirevisionista accomunò le componenti comuniste, che si distinguevano dai massimalisti per la loro identificazione con il bolscevismo. Anche se gli ordinovisti non condividevano l’astensionismo antiparlamentare bordighiano, il comune cavallo di battaglia, in polemica con i riformisti, era che la rivoluzione comunista fosse necessaria in Italia per ragioni internazionali, prima ancora che nazionali26. Il nodo era anche generazionale, come osservò Angelo Tasca, perché i giovani che avevano sperimentato la guerra erano prima di tutti gli altri chiamati a esprimere una «potenza creativa» e una critica radicale del sistema borghese27. La retorica adesione del Partito socialista al Comintern e la sua vittoria elettorale, che ne fece il primo partito italiano, non cambiarono le carte in tavola e non composero le fratture emergenti. La prospettiva consiliare restava irrinunciabile e anzi rafforzata malgrado le sconfitte nell’Europa centrale. Il movimento dei consigli di fabbrica vide la luce a Torino avvalorando l’impegno politico e intellettuale del gruppo dell’«Ordine Nuovo». Semmai l’influenza del Comintern e l’ondata di violenza che scuoteva l’Europa in tempo di pace spinsero gli ordinovisti ad aggiustare gradualmente l’ottica dal tema della coscienza sociale e dell’iniziativa dal basso alla nozione dei rapporti di forza e al consolidamento di un nuovo ordine politico. Come è stato notato, queste rappresentavano «due correnti di fondo» del pensiero di Gramsci, che intendeva la rivoluzione socialista sia come automobilitazione delle masse e liberazione individuale, sia come coesione e ordinamento del corpo sociale, anzitutto tramite la figura e l’autorità dello Stato28. L’affermazione del potere bolscevico dalla guerra civile spostò l’ago della bilancia verso il secondo dei due poli.
Gramsci tematizzò cosí il significato della vittoria dei bolscevichi nella guerra civile russa. I successi dell’Armata rossa sui fronti orientale e meridionale della guerra civile costituivano ai suoi occhi «l’avvenimento storico piú grande del primo ventennio del secolo», perché «uno Stato operaio è sorto in Europa e nel mondo». Egli era convinto che lo Stato bolscevico incarnasse «un principio di vita, il cui respiro è piú ampio di quello delle rivoluzioni succedutesi finora nella storia del genere umano; il principio che vive e milita nella rivoluzione russa è il principio della rigenerazione del mondo, è il principio dell’unificazione del mondo rigenerato»29. Il linguaggio di Gramsci disegnava una missione palingenetica molto piú di quanto fosse lecito ricavare dai discorsi di Lenin, che alla fine del 1919 definiva realisticamente la vittoria nella guerra civile «un miracolo storico». Gramsci era però in sintonia con Lenin nel vedere la potenziale influenza dallo Stato sovietico nella politica mondiale:
Il sistema della rivoluzione proletaria internazionale, che si impernia sull’esistenza e sullo sviluppo come potenza mondiale dello Stato operaio russo, possiede oggi un esercito di due milioni di baionette […]. Le vittorie e le avanzate dell’esercito della III Internazionale scuotono le basi del sistema capitalista, accelerano il processo di decomposizione degli Stati borghesi, acuiscono i conflitti nel seno delle democrazie occidentali30.
In altre parole, egli non vedeva lo Stato rivoluzionario esclusivamente nella luce interna della sua costituzione di partito-Stato, ma anche nella sua proiezione internazionale e di potenza.
Nel marzo 1920, il tentato colpo di Stato del generale Kapp in Germania determinò una svolta repentina nella percezione e nelle prospettive rivoluzionarie dopo gli insuccessi del primo anno postbellico. I bolscevichi lo interpretarono come una riapertura della prospettiva occidentale della rivoluzione dopo aver considerato lo scenario alternativo della «rivoluzione asiatica». Il contraccolpo si fece sentire anche tra i rivoluzionari europei. Il commento di Gramsci rivelò uno spostamento di ottica sulla rivoluzione in Europa. Il tentativo di Kapp dimostrava la fragilità della democrazia di Weimar ma anche la forza del proletariato tedesco come forza organizzata, alla luce dello sciopero generale che aveva bloccato i militari. In piena sintonia con la visione dei bolscevichi e dell’Internazionale, Gramsci ripose ulteriori speranze nella Germania perché «l’equilibrio delle forze si è spostato a vantaggio della classe operaia». Una simile affermazione passava sotto silenzio il fatto che la risposta operaia era largamente avvenuta nel quadro della socialdemocrazia e non fuori da esso, ma Gramsci pensava che dopo «il periodo di stasi democratica» il proletariato tedesco si trovasse su posizioni «enormemente piú favorevoli che nel gennaio 1919»31. Le aspettative di Gramsci si collocavano in un solco condiviso dai seguaci del bolscevismo, ora conformandosi piú nettamente alla prospettiva della guerra civile. In polemica con Tasca, richiamò le analisi dei «teorici della Terza Internazionale» sul capitalismo finanziario a fondamento di una visione delle dinamiche rivoluzionarie affatto altra dalla cultura riformista32. Per la prima volta egli rifletteva però sulle sconfitte subite dalle rivoluzioni europee, riconoscendo che «in Germania, in Austria, in Baviera, in Ucraina, in Ungheria […] alla rivoluzione come atto distruttivo non è seguita la rivoluzione come processo ricostruttivo in senso comunista». Il motivo di fondo era rappresentato dall’assenza di un «movimento cosciente delle masse proletarie rivolto a sostanziare col potere economico il potere politico» fino a «fare della fabbrica la cellula del nuovo Stato». L’esperienza delle rivoluzioni europee aveva mostrato come «dopo la Russia, tutte le altre rivoluzioni in due tempi siano fallite e il fallimento della seconda rivoluzione abbia piombato le classi operaie in uno stato di prostrazione e di avvilimento che ha permesso alla classe borghese di riorganizzarsi fortemente». La lezione che ne traeva era l’esigenza di un livello piú elevato e cosciente di organizzazione politica, anzitutto tramite la «costituzione organica» dei partiti comunisti («È necessario creare, nella misura di ciò che può essere ottenuto dall’azione di un partito, le condizioni in cui non si abbiano due rivoluzioni»)33. Gramsci pose un simile obiettivo nell’imminenza del II Congresso del Comintern, sapendo che la costruzione dei partiti comunisti diveniva ora un progetto concreto e che le sue modalità sarebbero state oggetto di dibattito e negoziato.
La nascita dei partiti comunisti in Europa varata nell’estate 1920 risentí del contraccolpo generato prima dalle speranze rivoluzionarie accese dall’avanzata dell’Armata rossa in Polonia, poi dalla sconfitta e dal riflusso. L’obiettivo della presa di Varsavia, l’aspettativa di un’insurrezione proletaria in Polonia e in Germania, la speranza di esportare la rivoluzione «sulla punta delle baionette» infiammarono l’immaginazione dei delegati al Congresso del Comintern tra luglio e agosto. Tra questi non figuravano gli ordinovisti, malgrado la partecipazione di una folta delegazione italiana. Gramsci e i suoi compagni si presero però la migliore delle rivincite, quando Lenin elogiò le loro posizioni, definendole pienamente corrispondenti ai principî del Comintern. Lenin si riferiva alle proposte ordinoviste per un radicale cambiamento del Partito socialista e dei sindacati, ma è difficile pensare che gli sfuggisse lo spessore internazionalista del gruppo, a confronto di tutti gli altri esponenti dell’ala radicale e massimalista. Nel momento euforico dell’avanzata dell’Armata rossa verso occidente, egli immaginava un’insurrezione operaia in Germania e valutava una possibile «sovietizzazione» della Polonia e della Lituania. Ma riteneva anche, insieme a Zinov′ev e a Bucharin, che occorresse «promuovere senza indugio la rivoluzione in Italia»34. Le sue parole sul gruppo ordinovista vanno viste in questa luce di accese aspettative rivoluzionarie in Europa e in Italia.
Venuto a conoscenza dell’endorsement di Lenin, Gramsci ripropose il duplice registro della propria visione internazionale al culmine dell’avanzata dell’Armata rossa su Varsavia. Nel suo giudizio, la disciplina e il senso della gerarchia creati dallo Stato operaio coincidevano con l’esistenza di un «consenso nazionale» al partito bolscevico e alla «nuova gerarchia delle classi sociali» secondo la quale gli intellettuali, i contadini e le classi medie riconoscevano la classe operaia «come classe dirigente». Egli idealizzava le basi di consenso acquisite dal bolscevismo tramite la leva in massa della guerra civile e non sembrava realizzare le conseguenze della militarizzazione in chiave di autoritarismo e di pratiche violente. Nel contempo, abbozzò un’analisi della posizione acquisita dalla Russia sovietica «nel sistema mondiale delle potenze». Con la costruzione dell’esercito di massa e la guerra in Polonia, la Russia era divenuta una «potenza mondiale» dotata della «statura storica» in grado di sfidare «tutto il sistema capitalistico mondiale» perché guidava «il sistema di potenze reali che lottano contro il capitalismo egemonico». Tali «potenze reali» erano per lui le classi proletarie come le nazioni vinte, le forze ribelli nel mondo coloniale come quelle anticapitalistiche nelle metropoli. Queste parole non rappresentavano una semplice eco dei proclami dei leader bolscevichi e del Comintern, in quel momento segnati dalla hybris e dalle aspettative di un’insurrezione popolare in Polonia e in Germania a sostegno dell’Armata rossa. Gramsci partecipò di una simile speranza, che si rivelò molto presto totalmente infondata, ma intuí anche un cambiamento politico e strategico profondo, in atto indipendentemente dalle sorti della guerra russo-polacca. La Russia sovietica aveva comunque «infranto il sistema egemonico» di Versailles e dell’Intesa avviando una nuova competizione globale tra gli Stati «in una forma assolutamente impreveduta per il pensiero socialista»35. Il tono era sin troppo enfatico, ma egli coglieva un dato essenziale della transizione generata dall’esito della guerra civile in Russia, destinata a influire sulla cultura politica dei comunisti e sull’ordine postbellico.
Nel giro di pochi giorni, il sogno leniniano di fare a pezzi il sistema di Versailles prendendo Varsavia svaní sotto l’urto della controffensiva di Piłsudski. La prospettiva di un incontro tra l’Armata rossa vittoriosa e la spontanea sollevazione della classe operaia europea si consumò rapidamente. In questo cono d’ombra entrò anche la vicenda dell’occupazione delle fabbriche in Italia. Vissuta dai rivoluzionari italiani come la dimostrazione dell’insipienza della direzione socialista e della necessità di separarsi dal riformismo, la rapida sconfitta del movimento di occupazione nel settembre 1920 fu l’ultima coda di un «biennio rosso» che non era stato soltanto italiano ma anche europeo. L’opposizione tra Lenin e Wilson era ormai tramontata e nessuna delle due figure rispecchiava i rispettivi significati e le tendenze reali o immaginate dell’immediato dopoguerra. Il rivolgimento mondiale ispirato al leninismo o al wilsonismo non c’era stato. Il progetto comunista restava però attuale e segnava ugualmente la congiuntura del dopoguerra, tramite la creazione di uno Stato rivoluzionario e il suo ruolo costituente di un movimento organizzato. I partiti comunisti furono figli, nello stesso tempo, di una rivoluzione vincente in Russia, di un progetto globale e di una sconfitta storica in Europa, che in Italia presentò conseguenze estreme.
2. L’internazionalismo concreto.
La nascita del Pcd’I al Congresso di Livorno del gennaio 1921 avvenne sul modello della scissione risoluta dal mondo politico socialista, tramite l’applicazione delle rigide «ventuno condizioni» imposte dal II Congresso del Comintern che in Germania e in Francia aveva già creato due forti partiti comunisti. Livorno doveva però riflettere il crescente circolo vizioso tra la crisi italiana del dopoguerra, la radicalizzazione politica internazionale e l’instabilità dell’ordine europeo che la pace di Versailles non aveva risolto. Il sogno della rivoluzione italiana, coltivato da Lenin, Zinov′ev, Gramsci e Bordiga, si risolse in una forzatura che finí per creare una scissione nettamente minoritaria. L’internazionalismo cominternista contribuí a frantumare un partito socialista già paralizzato e diviso dopo il fallimento dell’occupazione delle fabbriche. La predominante influenza intransigente di Bordiga interagí con l’ossessione per la purezza ideologica tipica dei bolscevichi, senza la capacità di manovra che essi invocavano, dispensando consigli circa la tattica da seguire per inglobare i massimalisti. Anche gli ordinovisti contribuirono a una simile spirale settaria facendosi portatori di una polemica irriducibile contro tutti i socialisti, riformisti e massimalisti, bollati come nemici della classe operaia. Il Pcd’I non rappresentava una forza trascurabile, con i suoi quarantamila militanti circa, ma la sua capacità espansiva si rivelò limitata. Invece che fornire un nuovo impulso rivoluzionario, la spaccatura del movimento operaio sanciva la fine del «biennio rosso». Fu allora che lo strascico ideologico, violento e destabilizzante del dopoguerra europeo mostrò in Italia un carattere estremo, creando lo spazio per la guerra civile strisciante scatenata dal fascismo con le azioni armate contro il movimento operaio. Proprio nei mesi successivi alla scissione, il fascismo si profilò come un attore nazionale proponendosi quale fattore d’ordine dinanzi alla minaccia rossa, con la complicità o la benevolenza di una classe dirigente al tramonto. Cosí il caso italiano costituí un’eccezione alla capacità di tenuta dimostrata dall’Europa borghese e liberale, persino in Germania, malgrado l’impatto destabilizzante del conflitto tra rivoluzione e controrivoluzione, ma rappresentò anche un paradigma nato dalla miscela esplosiva tra lo shock della guerra, la violenza endemica, la politicizzazione di massa, la polarizzazione ideologica e le risposte nazionaliste36. Pochi anni dopo, Gramsci avrebbe espresso un duro giudizio su Livorno, annotando che i comunisti erano stati, senza volerlo, «un aspetto della dissoluzione generale della società italiana»37.
Nell’estate 1921 il gruppo dirigente del nuovo partito entrò nel mirino dei leader bolscevichi e del Comintern. Coerentemente con la nuova ricerca di alleanze e di compromessi varata dopo il fallimento dell’«azione di marzo» in Germania, Lenin invitò anche i comunisti italiani a rivedere la strategia di Livorno. Al III Congresso del Comintern, accusò Umberto Terracini di «sinistrismo» e ammoní i delegati italiani che la loro rivoluzione non poteva avvenire sulla falsariga della rivoluzione in Russia. Lenin chiedeva un’intesa con Serrati per isolare i riformisti nel Psi e una politica volta a conquistare non solo la maggioranza della classe operaia, ma anche gli strati poveri della popolazione rurale. Si stabilí cosí un braccio di ferro tra Mosca e l’intero gruppo dirigente del Pcd’I, che affidava la propria identità alla scissione dal mondo socialista38. La luna di miele con gli ordinovisti dell’estate precedente era ormai un ricordo. L’influenza del Comintern divenne un fattore conflittuale quanto piú si delineò il revirement voluto da Lenin verso la tattica «moderata» del «fronte unico». Quella dinamica non presentò una dimensione meramente bilaterale, dal momento che investiva la gran parte dei comunisti europei39. La stessa attività degli emissari del Comintern in Italia ricalcava un modello di disciplinamento utilizzato anche altrove, che spesso sortí effetti contrari a quelli sperati. Nel primo anno di vita del Pcd’I, i legami tra Mosca e il gruppo dirigente italiano furono tessuti dall’azione di svariati fiduciari russi operanti da tempo nel paese, incaricati dal Comintern o direttamente dal Politbjuro40. Nel contesto delle relazioni incerte e talvolta rocambolesche dell’epoca, la loro azione fu spesso opaca, portata avanti tramite diversi canali diplomatici, spionistici e variamente informali, e contribuí piú ad amplificare le dissonanze che a comporle. La presenza del Comintern configurò comunque una fitta rete transnazionale, nella quale in momenti diversi e negli anni successivi giocarono un ruolo in Italia o a Mosca dirigenti di primo piano quali Vasil Kolarov, Mátyás Rákosi, Otto Kuusinen, Dmitrij Manuiłskij, Jules Humbert-Droz, Osip Pjatnickij, Béla Kun e Karl Radek.
Il braccio di ferro attorno al «fronte unico» restava in atto quando Gramsci partí per Mosca nel maggio 1922, per assumere l’incarico di rappresentante del partito nell’Esecutivo del Comintern, e non si risolse facilmente. Tuttavia, il periodo trascorso a Mosca doveva rivelarsi decisivo per la sua formazione politica, a cominciare dall’acquisizione senza mediazioni di fonti e modalità di pensiero, con conseguenze importanti per tutti gli altri membri del gruppo dirigente. Il rapporto di Gramsci e dei suoi compagni con l’internazionalismo acquistò nuovi significati. Mosca nei primi anni Venti rappresentava il crocevia cosmopolita, luogo cruciale di incontri e scambi politici, culturali e ideologici frequentato da comunisti di ogni parte del mondo. Quasi due anni dopo, scrivendo a Togliatti, egli avrebbe ricordato cosí quel momento cruciale di passaggio:
Andato a Mosca senza essere informato neppure di un decimo delle questioni in corso, ho dovuto fingere di sapere e fare delle acrobazie inaudite per non far rilevare con quanta leggerezza venissero nominati i rappresentanti, senz’altro viatico che quello del dottor Grillo: «Che Dio te la mandi buona»41.
Parole probabilmente valide per tutti i comunisti che si recavano a Mosca per assumere responsabilità nel Comintern. Come molti altri, Gramsci impiegò del tempo per destreggiarsi negli ambienti cominternisti e intessere relazioni, anche a causa delle sue precarie condizioni di salute. Il problema piú scottante era rappresentato dal carattere autoreferenziale di quelle relazioni mentre la situazione in Italia precipitava.
Il settarismo dei comunisti italiani e le interminabili diatribe sui rapporti con i socialisti rispecchiavano una sottovalutazione del fascismo e una tendenza a vedere negli sviluppi della «reazione» le condizioni per un’occasione rivoluzionaria. Il Comintern aveva largamente contribuito a tale dinamica, salvo poi cercare di correggerla addossando ogni responsabilità ai comunisti locali, come in Germania. Il caso italiano fu però il piú clamoroso. È emblematico il fatto che la marcia su Roma, nell’ottobre 1922, colse i principali dirigenti del nuovo partito a Mosca impegnati a discutere sulla linea del «fronte unico» e a discettare sulla formula del «governo operaio» mentre il fascismo prendeva il potere. Bordiga e Gramsci parteciparono ai lavori del IV Congresso del Comintern difendendo la linea scissionista di Livorno e svalutando le conseguenze del colpo di Stato di Mussolini. Si posero cosí in un confronto frontale con Lenin, Trockij e gli altri dirigenti russi. Bucharin fece loro notare che una simile ottica non era idonea a creare un’opposizione delle masse operaie al fascismo42. Il braccio di ferro continuò a lungo senza trovare una soluzione, soprattutto a causa dell’intransigenza di Bordiga. Inviato come emissario in Italia all’inizio del 1923, Manuiłskij scrisse a Zinov′ev svariate comunicazioni allarmate alla luce delle persecuzioni messe in atto dal governo di Mussolini, confermando la necessità di una riorganizzazione congiunta delle file tra i dirigenti del Pcd’I e Serrati43. La lettera del 20 marzo 1923 con la quale Zinov′ev richiamò i comunisti italiani rappresentava un esempio classico di tensione politica tra centro e periferia, che vedeva i dirigenti locali disubbidire alle direttive dall’alto pur senza far mancare la loro professione di fedeltà44.
Le critiche di esponenti del Comintern ai comunisti italiani si estesero soprattutto all’analisi del fascismo. In particolare, Giulio Aquila (Gyula Sas), comunista ungherese inviato in Italia, insisteva sul carattere di massa non effimero del fascismo, capace di suscitare un consenso popolare tramite la combinazione sincretica di socialismo e nazionalismo e persino di autonomizzarsi dalle élite capitalistiche45. La nozione del carattere di massa del fascismo, in realtà, non era ignota all’ex gruppo ordinovista. Ne è testimonianza un rapporto di Palmiro Togliatti che non era giunto in tempo a Mosca per il Congresso del Comintern e che delineava un’interpretazione incentrata sulle debolezze dello Stato liberale italiano e sui tratti di originalità del fenomeno fascista, diversa da quella rigidamente classista di Bordiga46. Tuttavia i nessi tra l’analisi e la linea politica stentavano a comporre un quadro coerente. Gramsci a Mosca svolse un ruolo di mediazione, scontando la debolezza di un partito decimato dagli arresti di polizia e mancante di una forte base di militanti. Accusò Rákosi di adottare metodi sbrigativi e sprezzanti delle capacità organizzative dei comunisti italiani, ma riconobbe che la linea del Comintern non poteva non mirare a conquistare la massa dei partiti socialisti europei47. Poco dopo però Zinov′ev censurò duramente i dirigenti italiani e criticò Gramsci per aver fatto vaghe promesse di sostenere la linea della fusione, che non aveva mantenuto48. Gramsci annotò che la tattica del fronte unico non aveva trovato «in nessun paese partito e uomini che sapessero concretarla […]. Evidentemente tutto ciò non può essere casuale. C’è qualche cosa che non funziona in tutto il campo internazionale e c’è una debolezza e una deficienza di direzione»49. Dopo il primo anno a Mosca egli giunse cosí alla conclusione che l’intera revisione strategica operata dopo il fallimento della rivoluzione europea nei primi due anni del dopoguerra fosse un’esperienza frustrante e poco convincente, anche per una responsabilità del gruppo dirigente russo.
A Mosca il campo visuale che si aprí a Gramsci era molto piú ampio di quanto non suggeriscano le dinamiche cominterniste tra centro e periferia. Entrando in contatto diretto con i bolscevichi e con l’ambiente cosmopolita del comunismo internazionale, Gramsci si mise alle spalle il generico internazionalismo dei rivoluzionari europei del dopoguerra. I suoi contatti con Trockij, Bucharin e altri esponenti del gruppo dirigente del Comintern furono significativi. Egli fu testimone partecipe della riconversione del bolscevismo al potere dopo la guerra civile. Proprio nel novembre 1922, Lenin e Trockij dilatarono il tempo storico della rivoluzione mondiale, immaginata originariamente come un evento immediato e travolgente, senza mancare di rivendicare il 1917 come modello. In parallelo, Lenin presentò la Nep (Novaja Ėkonomičeskaja Politika, Nuova politica economica) come un’opzione strategica, anche se il suo giudizio oscillava tra l’idea di una «ritirata» e una visione di piú lungo periodo. I bolscevichi seguivano la logica del consolidamento del loro potere statale, che li portava a privilegiare la ripresa economica e la stabilità interna. La loro revisione dopo il «comunismo di guerra» era molto piú empirica che concettuale. Il duplice compromesso costituito dalla Nep in Russia e dal «fronte unico» nel movimento comunista si prestava a interpretazioni diverse e assunse un evidente aspetto asimmetrico, perché il tema dell’«alleanza» con il mondo contadino appariva a molti piú persuasivo e necessario di quello del rapporto con il mondo socialdemocratico. In ogni caso, l’adeguamento a un tempo e uno spazio della rivoluzione diversi da come erano stati pensati nel 1917 era il tema all’ordine del giorno nella Mosca del 1922. L’incontro di Gramsci con Lenin, il 25 ottobre 1922, fu probabilmente importante a questo proposito. È facile ritenere che il dialogo con Lenin indusse una riflessione sul fallimento dell’occupazione delle fabbriche di due anni prima, come avvenne poco dopo nel caso di Tasca50. Di fatto si pose allora il problema del passaggio dalla «guerra di movimento» alla «guerra di posizione», destinato a lasciare una lunga traccia nel pensiero di Gramsci, fino a sovrapporre un decennio piú tardi la memoria del IV Congresso del Comintern, depurata dai suoi aspetti contingenti, e l’elaborazione teorica retrospettiva compiuta in prigione51.
L’elemento centrale della ricezione gramsciana del bolscevismo divenne la costruzione delle alleanze sociali, che egli vedeva realizzarsi nella Nep e che costituiva un capitolo della lettura della rivoluzione come nuovo ordine, con implicazioni internazionali non meno che nazionali. Tale lettura assumeva il punto di vista del ceto dirigente bolscevico e apponeva uno sguardo “dall’alto” sulla società russa, destinato a restituire narrazioni mitologiche circa la natura «proletaria» del regime e a postulare l’esistenza di un consenso sociale scarsamente basata su dati di fatto. Gramsci accettava implicitamente le pratiche di governo repressive dei bolscevichi e l’evidente militarizzazione del loro linguaggio, che si trasmetteva ai partiti comunisti. Nondimeno, la sua visione aveva fondamento in un fenomeno reale, l’adozione di una politica economica influente sulla ricostruzione del paese, sui rapporti tra lo Stato rivoluzionario e la società, tra le metropoli industriali e la sterminata campagna russa. La Nep esprimeva il concreto esercizio del potere nelle condizioni storiche della Russia sovietica dopo un lungo ciclo di guerre devastanti e costituiva un riferimento per ripensare la primogenitura della rivoluzione operaia e urbana, specie in un paese come l’Italia. In tal modo si modificò la visione stessa dell’interdipendenza tra la rivoluzione russa e la rivoluzione europea, che Gramsci aveva concepito sin dal 1918. Egli aveva visto il ruolo dei rivoluzionari come argine alla dissoluzione della società, volto a delineare un ordine mondiale nuovo dopo la Grande guerra, che l’internazionalismo liberale non era in grado di edificare. Alla fine della guerra civile russa, aveva definito la Russia sovietica come una «potenza» nel mondo del dopoguerra. Ai suoi occhi, la Nep consolidava lo Stato bolscevico anche nel contesto mondiale, mentre la Società delle Nazioni rappresentava un organismo zoppo e limitato. Questa visione predispose Gramsci a combinare la revisione attuata dal bolscevismo al potere con il senso dell’internazionalismo rivoluzionario in un tempo storico che non era piú quello della «guerra di movimento» in Europa. Il momento di passaggio decisivo fu segnato dal fallimento dell’«ottobre tedesco» nell’autunno 1923 e dalla morte di Lenin.
3. La riflessione sulla sconfitta.
Alla fine del 1923, Gramsci lasciò Mosca per recarsi a Vienna. Ciò lo collocò in un campo visuale che induceva a riflettere assieme sui motivi del fallimento della rivoluzione in Europa e sulle prospettive della rivoluzione russa dopo Lenin. Egli accettò la versione ufficiale del fiasco tedesco, che scaricava tutte le responsabilità sui leader comunisti tedeschi e su Radek. In una certa misura, era consapevole delle divisioni politiche esistenti tra Trockij e gli altri leader bolscevichi. Anzi invitò il suo successore a Mosca a non sottovalutarle osservando che la situazione nel partito bolscevico «è molto piú complicata e piú sostanziale di quanto non veda Urbani [pseudonimo di Terracini]». Nello stesso tempo, però, rivolgendosi esclusivamente agli ex ordinovisti ed escludendo dalle sue riflessioni dirigenti irriducibili come Bordiga, Grieco, Fortichiari, li invitò a comprendere i motivi della supremazia dei dirigenti russi nel Comintern. I loro orientamenti si basavano infatti «su una base materiale che noi non potremo avere se non dopo una rivoluzione e ciò dà alla loro supremazia un carattere permanente e difficilmente intaccabile»52. Questa constatazione realista fondava una precisa visione dell’internazionalismo, diversa da quella di Bordiga. Gramsci contestava la contrapposizione tra l’arretratezza russa e la «determinazione» storica dell’Occidente, che avrebbe costituito il teatro autentico della rivoluzione socialista. A suo giudizio, il bolscevismo non si era formato su base nazionale, ma internazionale, e l’Europa capitalistica non era semplicemente proletaria, ma popolata da classi lavoratrici stratificate, sotto l’influenza socialdemocratica. Di qui una visione differenziata della rivoluzione in Occidente («la determinazione, che in Russia era diretta e lanciava le masse nelle strade all’assalto rivoluzionario, nell’Europa centrale e occidentale si complica per tutte quelle superstrutture politiche, create dal piú grande sviluppo del capitalismo»). Soltanto un forte legame internazionalista poteva però dare senso e futuro ai rivoluzionari in Occidente, mentre la sua recisione li avrebbe perduti. Perciò Gramsci sosteneva che, mentre Bordiga si poneva dal punto di vista di una «minoranza internazionale», occorreva invece adottare quello di una «maggioranza nazionale» integrata nel movimento internazionale53.
Tra gli elementi fondanti della visione internazionalista maturata da Gramsci figurava l’idea della fondamentale unità del gruppo dirigente bolscevico, «una delle grandi forze dei compagni russi», ancora piú necessaria dato il loro monopolio politico nello Stato rivoluzionario54. Lo Stato bolscevico poteva esprimere il proprio potenziale soltanto a condizione che le élite politiche restassero compatte. Il suo necrologio apologetico di Lenin espresse implicitamente un simile punto di vista, insieme all’incertezza della fase che si apriva. Veniva meno l’ideatore dell’«egemonia del proletariato […] concepita storicamente e concretamente» e la sua funzione centrale nel gruppo dirigente55. Gramsci era pienamente consapevole, nello stesso tempo, del significato mitologico che emanava dalla figura di Lenin e dello Stato rivoluzionario. Nel frammento di una lettera scritta nel gennaio 1924, egli descrisse il culto di Lenin nel funerale di un bracciante, osservando che i nomi dei capi rivoluzionari «in una grande parte della massa piú povera e arretrata, diventano quasi un mito religioso. È questa una forza che non bisogna distruggere»56.
Gramsci scriveva a Vienna nei primi mesi del 1924, in un periodo di riflessione e di attività intense, tramite le molteplici relazioni dell’organizzazione cominternista57. È facile immaginare che il suo pensiero fosse ispirato proprio dall’esperienza nella città del movimento operaio piú organizzato d’Europa, dominato dalla socialdemocrazia di governo, con i comunisti locali ridotti alla marginalità e insignificanti numericamente58. Sta di fatto che egli elaborò a Vienna una visione della rivoluzione lontana o persino opposta alle teorie e pratiche dell’offensiva basate sul modello del 1917, identificate largamente nella personalità di Trockij, sebbene tutto il gruppo dirigente bolscevico le avesse condivise nella Germania del 1923. Tale visione non significava però in alcun modo separare il destino dei rivoluzionari europei dalla Russia sovietica. Il problema della «traducibilità» dei linguaggi e delle pratiche rivoluzionarie si trasferiva all’interazione tra la nuova statualità sovietica e la resilienza delle classi dirigenti europee, tra l’esercizio bolscevico del potere nel sistema della Nep e le condizioni dell’egemonia nell’Europa borghese. Contestualmente, Gramsci rifletteva sulla sconfitta subita nel dopoguerra dai rivoluzionari italiani. Era mancata la capacità di «tradurre in linguaggio comprensibile a ogni operaio e contadino» il significato degli avvenimenti del «biennio rosso»59. Gramsci impiegava una nozione di Lenin, che nel suo intervento al IV Congresso del Comintern aveva stigmatizzato la difficoltà incontrata dal linguaggio politico dei bolscevichi in Europa. Sebbene egli rivendicasse la capacità dell’«Ordine Nuovo» di interpretare la cultura politica del bolscevismo nell’Italia del 1919-20, il suo sguardo retrospettivo sulla nascita del Pcd’I era duramente autocritico, alla luce dell’ascesa del fascismo.
Rientrato in Italia nel maggio 1924, Gramsci doveva presto prendere le redini del partito e si trovò a fronteggiare la crisi provocata dall’assassinio di Matteotti. Alla luce della crisi del regime, egli sviluppò un’analisi del fenomeno fascista come «un’organizzazione di massa della piccola borghesia», nata in relazione alla «crisi della classi medie» del dopoguerra, invitando alla prudenza circa lo scenario di un risveglio rivoluzionario popolare pur nella seria difficoltà attraversata da Mussolini60. Nel contempo, il gruppo dirigente fece i conti con tutte le possibili contraddizioni dell’internazionalismo comunista, subendo sia la logica della diplomazia di Mosca, sia l’ennesima censura del Comintern, questa volta a parti invertite. L’instaurazione di relazioni diplomatiche tra l’Italia e l’Unione Sovietica all’inizio dell’anno fece infatti emergere una tensione che non aveva precedenti neppure in Germania. Il famoso casus belli fu il pranzo dell’11 luglio 1924 tra l’ambasciatore sovietico Konstantin Jurenev e Mussolini. La diplomazia sovietica sembrò cosí offrire una sponda a Mussolini nel momento piú critico del suo isolamento internazionale. Gramsci reagí con durezza e sconfessò pubblicamente la scelta dell’ambasciatore. Forti del sostegno del consigliere politico dell’ambasciata Aleksandr Makar, i dirigenti italiani protestarono senza giri di parole con l’Esecutivo del Comintern, ma non ottennero alcuna risposta dirimente61. L’episodio mise a nudo il rischio di una rotta di collisione tra gli interessi di Mosca e la sopravvivenza del partito italiano, come di altri partiti comunisti in Europa e altrove. Parallelamente, l’Esecutivo criticò Gramsci per le sue esitazioni ed esortò i comunisti italiani a porsi come compito immediato «il rovesciamento del regime fascista», dal momento che «l’intera nazione italiana sta per ribellarsi contro il fascismo»62. Uno schema a dir poco semplicistico, nell’Italia del 1924 come nella Germania dell’anno precedente, proprio quando Gramsci aveva fatto tesoro delle analisi critiche sul fascismo suggerite da Bucharin e da esponenti del Comintern quali Sas e Clara Zetkin63.
Fu necessario l’intervento del vicecommissario agli Affari esteri, Maksim Litvinov. Il 14 novembre 1924, questi istruí Jurenev su come fosse opportuno relazionarsi «con i nostri antipodi politici, i fascisti». Nel caso del governo italiano, precisò, «avete un caso classico della duplicità della nostra politica verso il fascismo, come comunisti e come potere statale». Erano corrette «le relazioni concrete» instaurate con Mussolini, ma quanto a un appoggio al fascismo «come partito e come movimento politico, non se ne può ovviamente neppure parlare». Nello stesso tempo, Litvinov riteneva che la crisi Matteotti avrebbe portato al tramonto del fascismo, ma finché Mussolini restava al potere, era inevitabile trattare con lui64. Questa linea componeva i rapporti con i comunisti italiani in vista dell’apertura di negoziati per un trattato politico con l’Italia, nella forma di un patto di non aggressione, proposto da Roma il 7 novembre. La decisione sovietica di portare avanti una trattativa seguí di poco la dichiarazione di Mussolini che chiudeva brutalmente la crisi assumendosi la responsabilità politica del delitto Matteotti. Il 20 gennaio 1925, Litvinov informò il Politbjuro sulle condizioni per concludere il negoziato con Roma. Fece notare che anche Gramsci e Grieco avevano suggerito «di non respingere le proposte di Mussolini, ma solo di stringere l’inizio dei negoziati», ritenendo che dopo le elezioni si sarebbe verificato «un accordo tra i fascisti e le opposizioni». Nell’eventualità di «un governo postfascista in Italia», osservava Litvinov, «concludere un accordo non sarà possibile». Il 27 gennaio il Politbjuro deliberò a favore del trattato, incaricando Bucharin di «preparare nel modo corrispondente i comunisti italiani»65. In realtà, il negoziato tra Mosca e Roma si trascinò a lungo senza mai giungere in porto66. Ma l’episodio resta molto significativo. Come si vede dalle parole di Litvinov, Gramsci non si limitava a riconoscere gli interessi dello Stato sovietico, ma anzi aderiva con realismo a una linea strategica che consentisse di favorirli, in questo caso tramite un’intesa con il «revisionista» Mussolini che avrebbe integrato l’asse già stabilito da Mosca con Berlino in chiave anti-Versailles. Il dualismo tra la politica estera dell’Unione Sovietica e il Comintern non produceva necessariamente una dicotomia tra ragion di Stato e rivoluzione nelle relazioni con i comunisti locali. Tanto meno questi si caratterizzarono soltanto per la propria lealtà. Proprio perché Gramsci e il suo gruppo dirigente si ponevano il problema di una «traduzione» nazionale degli insegnamenti del bolscevismo, in rotta di collisione con Bordiga, la loro visione dell’internazionalismo includeva l’incrocio con la ragion di Stato sovietica.
Le lezioni dell’Ottobre di Trockij avevano nel frattempo innescato definitivamente la lotta per la successione a Lenin, destando forte impressione tra i comunisti europei67. La loro percezione della «questione russa» si rivelava però quanto mai approssimativa. Molti videro Trockij come un leader di «destra», che si sarebbe proposto di rinviare la rivoluzione «a tempo indefinito», mentre egli si presentava invece come il nemico giurato della teoria del «socialismo in un solo paese» delineata da Stalin e Bucharin, che giudicava una rinuncia alla rivoluzione mondiale68. Gramsci puntò comunque il dito sul tema per lui essenziale: le visioni di Trockij rappresentavano un «pericolo» in quanto «la mancanza di unità nel partito in un paese in cui vi è un solo partito, scinde lo Stato»69. Il secondo viaggio di Gramsci in Russia (marzo-aprile 1925) serví a fare chiarezza ma non dissipò il suo timore per il rischio di una frattura del gruppo dirigente bolscevico. Egli poté constatare che era la maggioranza di Stalin e Bucharin a sostenere la tesi della «stabilizzazione del capitalismo» dopo l’adozione del Piano Dawes lanciato dagli Stati Uniti e l’avvio della ripresa economica in Germania. Adottata ufficialmente proprio nel marzo 1925 e subito oggetto di feroci polemiche tra la maggioranza e l’opposizione del partito bolscevico, la formula della «stabilizzazione relativa» integrava la dottrina del «socialismo in un solo paese»70. Gramsci si trovò soprattutto costretto a difendere il proprio gruppo dirigente dall’accusa di «carbonarismo» mossa da Manuiłskij71. Ma espresse anche la propria visione della «relativa stabilizzazione del capitalismo», riferendosi al periodo successivo al 1921 come «caratterizzato da un rallentamento del ritmo rivoluzionario» che era all’origine della debolezza ideologica dei partiti comunisti72. Gramsci non aderiva alla lettura di Trockij (e di Bordiga), che postulava una statica opposizione tra il «socialismo in un solo paese» e la rivoluzione mondiale. Al contrario, vedeva un rapporto dinamico tra le due nozioni. Il «socialismo in un solo paese» non significava, dal suo punto di vista, una rinuncia alla rivoluzione mondiale e anzi poteva costituirne una risorsa politica e simbolica. L’allontanamento delle prospettive rivoluzionarie in Europa avrebbe però potuto compromettere l’esercizio dell’egemonia bolscevica in Russia. La sua stella polare fu l’unità del gruppo dirigente quale condizione necessaria per mantenere l’autorità dello Stato bolscevico. Nel suo scontro con Bordiga, egli pose come una questione «sostanziale» la concezione unitaria del Comintern quale «partito mondiale» della rivoluzione73. Il nesso tra movimento comunista e Stato rivoluzionario innervava gli altri elementi strategici che separavano Gramsci da Bordiga, la «bolscevizzazione» come disciplinamento e sforzo di costruire un partito di massa, la questione contadina come «questione nazionale», la «stabilizzazione relativa» del capitalismo74.
Il Congresso di Lione del Pcd’I, nel gennaio 1926, lasciò in disparte le valutazioni sull’evoluzione della politica sovietica, su richiesta degli stessi bolscevichi. Il gruppo dirigente italiano si concentrò sulla prospettiva di conciliare l’apprendimento del «leninismo» con una prospettiva nazionale e una lettura del dualismo storico tra Nord e Sud come base per l’«alleanza» tra operai e contadini, ispirata dalla Nep. Sotto questo profilo, l’Italia poteva apparire un anello di congiunzione globale tra la rivoluzione europea e la rivoluzione mondiale, con la sua unica combinazione nel perimetro nazionale di un Nord industriale e un Sud semicoloniale. Il problema della «traduzione» dei linguaggi rivoluzionari si faceva ancora piú cruciale e si rivolgeva tendenzialmente a una pluralità di soggetti che non erano esclusivamente definiti da categorie di classe75. In una conversazione con il nuovo ambasciatore sovietico, Platon Keržencev, il 5 febbraio 1926 Gramsci espresse la propria soddisfazione per il risultato del Congresso, rilevando l’isolamento di Bordiga76. Tuttavia la «questione russa» tornò a imporsi subito dopo e la figura di Bordiga non uscí di scena. Questi venne anzi incluso nella delegazione italiana al VI Plenum dell’Esecutivo del Comintern e la sua presenza generò uno scontro frontale con Stalin. Bordiga chiese che si discutessero «le questioni trattate dal congresso russo», vale a dire lo sviluppo della Nep e il problema dell’opposizione. Stalin respinse la richiesta con l’argomento che si trattava di questioni «essenzialmente russe» e che i partiti occidentali non erano «ancora preparati a discutere di esse». Egli ribadí cosí la gerarchia esistente tra il partito russo e gli altri, parlando di un «privilegio» che poneva precise «responsabilità» al gruppo dirigente bolscevico. Bordiga pose allora provocatoriamente il problema del rapporto tra rivoluzione russa e rivoluzione mondiale chiedendo «se il compagno Stalin pensa che lo sviluppo della situazione russa e dei problemi interni del partito russo è legato allo sviluppo del movimento proletario internazionale». Suscitò cosí l’indignata replica di Stalin: «Questa domanda non mi è mai stata rivolta. Non avrei mai creduto che un comunista potesse rivolgermela. Dio vi perdoni di averlo fatto»77. È evidente che Bordiga aveva sfidato una sacralità molto radicata in Stalin, rompendo una convenzione accettata dalla maggior parte dei comunisti. Grieco prese le distanze da Bordiga ricordando che non si poteva «capovolgere la piramide» e stabilire una inesistente «uguaglianza tra partiti comunisti», anche perché «la influenza rivoluzionaria esercitata da Mosca» costituiva un fattore di attrazione delle masse per i partiti comunisti78. Tuttavia l’interrogativo posto dal dirigente napoletano era nella mente di tutti, a cominciare da Gramsci, e avrebbe portato a risposte molto diverse tra loro.
4. Il senso ultimo dell’internazionalismo.
Lo sciopero generale del Primo maggio 1926 in Gran Bretagna riportò alla ribalta la visione della rivoluzione europea. Il 9 maggio Togliatti, da poco nominato rappresentante del Pcd’I al Comintern, riferí a Roma che a Mosca si vedeva lo sciopero inglese come «il fatto piú importante che sia accaduto dopo la rivoluzione russa». Egli non mancava di notare che, stando cosí le cose, Trockij aveva mostrato una capacità di previsione piú lucida degli altri dirigenti avversando la tesi della «stabilizzazione relativa»79. La revoca dello sciopero e l’immediata liquidazione delle illusioni rivoluzionarie fecero esplodere il feroce antagonismo esistente tra i bolscevichi, generando una spirale che non sarebbe piú stata recuperata tra la maggioranza di Stalin e Bucharin e l’opposizione unita di Trockij e Zinov′ev. Togliatti e il gruppo dirigente a Roma, privi di fonti di informazione oltre alla stampa del Comintern, si orientarono verso le posizioni di Stalin e Bucharin, volte a negare la fine pura e semplice della «stabilizzazione». Scoccimarro scrisse a Togliatti che «in generale noi siamo d’accordo con le direttive e l’atteggiamento da te preso». Egli citava lo sciopero operaio in Inghilterra, la crisi finanziaria in Francia, il colpo di Stato di Piłsudski in Polonia come sviluppi di un possibile esito rivoluzionario, ma precisava: «Non crediamo si sia giunti di già a questo punto»80.
Stalin e Bucharin decisero di coinvolgere i partiti comunisti, con l’obiettivo di arginare la possibile influenza del trockismo. Togliatti lo rese noto con prudenza («mi è stato detto che sarebbe desiderabile che il Pcd’I prendesse posizione sulle questioni che si dibattono ora nell’Internazionale. Da un compagno russo. Dobbiamo esaminare un poco la cosa»)81. Il 15 luglio egli stesso intervenne al Plenum del partito russo in appoggio alla maggioranza, accusando l’opposizione di «impazienza rivoluzionaria»82. Poi inviò a Roma dettagliate informazioni sullo scontro tra i dirigenti bolscevichi. Nel suo resoconto, concordò con la definizione dell’opposizione come «un blocco senza principî» e riconobbe inevitabile la conclusione del Plenum con «una sanzione di carattere organizzativo contro l’opposizione» (vale a dire l’esclusione di Zinov′ev dal Politbjuro). Egli riteneva che la scelta di una contrapposizione frontale compiuta da Trockij potesse «esercitare sulla vita del Pcr [Partito comunista russo] conseguenze per ora non calcolabili, certo assai gravi». A questo punto, Togliatti espresse il parere che la decisione del XIV Congresso del partito sovietico di non consentire ai comunisti europei di discutere la «questione russa» fosse superata. Il Comintern avrebbe necessariamente dovuto affrontare il problema perché ci si trovava a «un momento essenziale nello sviluppo dello Stato proletario e della sua politica»83.
Non conosciamo direttamente il punto di vista di Gramsci sugli sviluppi della «questione russa» nella primavera-estate 1926. Tuttavia, la sua relazione al Comitato centrale del Pcd’I del 2-3 agosto forní un’analisi internazionale circostanziata e fuori dagli schemi consolidati. Egli non prese posizione nel dibattito infuocato tra i successori di Lenin. Il suo giudizio era che la «stabilizzazione» del capitalismo non fosse al capolinea, ma la nozione stessa doveva essere ripensata e adattata a un’analisi differenziata, distinguendo tra il centro e la periferia del sistema capitalistico. Riprendendo il filo rosso di un pensiero già delineato, osservò che nei paesi a capitalismo avanzato «la classe dominante possiede le risorse politiche e organizzative che non possedeva per esempio in Russia» e perciò «anche le crisi economiche gravissime non hanno immediate ripercussioni nel campo politico». Era implicita l’osservazione di una realtà europea decisamente mutata negli ultimi due anni, a seguito della fuoriuscita della Germania dal ciclo di crisi del primo quinquennio postbellico. La rivoluzione tedesca era fallita, ma cosí anche la reazione sul modello fascista nel cuore dell’Europa. Nei paesi periferici invece, quali l’Italia, la Spagna, il Portogallo e la Polonia, dove «le forze statali sono meno efficienti», i movimenti delle classi intermedie, «le quali vogliono e in un certo senso riescono a condurre una propria politica», presentavano una diversa influenza e un potenziale reazionario o rivoluzionario. La periferia dell’Europa aveva attraversato nel dopoguerra transizioni simili all’Italia, che restava la forma «classica ed esemplare». Ma ora poteva essere giunto il momento di uno spostamento «molecolare» delle classi intermedie dalla reazione alla rivoluzione. In tal caso, sosteneva Gramsci, «noi entriamo in una fase nuova dello sviluppo della crisi capitalistica»84.
Gli studiosi si sono soffermati soprattutto su questa previsione illusoria di Gramsci, sulla scorta delle critiche in chiave di realismo mossegli allora da Tasca85. Di certo, le analisi sul fascismo come movimento di massa fondato sulle classi medie non avevano stemperato le aspettative di una destabilizzazione del regime, anche dopo la crisi Matteotti. È probabile che le speranze riposte in una imminente crisi del fascismo fossero indotte, tra l’altro, dal bisogno di contrastare l’influenza di Bordiga. Le visioni rivoluzionarie non erano un monopolio di Trockij e dei suoi seguaci. Le differenze tra i dirigenti del comunismo mondiale in tema di maggiore o minore realismo erano molto piú sfumate di quanto si ritenga solitamente. In particolare, la rivoluzione cinese suscitava aspettative trasversali. Tutti i dirigenti bolscevichi, malgrado le loro divergenze politiche, ritenevano ancora aperto lo scenario di una rivoluzione in Asia destinata a destabilizzare l’impero britannico86. La specificità di Gramsci consisteva piuttosto nel pensare che le prospettive rivoluzionarie fossero ancora aperte in Europa, ma soltanto nella periferia e non nelle metropoli del capitalismo avanzato. Il suo schema perciò non seguiva le visioni rivoluzionarie di Trockij e di Zinov′ev. Egli non pensava che l’Inghilterra del 1926 fosse come la Germania del 1923. Sulla questione dello sciopero inglese, accolse le posizioni della maggioranza del partito russo ritenendo che non vi fossero le condizioni per dare vita a un’azione autonoma dei comunisti. Gramsci guardava altrove. Non alla Germania o alla Gran Bretagna, ma neppure alla Cina. La sua visione non si volse alle interconnessioni immaginate tra la rivoluzione cinese e l’impero britannico, ma alle linee di frattura nel continente europeo, che assegnavano all’Italia fascista il ruolo di un laboratorio.
L’analisi differenziata gramsciana implicava un’attenzione alle diverse realtà nazionali e una distanza da letture integralmente classiste della dimensione internazionale. In questa luce, i canoni e i linguaggi cominternisti non facevano velo alla capacità di riconoscere una certa autonomia alle dinamiche internazionali e la molteplicità dei loro intrecci con i contesti nazionali (che lo portava, tra l’altro, a rimarcare le peculiarità di alcuni paesi del centro capitalistico, come la Francia). Gramsci si muoveva entro le coordinate suggerite soprattutto da Bucharin, ma con una differenza importante. Il teorico della Nep aveva da tempo chiarito che la dottrina del «socialismo in un solo paese» e la nozione della «stabilizzazione capitalistica» non liquidavano la «rivoluzione mondiale», perché soltanto quest’ultima poteva garantire la Russia sovietica dalla minaccia di un attacco delle potenze capitalistiche. La nozione gramsciana di una fase «intermedia» e la differenziazione delle realtà nazionali implicavano dissenso circa l’idea delle «due stabilizzazioni» speculari tra loro. La sua idea era che la tesi della «stabilizzazione relativa» del capitalismo offrisse scarso aiuto analitico e che la ragion d’essere del movimento rivoluzionario non si potesse risolvere nella mera difesa dell’Unione Sovietica. In questo quadro, egli aveva ben presente il ruolo degli Stati Uniti, sebbene solo per accenni. In particolare, stigmatizzava «l’asservimento completo» del governo fascista al capitalismo americano. Un argomento centrale nelle polemiche di stampa contro Treves e i socialisti riformisti, in linea con le visioni dei principali leader bolscevichi. Trockij, Zinov′ev e Bucharin avevano messo piú di una volta l’accento sulla schiacciante supremazia economica americana e sul significato del Piano Dawes in Europa quale strumento di riorganizzazione del capitalismo globale. Il Plenum del Comintern del febbraio-marzo 1926 aveva equiparato l’«americanizzazione» in Europa a un fenomeno reazionario che si avvaleva della presenza delle socialdemocrazie di governo e lanciato la parola d’ordine degli «Stati uniti socialisti d’Europa»87.
Gramsci non impiegava però la teoria delle «contraddizioni inter-imperialistiche» che portava i bolscevichi a immaginare persino uno scenario di guerra tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Come già aveva fatto nell’immediato dopoguerra, rimarcava invece l’influenza del potere economico americano, che ora chiaramente eclissava le potenze europee. Nella periferia d’Europa, la tendenza del capitalismo globale a limitare la sovranità nazionale degli Stati non costituiva però sempre un fattore di stabilità. Anche sotto questo profilo, egli faceva propria una visione eurocentrica delle dinamiche globali, che non cercava strategie di aggiramento in Asia al fine di destabilizzare gli imperi occidentali. Pensava invece a un’analisi piú realistica e sottile delle società europee e delle loro contraddizioni, con l’obiettivo di capire i punti fragili dell’ordine internazionale costituito dal Piano Dawes, dalla Conferenza di Locarno e dall’ingresso della Germania di Weimar nella Società delle Nazioni. Gli interrogativi sull’effettiva stabilizzazione della metà degli anni Venti aleggiavano ampiamente nella politica europea, specie perché il Trattato di Locarno disegnava uno scenario geopolitico incentrato esclusivamente sull’Europa occidentale e lacunoso nell’Europa centro-orientale, ma anche riguardo al ruolo che gli Stati Uniti avrebbero effettivamente giocato88. Gramsci interpretava a suo modo questo tema, mentre a Mosca esso era recepito prevalentemente nella chiave di una minaccia alla sicurezza sovietica oppure induceva a guardare alla Cina in funzione antibritannica.
Il conflitto nel Partito comunista sovietico si fece sempre piú stringente. Secondo Togliatti, il coinvolgimento dei comunisti europei era «di importanza fondamentale per le prospettive e per la tattica dell’avanguardia del proletariato nel momento presente»89. Il 26 settembre annunciò la convocazione per il 15 novembre di un Esecutivo allargato del Comintern, destinato a discutere la questione90. Le tensioni a Mosca presentavano riflessi nel discorso pubblico, dato che la stampa italiana non mancava di propagare notizie allarmanti e strali polemici circa la lacerazione del gruppo dirigente rivoluzionario. Gramsci si impegnò in una difesa della rivoluzione in Russia, incentrata sulla Nep. Egli sostenne la tesi di Bucharin che la dinamica storica tra i ceti industriali e agrari del XIX secolo fosse replicata dagli operai e dai contadini nel XX secolo e che il legame tra le due classi fondasse un’esperienza rivoluzionaria destinata a costruire una società socialista91. L’apologia del «socialismo in un solo paese» costituiva, sotto questo profilo, un riferimento ideale per il gruppo dirigente gramsciano. Fino allora esso si era distinto, in una certa misura, dalle logiche di schieramento che percorrevano il Comintern. Le circostanze del 1926 generarono però una discontinuità. Messo sotto pressione dalla richiesta di allineamento fatta da Stalin e Bucharin, il gruppo dirigente italiano si divise in un conflitto incomponibile e pieno di implicazioni tra Gramsci e Togliatti.
Si inserí in tale dinamica, con ogni probabilità, la lettura del testo integrale del «testamento» di Lenin92. Verosimilmente dettata da Lenin alle sue segretarie tra la fine di dicembre 1922 e l’inizio di gennaio 1923, letta ai delegati del XIII Congresso ma tenuta segreta dai dirigenti bolscevichi, la «lettera al Congresso» (o «testamento») di Lenin rappresentava una mina vagante nella politica comunista dell’epoca, sebbene la sua autenticità non fosse certa. L’appello a rimuovere Stalin dal potere ne costituiva l’aspetto piú pesante e ricorrente nella lotta senza esclusione di colpi per la successione. L’esistenza di un simile documento e parte del suo contenuto divennero noti ai comunisti europei a partire dalla primavera-estate 1925, quando il comunista americano Max Eastman (ben noto agli ex ordinovisti) ne citò in un pamphlet alcuni passaggi selezionati con il fine di mettere in una luce positiva Trockij93. Questi fu costretto da Stalin a prendere le distanze dall’autore per la sua disinvolta manipolazione di un documento che tutti i leader bolscevichi avevano convenuto di non destinare al pubblico, ma non ne smentí l’esistenza. Dopo una lunga serie di controversie e richiami al documento da parte dell’opposizione, lo stesso Stalin lo citò largamente nel Plenum del Comitato centrale del luglio 1926 aperto ai rappresentanti del Comintern, nel tentativo di togliere un’arma agli oppositori ricordando i giudizi tutt’altro che lusinghieri espressi da Lenin anche su di loro94. Il testo integrale divenne allora il classico segreto di Pulcinella. In una delle sue comunicazioni da Mosca, il 4 ottobre 1926, Togliatti fece cenno all’intenzione dell’opposizione di chiedere «un referendum sul testamento di Lenin»95. Egli menzionava il documento senza alcuna enfasi, evidentemente dando per scontato che fosse familiare ai suoi compagni. In altre parole, possiamo ritenere che i dirigenti comunisti italiani (e non solo essi) avessero letto il «testamento» di Lenin prima della sua pubblicazione a opera di Eastman sul «New York Times», avvenuta il 18 ottobre 192696. Ciò getta una luce particolare sulla lettera inviata da Gramsci il 14 ottobre 1926 a Togliatti a Mosca, perché questi la inoltrasse al gruppo dirigente sovietico, in risposta alla richiesta dei capi della maggioranza bolscevica di sostenerli contro l’opposizione.
Gramsci dichiarava in apertura della sua missiva di percepire una situazione «diversa e molto piú grave» che in passato perché «vediamo verificarsi e approfondirsi una scissione nel gruppo centrale leninista» e concludeva indicando in Trockij, Zinov′ev e Kamenev «i maggiori responsabili dell’attuale situazione». Il termine «scissione» era moneta circolante nel movimento comunista e lo stesso Gramsci lo aveva piú volte impiegato in relazione a Bordiga e a Trockij. Ma ora egli usava questa nozione in un modo diverso, cioè come il frutto avvelenato di un conflitto di «carattere organico» che vedeva tutti responsabili, anche Stalin. Una simile scissione metteva a rischio «il principio e la pratica dell’egemonia del proletariato» e «i rapporti fondamentali di alleanza tra operai e contadini», vale a dire «i pilastri dello Stato operaio e della Rivoluzione». La critica all’opposizione trockista era incentrata sull’argomento che essa avesse tradito l’idea che il proletariato non poteva «mantenere la sua egemonia e la sua dittatura» senza sacrificare i propri «interessi corporativi», resuscitando perciò «tutta la tradizione della socialdemocrazia e del sindacalismo», ostacolo principale all’«organizzarsi in classe dirigente» del proletariato occidentale. Ma la sua principale preoccupazione era che la maggioranza staliniana intendesse «stravincere» e favorire cosí una scissione che avrebbe prodotto danni «irreparabili e mortali». «Voi siete stati in questi nove anni di storia mondiale l’elemento organizzatore e propulsore delle forze rivoluzionarie di tutti i paesi», dichiarava Gramsci, «ma voi oggi state distruggendo l’opera vostra, voi degradate e correte il rischio di annullare la funzione dirigente che il Pc dell’Urss aveva conquistato per impulso di Lenin»97. È lecito pensare che una simile visione fosse influenzata, tra l’altro, dalla lettura della «lettera al Congresso» di Lenin. Il documento affermava che il pericolo di una «scissione» nel partito nascesse in gran parte dalle personalità di Stalin e Trockij. Era quello anzi il suo aspetto centrale, assai piú dell’appello a rimuovere Stalin dal potere, legato a una contingenza ormai passata. Nell’autunno 1926, quel monito poteva essere letto come una profezia che si stava avverando e portava a evitare logiche di schieramento troppo stringenti.
Sappiamo che Gramsci preparò la lettera con cura e l’annunciò sin dal 6 ottobre a Keržencev. Questi ne riferí a Stalin il giorno stesso:
Il c. Gramsci, membro del Cc e dell’ufficio politico del partito italiano, mi ha comunicato oggi che il Cc invierà alla nostra conferenza di partito una lettera contenente l’indicazione di tutto il danno causato dall’opposizione al lavoro comunista all’estero. Egli ha chiesto la mia opinione (nella forma di una conversazione privata, amichevole). Come membro della Vkp(b), gli ho detto che l’invio di tale lettera porterebbe un sostegno al nostro partito, in quanto effettivamente l’opposizione distrugge la causa del comunismo non soltanto da noi, ma dappertutto. Gramsci ha detto che la lettera sarà inviata nei prossimi giorni. Vi comunico questo per vostra conoscenza98.
Chiarendo in anticipo la propria lealtà verso la maggioranza bolscevica, Gramsci pensava evidentemente di inserirsi in una dinamica ancora in bilico a Mosca, dal momento che negli stessi giorni si profilava una tregua, annunciata da Togliatti in una comunicazione dell’11 ottobre e poi ufficializzata sulla «Pravda» il 17 ottobre99. L’impianto concettuale di Gramsci non era limitato al «testamento» ma si basava sul Lenin degli ultimi scritti. Egli indicò nella Nep la grande sfida postrivoluzionaria. La sua profonda convinzione, espressa con il medesimo linguaggio dei bolscevichi, era che il proletariato avrebbe potuto mantenere «la sua egemonia e la sua dittatura» soltanto sacrificando gli «interessi corporativi» in nome degli «interessi generali e permanenti della classe». Su questa narrazione, destinata a costituire una traccia della riflessione nel carcere, Gramsci incentrava la propria visione dell’internazionalismo. L’unità del gruppo dirigente bolscevico era per lui allo stesso tempo condizione necessaria per «l’egemonia proletaria in regime di Nep», cioè «i rapporti fondamentali di alleanza tra operai e contadini», e per «lo sviluppo e il trionfo delle forze rivoluzionarie mondiali». In una simile ottica, pronunciò l’accusa piú dura: «Ci pare che la passione violenta delle questioni russe vi faccia perdere di vista gli aspetti internazionali» dimenticando che «i vostri doveri di militanti russi possono e debbono essere adempiuti solo nel quadro degli interessi del proletariato internazionale»100.
Nella sua replica, Togliatti ignorò la connessione stabilita da Gramsci tra il sistema di potere fondato sulla Nep e le sue implicazioni internazionali. Egli indicò il «difetto essenziale» dell’argomentazione gramsciana nell’aver posto in primo piano il fatto della scissione e in secondo piano «il problema della giustezza o meno della linea» seguita dalla maggioranza. Rimproverò Gramsci di non aver fatto alcuna distinzione tra la maggioranza e l’opposizione del partito sovietico e aggiunse che «probabilmente, d’ora in poi, l’unità della vecchia guardia leninista non sarà piú […]. Nel passato il piú grande fattore di questa unità era dato dall’enorme prestigio e dalla autorità personale di Lenin. Questo elemento non può essere sostituito». Togliatti negava che vi fosse un legame tra l’unità del gruppo dirigente bolscevico nel suo assetto attuale e la funzione storica di organizzazione delle forze rivoluzionarie mondiali assolta dal Partito comunista sovietico101.
A questo punto, il 18 ottobre, esplose la bomba della pubblicazione del «testamento» di Lenin. La notizia divenne subito globale e Gramsci la apprese dal «Corriere della Sera» del 19 ottobre102. Il 21 ottobre, Manuiłskij gli scrisse per rassicurarlo circa la stabilità del potere sovietico e la completa disfatta dell’opposizione: due argomenti che a Gramsci suonarono verosimilmente contraddittori tra loro e che non collimavano con la sua idea di stabilità dello Stato. Manuiłskij affermava anche, come Togliatti, che i compagni italiani non avrebbero avuto adeguata percezione del reale stato delle cose a Mosca e promise di rimediare inviando un emissario in Italia, che sarebbe stato Humbert-Droz103. Non era però questo il punto autentico della questione. Di certo Gramsci capí che la situazione a Mosca stava precipitando, anche e soprattutto in seguito alla pubblicazione del «testamento». Ne trasse conferma dall’informativa di Togliatti del 25 ottobre circa le decisioni drastiche assunte dalla maggioranza contro l’opposizione il 23 ottobre e circa la richiesta della delegazione dell’Esecutivo del Comintern di rimuovere Zinov′ev dalla carica di presidente104.
La replica di Gramsci a Togliatti del 26 ottobre va compresa in questo contesto. Egli ammetteva che l’unità non potesse essere mantenuta «almeno nella forma che essa ha avuto in passato». Nondimeno la descrisse come «condizione esistenziale» sia per i partiti dell’Internazionale sia «per quanto riguarda l’egemonia del proletariato e cioè il contenuto sociale dello Stato». Anche questo appare un richiamo all’ultimo Lenin e al tema della stabilità di uno Stato fondato su due classi. Chiaramente Gramsci pensava che l’unità garantita da Stalin fosse piú un problema che una soluzione, perché produceva una perdita in termini di idee e personalità. Perciò affermava essere «nostro scopo contribuire al mantenimento e alla creazione di un piano unitario nel quale le diverse tendenze e le diverse personalità possano riavvicinarsi e fondersi anche ideologicamente». Pure cosí riformulata, l’unità del «nucleo leninista» rappresentava ai suoi occhi «una questione della massima importanza nel campo internazionale» e anzi «dal punto di vista di massa, la questione piú importante in questo periodo storico». Ciò lo portava a formulare il tema dell’egemonia in una chiave internazionale:
Oggi, dopo nove anni dall’ottobre 1917, non è piú il fatto della presa del potere da parte dei bolscevichi che può rivoluzionare le masse occidentali, perché esso è già stato scontato ed ha prodotto i suoi effetti; oggi è attiva, ideologicamente e politicamente, la persuasione [se esiste] che il proletariato, una volta preso il potere, può costruire il socialismo. L’autorità del P[artito] è legata a questa persuasione, che non può essere inculcata nelle grandi masse con metodi di pedagogia scolastica, ma solo di pedagogia rivoluzionaria, cioè solo dal fatto politico che il P[artito] R[usso] nel suo complesso è persuaso e lotta unitariamente105.
In altri termini, Gramsci estendeva al «campo internazionale» la nozione dell’egemonia che aveva acquisito dal bolscevismo. Cosí facendo, offriva una versione dell’egemonia diversa dall’uso che gli stessi bolscevichi facevano di questo termine. Presupponeva infatti che l’egemonia e la forza simbolica della rivoluzione fossero distinte da una concezione di tipo militare della direzione politica e strategica. In questo senso, le sue parole rivelavano una resistenza all’assimilazione dei linguaggi bolscevichi e alla militarizzazione della cultura politica.
Quella di Gramsci poteva essere una speranza anacronistica, data l’escalation del conflitto politico in Russia, e persino una sopravvalutazione della dimensione culturale dei bolscevichi. È lecito chiedersi se Gramsci non restasse legato a una concezione del partito sovietico mitica e incongrua con la sua evoluzione106. La sua idea dell’unità del gruppo dirigente bolscevico sembrava ignorare la logica repressiva del partito-Stato nelle stesse élite politiche, che Lenin aveva incrementato e non allentato dopo la fine della guerra civile, al momento di varare il «capitalismo di Stato» della Nep, e che Stalin seguiva fedelmente107. La sua visione non presentava però soltanto l’aspetto di un intervento tardivo o illusorio, ma anche un altro aspetto piú realistico. A differenza di Togliatti e degli altri dirigenti cominternisti, Gramsci intuí che la rottura tra i successori di Lenin metteva a rischio il precario equilibrio politico e sociale della Nep. Come si doveva verificare poco piú di un anno dopo, quando Stalin avrebbe definitivamente gettato la maschera del moderato, iniziando la svolta verso una trasformazione gigantesca e violenta della società russa che nel 1926 non era neppure lontanamente all’ordine del giorno. Una «seconda rivoluzione» destinata ad avere cruciali riflessi sulle scelte internazionali dell’Unione Sovietica e del Comintern. In tal senso, le lettere di Gramsci dell’ottobre 1926 costituivano una profezia e un testamento, che seguiva il senso ultimo dell’internazionalismo cosmopolita degli anni Venti.
▲La presa di posizione di Gramsci era quanto mai atipica nel contesto del comunismo occidentale, quella di Togliatti costituiva invece un adeguamento senza riserve. Gramsci non era però volto ad affermare soltanto ragioni di principio e di politica nazionale del Pcd’I, cosí come Togliatti non faceva valere esclusivamente ragioni di disciplina. Il carteggio tra i due mostra la piena coscienza di essere componenti di un movimento mondiale e le argomentazioni svolte da entrambi mossero da questo punto di vista. Furono le rispettive idee sull’internazionalismo a divergere alla prova dei fatti, malgrado il bagaglio comune accumulato negli anni precedenti. Messo alle strette dalle circostanze, Gramsci si convinse che la frattura della vecchia guardia bolscevica potesse compromettere la risorsa simbolica rappresentata dallo Stato sovietico, quale condizione essenziale dell’egemonia internazionale. Togliatti non condivise questa persuasione e puntò invece sulla concreta solidità rappresentata dalla forza della maggioranza raccolta attorno a Stalin. L’arresto di Gramsci rimosse la questione stessa dal campo ottico dei comunisti italiani. La loro cultura politica avrebbe continuato a fondarsi sulla nozione dell’interdipendenza tra le dimensioni internazionale e nazionale, applicata all’analisi del fascismo e alla sua trasformazione in un regime totalitario, senza piú includere in questo quadro analitico e strategico gli interrogativi sul ruolo e il destino dell’Unione Sovietica.
Capitolo secondo
Stalinismo e antifascismo
1. La centralità dello Stato sovietico.
L’arresto di Gramsci, la messa fuori legge del Pcd’I e l’ascesa di Stalin furono il preludio alla disgregazione del gruppo dirigente italiano, faticosamente costruito negli anni precedenti. La coesione trovata tra gli ex ordinovisti e l’allargamento del loro gruppo al Congresso di Lione, culmine della lunga interazione conflittuale con Bordiga, venne meno proprio sul terreno dell’internazionalismo. Il conflitto tra Gramsci e Togliatti dell’ottobre 1926 non ebbe immediate conseguenze ma segnò ugualmente una svolta, che poneva fine ai tentativi di trovare una posizione intermedia tra le diverse correnti del comunismo internazionale e implicava una divergenza destinata ad allargarsi. Nei due anni successivi, la fine dell’alleanza tra Stalin e Bucharin si riverberò immediatamente su tutti i partiti comunisti e quello italiano non fece eccezione. I dirigenti italiani furono completamente colti di sorpresa dalla svolta di Stalin verso una radicale trasformazione della società sovietica e l’adozione di una linea estremista nel Comintern, dopo averlo sostenuto per motivi opposti nella sua lotta contro Trockij. Le loro diverse risposte furono una fonte di ulteriore disgregazione. A differenza di altri partiti comunisti, però, quello italiano non conobbe un’epurazione totale dei propri dirigenti. La figura di Togliatti rappresentò una continuità con l’epoca precedente, sebbene tra mille contraddizioni e adattamenti. La sua personalità si fece dominante e finí per stabilire un rapporto gerarchico con gli altri, in una dialettica di sfida e cooptazione della generazione piú giovane, avvalendosi del ruolo giocato negli organismi dirigenti del Comintern. Questa particolare dialettica tra una singola personalità e gli altri dirigenti doveva approfondirsi e continuare fino alla fine della Seconda guerra mondiale.
Prima ancora che la svolta totalitaria di Mussolini alla fine del 1926 mettesse il Pcd’I nell’illegalità e spingesse nell’esilio o in carcere il suo gruppo dirigente, la formazione internazionalista di Togliatti aveva conosciuto un passaggio decisivo. Le scelte da lui compiute lasciarono una traccia durevole e si rivelarono fatali alla luce del precipitare della situazione in Italia. Appena nominato rappresentante del Pcd’I al Comintern, Togliatti si trovò nella necessità di adottare una linea di condotta dinanzi all’escalation del conflitto nel partito russo. Non era certo privo di conoscenze circa l’evoluzione della politica sovietica, né gli faceva difetto la conoscenza personale di esponenti cominternisti quali Manuiłskij. Ma scontava come tutti i comunisti europei i limiti di un’informazione selettiva e approssimativa. La sua attività fu quasi interamente assorbita dalla vicenda politica russa, che delimitava i confini dell’internazionalismo stabilendo canoni sempre piú stretti e vincolanti. Bucharin divenne il suo interlocutore principale quando assunse di fatto la guida del Comintern1. Come appare evidente dalla sua corrispondenza con Roma, Togliatti prese atto della logica di schieramento che gli stessi protagonisti sovietici suggerivano nel loro infiammato scontro politico e si fece portavoce delle linee di condotta indicate dalla maggioranza raccolta attorno a Stalin e Bucharin. Nello stesso tempo, consolidò il ruolo svolto dai comunisti italiani quali analisti del fascismo. Sulla stampa del Comintern, respinse le definizioni generiche di fascismo, che attribuivano al termine «un senso troppo generale e troppo astratto». Il suo intento non era quello di presentare il fascismo come un fenomeno eccezionale e circoscritto all’Italia, rimarcandone la specifica complessità sociale ed ecletticità ideologica. Egli invitò piuttosto a distinguere sul piano analitico gli aspetti connessi alle peculiarità storiche del paese, a cominciare dalla debolezza dello Stato liberale e dalla crisi particolarmente profonda dell’immediato dopoguerra, e quelli che potevano invece presentare un significato anche per altre realtà nazionali. Togliatti indicò cosí nel fascismo un problema internazionale, non soltanto italiano, ma avvertí che solo un’analisi differenziata poteva fornire gli strumenti per la sua comprensione2.
Tuttavia nell’ottobre 1926, come sappiamo, il gruppo dirigente si spaccò sul tema dell’internazionalismo. La forzatura compiuta da Gramsci, che criticò tutti gli attori in scena dopo Lenin, in nome di valori e principî superiori, unitari ed egemonici, costrinse Togliatti a esprimere piú nettamente un proprio punto di vista. Si dipartirono da qui visioni divergenti, non perché fosse in discussione l’opzione strategica del «socialismo in un solo paese», e neppure elementi basilari di analisi del fascismo e della situazione internazionale, ma perché l’esigenza di conciliare gli interessi di sicurezza dell’Unione Sovietica con la rivoluzione mondiale poteva essere declinata in modi diversi. La scelta fatta da Togliatti, di seguire e giustificare senza riserve la linea e la condotta della maggioranza staliniana, fu un dato irreversibile. La personalità di Togliatti emerse pienamente allora. Egli divenne il capo di un gruppo di emigranti politici che operavano tra Parigi e Mosca, ma si affermò anche come un dirigente del comunismo internazionale. Sin dai suoi interventi al VII Plenum del Comintern, nel novembre-dicembre 1926, Togliatti propose una visione che elaborava i principali aspetti analitici e strategici condivisi dal gruppo dirigente italiano, allineandoli però strettamente alla ragion di Stato sovietica. La sua insistenza sulla «stabilizzazione» capitalistica e sulla sconfitta storica del movimento operaio non gli impedí di seguire le orme di Gramsci circa gli scenari del fascismo. «L’esperienza italiana», affermò, «ha un valore internazionale», in quanto dimostrava che il tentativo di «stabilizzare il capitalismo» mobilitando «alcuni strati medi sulla base della lotta contro la classe operaia e come base di un nuovo regime» generava contraddizioni «molto piú gravi dei vantaggi che procura». Egli evocò persino il ritorno a una situazione rivoluzionaria paragonabile a quella del 1919-20. Nello stesso tempo, affermò «l’identità tra la rivoluzione russa e la rivoluzione mondiale», citando quasi letteralmente, senza menzionarla, la lettera inviatagli da Gramsci il 26 ottobre 1926 circa l’esigenza di mantenere attiva, nella coscienza di massa, la persuasione che «in Russia dopo aver conquistato il potere, il proletariato può costruire il socialismo». Tuttavia, seguí la priorità della difesa dello Stato sovietico. Persino in Italia, dichiarò, «quando organizziamo illegalmente il nostro partito», il risultato di tale lavoro era «aiutare direttamente il proletariato russo nella costruzione del socialismo»3.
Togliatti sviluppò cosí il punto essenziale della sua risposta a Gramsci del 18 ottobre 1926, la dissociazione fra il tema dell’unità del gruppo dirigente sovietico e il tema dell’internazionalismo. Nell’aprile 1927, forní ai quadri italiani una ricostruzione della storia del bolscevismo tutta incentrata sulla nozione dell’«egemonia del proletariato» sui contadini, presentandola come una bussola infallibile del leninismo. Indicò nel «giusto regime interno di partito» la condizione per esercitare tale egemonia e censurò l’opposizione trockista sia per la sua tendenza a costruire «fazioni» disgregatrici sia per la sua fallace inclinazione a postulare «il ritorno di una situazione rivoluzionaria immediata»4. La sua visione processuale della rivoluzione, che rifletteva le ineguaglianze dello sviluppo capitalistico, si pose nel solco di Gramsci. La nozione di egemonia non era invece quella gramsciana: anche se rimandava alla capacità di direzione, non si applicava alla funzione internazionale del gruppo dirigente sovietico. Togliatti si adattò cosí a un nesso con lo Stato sovietico molto piú vincolante che in passato. Continuò però a presentare l’analisi del fascismo quale contributo primario degli italiani, insistendo sulla specificità del fenomeno ma anche sulle sue conseguenze piú generali. Recatosi a Parigi per costituire il Centro estero del partito all’inizio del 1927, scrisse sul fascismo come un fattore che intensificava le tensioni dell’Europa capitalistica e la spingeva verso la guerra. L’Italia di Mussolini era «un paese capitalistico che tende con tutte le sue forze a risolvere con la guerra le sue contraddizioni interne»5.
Come è stato notato, la visione proposta da Togliatti fuoriusciva dai canoni piú stretti della teoria leniniana dell’imperialismo e non era molto lontana da quella di Rudolf Hilferding e di altri capi della socialdemocrazia europea, nel ritenere che le minacce internazionali fossero generate piú dall’Italia fascista che non dalle grandi potenze occidentali vincitrici della guerra6. Allo stesso tempo, egli dipingeva l’Europa come «un immenso campo trincerato», ponendo un’enfasi sul pericolo di guerra che invece respingeva le tesi socialdemocratiche e relativizzava una volta di piú la «stabilizzazione» del capitalismo postbellico. Il «socialismo in un solo paese» in Russia e la crescita del movimento rivoluzionario in Cina costituivano i due vettori principali di una prospettiva di crisi del capitalismo mondiale7. Qui Togliatti non faceva altro che ricalcare le tesi di Bucharin, secondo il quale il capitalismo mondiale non sarebbe stato in grado di accerchiare l’Unione Sovietica e al tempo stesso contenere la «rivoluzione nazionale antimperialista» in Cina, destinata ad accelerare il declino dell’impero britannico8.
Lo scenario di una rivoluzione cinese destinata a riscattare la fallita rivoluzione europea subí un colpo mortale nell’aprile 1927. Il massacro dei comunisti a Shanghai, attuato dai nazionalisti sotto la guida di Chiang Kai-shek, apparve subito una sconfitta drammatica. La visione dalle «tre leve» del movimento rivoluzionario proposta da Bucharin (la classe operaia britannica, la rivoluzione cinese e la stessa Unione Sovietica) non resse alla prova dei fatti. Con il collasso dello scenario di rivoluzione mondiale che tutti i bolscevichi avevano immaginato, sia pure con toni e accenti diversi, il tema della difesa dell’Unione Sovietica era destinato a farsi ancora piú stringente. I leader della maggioranza staliniana lanciarono un autentico allarme di guerra, condiviso dagli oppositori. In assenza di un movimento rivoluzionario che agisse da deterrente all’imperialismo, questo l’assunto fondamentale, l’Unione Sovietica isolata rischiava di subire un’aggressione, ancor piú dopo la rottura delle relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna e la cooptazione della Germania nella Società delle Nazioni. Trockij attribuí a Stalin la responsabilità di questa situazione, ma fu il secondo a trarre profitto dall’allarme di guerra, usando l’accusa di disfattismo per liquidare definitivamente l’opposizione9.
Da questo momento in avanti, la priorità della difesa dell’Unione Sovietica conobbe una decisa accelerazione. Togliatti declinò a suo modo il nuovo canone internazionalista. Tra coloro che trassero subito le implicazioni piú generali del fallimento rivoluzionario in Asia, egli si distinse per l’argomentazione svolta all’VIII Plenum del Comintern nel maggio 1927. Propose infatti di mettere al centro della strategia del Comintern la «lotta per la pace» sostenendo che ciò avrebbe potuto creare un «legame diretto» tra «la politica dello Stato operaio» sotto la minaccia del «fronte unico degli imperialisti» e i «profondi sentimenti di massa contro la guerra»10. Pur avendo egli stesso posto il tema all’ordine del giorno, Bucharin respinse la proposta della delegazione italiana con l’argomento che essa non si poteva applicare alla Cina, dove era in corso una «guerra rivoluzionaria»11. Bucharin continuava a riporre speranze nella rivoluzione cinese, malgrado il disastro di Shanghai, mentre Togliatti si posizionò diversamente. Il gruppo dirigente italiano non aveva mai creduto troppo nello scenario della «rivoluzione asiatica». Togliatti proponeva invece di sfidare i socialisti europei sul terreno stesso della loro agenda internazionale «pacifista», che dopo gli accordi di Locarno si incentrava sul tema del disarmo, collegato alla Società delle Nazioni, con forti contrasti e differenze nazionali tra i principali partiti12. La prospettiva di un «pacifismo» comunista si poteva coniugare con gli interessi dell’Unione Sovietica, che aderí all’iniziativa Briand-Kellogg per il disarmo e parve cosí aprire una convergenza tra diverse culture internazionaliste13. Implicava anche una visione non esclusiva dell’internazionalismo comunista e l’obiettivo di contendere alla socialdemocrazia il consenso delle masse lavoratrici, liquidando la minorità dei partiti comunisti europei. Entrambe le prospettive sarebbero rimaste un tratto distintivo della personalità di Togliatti.
Nella congiuntura della fine degli anni Venti, si impose però la visione dell’inevitabilità della guerra, basata sulla dottrina leniniana dell’imperialismo. Il suo assunto principale era che i comunisti dovevano mobilitarsi contro una guerra incombente, mentre l’idea di prevenirla sarebbe stata illusoria e impraticabile. La campagna sul pericolo di guerra si intensificò con il collasso dello scenario rivoluzionario globale nell’estate 1927, dopo la rottura definitiva tra il Comintern e il Guomindang, il partito nazionalista cinese, e la repressione sanguinosa degli scioperi operai a Vienna. Stalin enunciò allora il principio dell’identificazione tra l’internazionalismo e la difesa dell’Unione Sovietica. Alla fine dell’anno, mise l’accento sull’«accerchiamento capitalistico» e liquidò la nozione della «stabilizzazione capitalistica», prevedendo nuove crisi, rischi di guerra e la fascistizzazione dei governi borghesi. La sua non era una profezia rivoluzionaria ma piuttosto un’enfasi senza precedenti sulla centralità dell’Unione Sovietica quale «fattore di disgregazione» dell’imperialismo mondiale. Cosí svincolò la propria figura politica dalla concezione moderata del «socialismo in un solo paese»14.
Togliatti seguí le coordinate di Stalin. Nella sua relazione del gennaio 1928 alla II Conferenza del Pcd’I, tenutasi a Basilea, liquidò le idee sul «capitalismo organizzato» e, in gran parte, la stessa visione della «stabilizzazione capitalistica». «Se la Russia si sviluppa verso il socialismo» sosteneva ora Togliatti, «il mondo capitalistico non può stabilizzarsi, perché gli manca una parte di sé stesso», senza contare che il fatto stesso della rivoluzione rappresentava «un elemento di disgregazione della economia capitalistica per l’autorità che la Russia ha sulle masse lavoratrici del mondo intiero». Togliatti dipingeva un mondo dominato da conflitti esplosivi di due tipi: quelli tra Stati capitalistici, nei quali si inseriva la bellicosità del fascismo italiano, classicamente destinati a sboccare in guerre coloniali e generali, e quello fondamentale tra le potenze imperialistiche e la Russia sovietica. La parola d’ordine del movimento comunista era ormai la «lotta contro la guerra», che significava serrare le file attorno all’Unione Sovietica privilegiando l’agitazione sulla politica15. Sull’esempio di Stalin, Togliatti non modificava gli idiomi e il vocabolario dei comunisti, ma li impiegava in un modo selettivo e semplificato. La traiettoria di Togliatti si allineava cosí a quella di tutti i dirigenti del comunismo internazionale. Nel caso del gruppo dirigente italiano, la soluzione di continuità appare particolarmente rilevante. Gramsci aveva infatti sempre evitato il determinismo catastrofista e sostanzialmente ignorato la teoria dell’inevitabilità della guerra. L’approccio dell’«analisi differenziata» fu difeso, oltre che da Togliatti, anche da Tasca nei suoi contributi sulla compresenza di modernizzazione e arretratezza nell’economia italiana, sulla ristrettezza delle basi dell’imperialismo fascista e sul ruolo finanziario degli Stati Uniti16. Tuttavia, tale approccio rischiava di essere in gran parte compromesso dalla visione indifferenziata delle potenze capitalistiche sul piede di guerra.
Il VI Congresso del Comintern, nel luglio 1928, si svolse all’insegna del pericolo di guerra e della difesa dell’Unione Sovietica. Bucharin abbracciò una linea radicale che liquidava alcune delle sue stesse posizioni precedenti sul «capitalismo organizzato». Seguendo l’evoluzione del gruppo dirigente bolscevico, Togliatti si appellò alla «consapevolezza dell’inevitabilità della guerra» e aderí alla teoria staliniana dell’«intensificazione della lotta di classe»17. L’unico elemento di «analisi differenziata» difeso dal leader italiano era rappresentato dal suo invito a non generalizzare il fenomeno del fascismo e a evitare analogie troppo disinvolte tra fascismo e socialdemocrazia. Egli ricordò che il fascismo «come movimento di massa» combinava le aspirazioni e gli interessi delle classi medie e della grande borghesia, mentre la socialdemocrazia conservava un’influenza maggioritaria nella classe operaia europea. Su questo terreno, continuò a esercitare il proprio realismo a dispetto dell’immaginario della guerra che dominava la retorica comunista, senza alcun fondamento nelle dinamiche internazionali.
L’allineamento di Togliatti non giunse ad accogliere la teoria del «socialfascismo», che dall’estate 1928 in avanti prese campo nel discorso comunista. Stalin aveva teorizzato l’analogia tra socialdemocrazia e fascismo sin dal 1924 e mostrato una sostanziale incomprensione del fenomeno fascista18. Accogliere la teoria del «socialfascismo» equivaleva a gettare al vento l’elaborazione del gruppo dirigente italiano negli anni precedenti circa la specificità del fascismo19. Togliatti stigmatizzò le tendenze a designare come tale «ogni forma di reazione», mentre invece esso rappresentava «una forma particolare, specifica della reazione». La specificità dell’Italia era «l’unità politica» che le diverse componenti del capitalismo italiano avevano cercato nel fascismo per rimediare ai propri limiti storici. Ciò aveva prodotto una trasformazione del movimento in un regime dotato di basi di massa e volto a costruire uno Stato totalitario. Nella scia del Gramsci di due anni prima, Togliatti riteneva improbabile che il fascismo potesse svilupparsi in un paese a capitalismo avanzato e che le sue potenzialità di diffusione internazionale fossero limitate alla periferia dell’Europa, come ad esempio in Polonia. Piú che in passato, circoscriveva il fascismo all’Italia. Questa era soprattutto una linea di difesa contro le tendenze sempre piú forti a identificare lo sviluppo del capitalismo e della socialdemocrazia nell’esito della fascistizzazione20.
Al Congresso Togliatti fu incaricato di intervenire, nella veste di dirigente del Comintern, con un rapporto sulla socialdemocrazia e la «questione coloniale», un tema insolito per lui, anche se si era occupato negli anni precedenti di Cina e di America Latina. I paesi latinoamericani non potevano essere catalogati nella «questione coloniale» ma costituivano un anello di collegamento analitico e strategico sul piano globale. In particolare, Togliatti vedeva il Brasile come teatro di una possibile «alleanza» tra operai e contadini, sul modello delle Tesi di Lione21. La nuova rivista del Pcd’I stampata a Parigi dal marzo 1927, «Lo Stato Operaio», aveva dedicato sin dall’inizio attenzione al tema della lotta anticoloniale, in particolare con un commento di Tasca al Congresso della Lega antimperialistica fondata da Willi Münzenberg22. Nel luglio 1928, Grieco presentò un rapporto alla «commissione dell’Oriente prossimo» del Comintern, nel quale riconosceva che le tesi sulla «questione coloniale» approvate a Lione erano rimaste lettera morta, ma rilanciava le possibilità di un’attività dei comunisti italiani in Tunisia, con il sostegno dei francesi, e in Libia23. In realtà, la prospettiva di Togliatti nel suo rapporto al Congresso fu assai piú incentrata sull’Europa che sul mondo coloniale24. Egli trattò la questione come un punto debole dei socialdemocratici quale forza subalterna al sistema imperiale europeo. L’argomentazione rifletteva le feroci polemiche del decennio trascorso, ma evidenziava le ambivalenze dell’Internazionale socialista, oscillante tra le prevalenti istanze di riforma del sistema coloniale e le idee di indipendenza nazionale. Alla fine degli anni Venti, l’anticolonialismo del Comintern aveva messo sulla difensiva i socialisti europei, che erano emarginati dai vivaci ambienti antimperialisti attivi nelle metropoli imperiali, Londra e Parigi25. Togliatti criticava però anche le insufficienze delle pratiche e analisi comuniste, malgrado la coscienza del potenziale legame tra l’esperienza sovietica, l’azione antimperialista e la crisi del sistema coloniale europeo26. Una simile visione non ebbe seguito a causa della repentina caduta di Bucharin e dell’emarginazione di Münzenberg, che doveva segnare il capolinea dell’idea leniniana di un’alleanza con le élite coloniali in nome dell’autodeterminazione27. Una vera e propria strada non presa, destinata a riemergere come un fiume carsico soltanto molti anni dopo, nel contesto della decolonizzazione.
Togliatti incaricò Tasca di rappresentare il Pcd’I nel Comintern e gli suggerí di collaborare con Bucharin, che giudicava «il solo che pensa […] che cerca di vedere gli elementi nuovi della situazione»28. Entrambi, tuttavia, realizzarono presto come il VI Congresso avesse segnato un compromesso molto fragile tra Stalin e Bucharin. Le notizie inviate da Tasca a Parigi segnalavano la crescente tensione tra i due leader bolscevichi che spaccava il Politbjuro e paralizzava il Comintern. All’inizio di dicembre, Tasca affermò tra l’altro che l’Esecutivo era «lontanissimo dal meritare la definizione di «stato maggiore della rivoluzione», perché non svolgeva alcun ruolo dirigente. Togliatti lo invitò a moderare i suoi giudizi di forte insofferenza per il clima cospiratorio ormai dominante. Ma il problema era anche costituito dalla crescente percezione di un cambiamento politico imposto da Stalin e rivolto a radicalizzare la linea del Comintern, destinato a ripercuotersi anche sul partito tedesco e su tutti gli altri. Tasca finí per dichiarare che il suo disaccordo non era sanabile e che la sua permanenza a Mosca non aveva piú ragion d’essere29. Il 17 dicembre Togliatti gli scrisse, dopo una riunione del Comitato centrale tenutasi in Svizzera alla presenza di Manuiłskij, che la posizione dei comunisti italiani restava legata alla difesa della linea del Congresso e che i problemi politici dovevano porsi «in prima linea», anche se il tema del «regime interno» aveva un suo rilievo. Egli si dichiarava d’accordo «nella sostanza» con Tasca e lo informava che nessuno aveva invece condiviso quanto riportato da Manuiłskij circa l’impossibilità di una composizione nel partito tedesco, da mesi al centro delle accuse contro la «destra»30.
La svolta radicale si verificò due giorni dopo, quando Stalin lanciò un feroce attacco contro la «deviazione di destra» nel partito tedesco, che preludeva a una vasta epurazione nei suoi ranghi. In tale occasione, tra l’altro, Stalin pronunciò parole pesanti all’indirizzo di Humbert-Droz e di Tasca, accusati di «opportunismo»31. Stalin mostrò allora un’immagine inconciliabile con quella del ponderato realista coltivata sino a poco prima e coerente invece con le scelte estreme compiute adottando «misure eccezionali» e requisizioni violente contro i contadini, che compromettevano il rapporto città-campagna stabilito dalla Nep. Il nesso tra la deriva del Comintern, la crisi della Nep e il crescente conflitto all’interno dell’ex maggioranza del Partito comunista sovietico si fece allora percepibile. Da quel momento in avanti, si verificò un declino del ruolo del Comintern e un degrado del suo ambiente cosmopolita, conseguenza della liquidazione non soltanto degli oppositori di sinistra ma anche dei moderati. Una perdita secca in termini di personalità e menti politiche, ma soprattutto uno scivolamento rapido verso forme di intolleranza, disciplinamento e censura sino allora sconosciute. Il lancio della “rivoluzione dall’alto” in Unione Sovietica, con la svolta verso una modernizzazione industriale forzata e la collettivizzazione violenta delle campagne, portò nel movimento comunista una escalation dell’estremismo verbale, del settarismo e del catastrofismo, retoricamente rivolti a dichiarare la continuità del concetto di rivoluzione mondiale, ma integralmente orientati dalle priorità dello Stato e dal «pericolo di guerra».
La rottura tra Togliatti e Tasca ricalcò il modello di epurazione dei moderati seguito anche in altri partiti. Fu però molto tormentata. Togliatti criticò duramente Tasca già alla fine di dicembre, dicendogli che se i suoi giudizi fossero stati giusti non restava che pensare a «una ricostruzione dell’Internazionale dal basso»32. Cercò però di evitare decisioni drastiche. All’inizio di gennaio 1929, Manuiłskij scrisse a Stalin che le misure prese sulla Kpd avrebbero aiutato anche gli italiani, spiegandone i «barcollamenti» con il fatto che «vivono un po’ al di fuori della grande via del movimento comunista». Gli riferí poi lo svolgimento di una riunione con gli italiani e i tedeschi, il 12 gennaio 1929, alla presenza degli emissari cominternisti Kolarov e Georgi Dimitrov. A suo giudizio, l’intervento di Togliatti era stato «affabile» con l’obiettivo di evitare una vera discussione e «diplomatizzare» i problemi. Questi aveva insistito per rimandare a una riunione del Pcd’I il chiarimento con Tasca, colpevole di avere rotto il canone dell’unanimismo e criticato il metodo repressivo usato dall’Ikki verso il partito tedesco, ricevendo una dura reprimenda di Stalin in persona. Togliatti aveva anche fatto notare che egli stesso, Tasca e Grieco rappresentavano ciò che restava della «vecchia guardia». Proprio queste parole, secondo la lettera di Manuiłskij, avevano infiammato il confronto e portato il delegato sovietico a dire che gli italiani sgusciavano «come un pesce bagnato» dalle mani. Egli riteneva che il problema fosse rappresentato dalla loro perdita di contatto con i «movimenti di massa» e suggeriva che si trasferissero in Germania e non in Svizzera33.
L’argomento di Togliatti sulla «vecchia guardia» del partito, che egli sapeva bene essere irricevibile e persino controproducente, tradiva un nervo scoperto, forse anche emotivamente, e rivelava la preoccupazione reale di un mutamento generazionale e politico irreparabile. Ciò però non gli impedí di adeguarsi alla stalinizzazione del Comintern. La traiettoria critica presa da Tasca proprio nel momento delle esitazioni del gruppo dirigente rese la situazione insostenibile. In una lettera del 20 gennaio, egli dipinse un ritratto di Stalin impietoso e realistico, fuori da ogni canone accettabile dopo il 1927 («Tutta la situazione gravita su Stalin. L’Ic non esiste; il Pc dell’Urss non esiste; Stalin è il “maestro e donno” che muove tutto»). Come Trockij e molti altri, probabilmente sottovalutava le qualità politiche di Stalin, presentato come una mediocrità e un «rimasticatore di idee» non all’altezza dei problemi della rivoluzione, che avrebbe danneggiato in modo fatale34. Il giudizio sul carattere dispotico e autocratico di Stalin metteva però il dito nella piaga e faceva saltare ogni possibile composizione. Posto nella condizione di scegliere tra Stalin e Tasca, Togliatti poteva soltanto optare per il primo. La requisitoria svolta da Togliatti nel Comitato centrale del partito del marzo 1929 pose fine alle esitazioni e segnò un punto di non ritorno. Togliatti adottò un codice inconfondibile, indicando nel «pericolo di guerra» il nodo «di tutte le contraddizioni che sono insite nel mondo capitalistico nel momento presente»35. Il sottotesto era che si dovesse evitare la saldatura tra i piani di guerra delle potenze capitalistiche e l’influenza della «destra» a Mosca e nel movimento comunista. Come egli stesso aveva rilevato nella sua corrispondenza con Tasca dei mesi precedenti, in mancanza di una rivoluzione «in Europa o nelle colonie», la pressione della «destra» quale espressione della «borghesia» piccola o media nelle campagne e nelle città dell’Unione Sovietica era destinata ad accrescersi36. Togliatti aveva mantenuto tutta la prudenza possibile ma disponeva anche degli argomenti per legittimare il giro di vite staliniano in Unione Sovietica e la fine della Nep, liquidando cosí le posizioni sulla «alleanza tra operai e contadini» prese all’epoca di Lione37. Il 22 aprile Stalin lanciò il suo definitivo attacco contro Bucharin al Plenum della Vkp(b), accusandolo di avere le stesse posizioni dei socialdemocratici sulla «stabilizzazione del capitalismo», e si scagliò contro i tedeschi e i cecoslovacchi, risparmiando altri partiti38. Ma il segnale era chiaro per tutti.
Al X Plenum del Comintern, nel luglio 1929, Togliatti fece ammenda per il ritardo del Pcd’I nella condanna dell’«opportunismo» nelle proprie file. Egli seguí un duplice registro. Da un lato, appoggiò senza riserve la svolta in atto in Unione Sovietica, dichiarando che sarebbe stato utile «collegare di piú i dibattiti sulle questioni internazionali a quelli sulle questioni politiche del Partito comunista russo», e citando Stalin («nelle brusche svolte c’è sempre qualcuno che cade dal carro e rimane disteso»)39. Dall’altro lato, la sua linea di difesa, insieme a Grieco, si attestò sulla riluttanza ad accogliere la tesi del «socialfascismo». Togliatti si piegò allora alla disciplina cominternista rivendicando però la differenza fra una teoria dell’«eccezionalismo» e un’analisi delle specificità nazionali. Egli dichiarò che «poiché non si può impedire di pensare, serberemo queste cose per noi e ci limiteremo a fare delle affermazioni generali»40. Subito dopo, in una lettera al nuovo capo della Kpd stalinizzata, Ernst Thälmann, confermò il pieno adeguamento della delegazione italiana contro gli atteggiamenti «conciliatori»41. Questa condotta è stata solitamente interpretata come un tentativo di salvare il salvabile della linea nazionale, cedendo sulle questioni internazionali, e come la conseguenza della grave difficoltà creata dalla disgrazia di Bucharin, il principale referente di Togliatti42.
Ma forse essa va vista in una luce diversa. La difficoltà di Togliatti non nasceva infatti solo dalla caduta di Bucharin, ma anche dal radicale cambiamento politico di Stalin, percepito sino a poco prima come il vero garante dei «realisti» e ora promotore di visioni ultraradicali tanto nella politica interna quanto nella politica internazionale. Ciò significa che il cedimento di Togliatti fu molto piú rilevante e non si limitò alla contingenza del 1929. La sua dichiarazione programmatica di dissimulazione, fatta al X Plenum, ci appare come una metodologia per cui la maggiore o minore convinzione in una linea politica doveva tenersi distinta dalla lealtà costitutiva, ideologica e istituzionale. Il problema non era piú di guardare alla linea politica, come Togliatti aveva suggerito prima a Gramsci e poi a Tasca. Stalin rappresentava la personalità centrale dello Stato bolscevico e si rivelava l’artefice di politiche molto diverse tra loro. La posizione espressa da Togliatti tra lealtà e dissimulazione non rispecchiava l’internazionalismo degli anni precedenti, con le sue oscillazioni di conformismo e dissenso, ma l’adesione alla nuova “costituzione materiale” del comunismo mondiale, cioè un salto di qualità della fede indiscussa nel partito-Stato e nel suo capo, destinata a durare nel tempo.
Con l’espulsione di Tasca nel settembre 1929, si consumò la disgregazione del nucleo dirigente del Pcd’I formatosi nella lotta politica con Bordiga, legittimato da Mosca e consolidatosi attorno alla metà degli anni Venti. Ciò implicava anche l’impoverimento e la dispersione di un patrimonio politico e intellettuale. Con Gramsci, Terracini e Scoccimarro in carcere, il principale superstite politico, Togliatti, doveva continuare a essere il capo riconosciuto senza davvero presiedere alla formazione di un nuovo gruppo dirigente nel successivo decennio di ferro e di fuoco. I comunisti italiani rimasero a lungo nel mirino del Comintern. La loro interazione con Mosca provocò nuove lacerazioni e fallimenti, esasperando la condizione dell’esilio. Lo stesso Togliatti si trovò a fronteggiare dure critiche personali, forse perché era rimasto l’unico leader di un importante partito europeo a non essere nominato direttamente da Mosca. Di certo egli non rientrava nel novero dei piú ciechi seguaci di Stalin, per motivi intellettuali e generazionali. La nuova generazione di giovani forgiata dopo Lenin, poi nel contesto della “rivoluzione dall’alto” in Unione Sovietica e della Grande Depressione in Occidente, presentò caratteri diversi, illustrati efficacemente da Eric J. Hobsbawm nelle sue memorie. La loro esperienza formativa postrivoluzionaria implicava non soltanto una scelta di vita e l’adesione a un principio di lealtà, ma una mentalità incentrata sul dogmatismo ideologico, sull’operatività militarizzata e sul «dramma del sacrificio»43. Questa generazione era rappresentata nel comunismo italiano da figure come Luigi Longo e Pietro Secchia, cresciuti nell’organizzazione giovanile nazionale e in quella internazionale. Sin dal 1928 entrambi avanzarono sulla scena come adepti del nuovo vangelo stalinista. Togliatti seppe mantenere una distanza gerarchica dalla nuova generazione, evitando che si formasse un autentico gruppo dirigente in grado di soppiantare anche lui. Ciò non significa che egli non condividesse con gli altri le principali prospettive discendenti dalle scelte di Stalin, che implicavano una visione del mondo incentrata sull’esistenza dell’Unione Sovietica come Stato socialista, come grande potenza e come società non capitalistica in costruzione, assediata dall’imperialismo occidentale. La peculiarità di Togliatti consistette nell’evitare una mera deduzione degli orientamenti politici dalle motivazioni ideologiche, tenendo insieme elementi tra loro spesso contraddittori.
Prendendo le mosse dall’attacco a Tasca, Longo e Secchia si impegnarono a fondo nella radicalizzazione politica imposta dal Comintern stalinizzato, in vista di un immaginario «terzo periodo» che avrebbe dischiuso le porte della rivoluzione anche in Italia. Essi si fecero portatori dell’idea di un «ritorno in Italia» dalla fine del 1929 in avanti, nella persuasione che si dovesse pagare qualunque prezzo pur di ricreare un legame organizzato nel paese. Togliatti li appoggiò, rovesciando le posizioni sostenute negli anni precedenti44. Il costo umano pagato fu allora giustificato con l’obiettivo del contatto con il paese, un argomento controverso destinato a rimanere nella memoria comunista e rilanciato retrospettivamente alla luce della Resistenza45. Quel che appare evidente è che nell’immediato la spinta a costruire una rete clandestina nel paese, inseguendo il fantasma di rivolgimenti rivoluzionari, equivalse quasi a un suicidio delle poche migliaia di quadri rimasti, facendo del Pcd’I un partito di carcerati piú che di cospiratori. Coloro che vi si opposero, come i «tre» (Alfonso Leonetti, Pietro Tresso e Paolo Ravazzoli) e Ignazio Silone, furono espulsi dal partito nel 1930. La stalinizzazione del partito era cosí compiuta nel contesto di una vasta epurazione internazionale, che colpí dirigenti del calibro di M. N. Roy46. Togliatti fu uno dei pochi a salvarsi tra coloro che erano stati vicini a Bucharin. La sua posizione uscí rafforzata dall’identificazione dei dissidenti come seguaci di Trockij.
Un’ombra molto simile emanava dal dissenso di Gramsci e di Terracini in carcere verso la linea «classe contro classe», che si precisò nell’estate 1930. Terracini scrisse una lettera che poneva in rilievo tutta la differenza tra il momento della «svolta» e la pratica politica precedente («fino alla fine del 1926 vi era stato nel Centro un elemento ispiratore e coordinatore rappresentato da Antonio che, nei suoi periodici colloqui con ognuno di noi, quasi inavvertitamente operava a mantenerci su una linea comune di pensiero»). A suo giudizio, la tendenza a identificare fascismo e capitalismo riproponeva «i concetti di Bordiga, già cosí fieramente combattuti»47. Gramsci stigmatizzò la propria emarginazione in un incontro del luglio 1930 con il fratello Gennaro. Egli espresse chiaramente allora una visione del fascismo opposta a quella prospettata dalla «svolta» del Comintern. Nel suo resoconto per il partito, Gennaro riferí di aver ipotizzato, rispondendo a una precisa domanda, che la possibilità di rivedersi in libertà fosse prossima, data la «crisi» internazionale e italiana. La replica di Gramsci, che si disse ben informato tramite la lettura della stampa, fu molto pessimistica («non credo che la fine sia cosí vicina. Anzi ti dirò, noi non abbiamo ancora visto niente, il peggio ha da venire»). Per la prima volta, egli avanzò anche dubbi molto gravi circa l’atteggiamento dei propri compagni, riferendosi in particolare a una lettera di Grieco risalente al 1928 che poteva avere recato un danno alla prospettiva di una sua liberazione prevedendo che si sarebbe verificata in tempi brevi48. Di qui si doveva dipartire un graduale ma irreversibile distacco di Gramsci dal partito. Contemporaneamente, i suoi ex compagni scelsero di isolarlo per evitare le ripercussioni della sua opposizione al Comintern e salvaguardare, verosimilmente, tanto se stessi quanto il prigioniero. Il IV Congresso, tenutosi a Colonia nell’aprile 1931, ne canonizzò la figura di martire e icona della lotta al fascismo, occultandone il dissenso. Le campagne per la sua liberazione condotte dal Pcd’I fecero di lui un eroe dell’antifascismo, ma ai suoi occhi pregiudicarono le possibilità di un’autentica trattativa o di un’amnistia. Le fratture del gruppo dirigente italiano, in altri termini, non furono soltanto una conseguenza del Tribunale speciale di Mussolini, ma il frutto di una serie di conflitti politici generati dal rapporto con il bolscevismo e con il Comintern, pur nel contesto di un’appartenenza e un’identità comuni49.
Il terreno piú scivoloso per Togliatti era costituito dai suoi tentativi, per quanto cauti, di tenere fermi elementi di realismo nel giudizio politico. È indicativo che subito dopo il Congresso di Colonia, svoltosi all’insegna dell’ortodossia, ma senza troppa enfasi sulle prospettive della rivoluzione imminente, egli venne duramente criticato dal rappresentante dell’Ikki, Leon Purman. In un rapporto a Manuiłskij e a Pjatnickij, questi lo accusò di avere usato argomenti «pericolosi in modo estremo»: vale a dire, di aver rammentato la discussione del 1923 sulla Germania senza tenere conto della «nuova situazione internazionale». Il rapporto venne inviato al capo del Comintern e fedelissimo di Stalin, Vjačeslav Molotov50. La critica alludeva evidentemente alle insidiose analogie che si potevano stabilire tra il fallimentare «ottobre tedesco» e il radicalismo settario del presente, che nella Germania della Grande Depressione sperimentava il suo banco di prova e annunciava risultati persino peggiori di allora. Forse a conoscenza delle critiche, Togliatti cedette alle pressioni di Mosca, sebbene con riluttanza, esprimendo un appoggio alla scelta della Kpd di partecipare al plebiscito dell’agosto 1931 in Prussia, che di fatto configurava una convergenza tra comunisti e nazisti contro il governo regionale socialdemocratico51. Nelle sue analisi, accentuò la distinzione tra il fascismo italiano e il nazionalsocialismo tedesco. Sostenne infatti nel settembre 1932, al XII Plenum del Comintern, che era sbagliato vedere nel fascismo italiano il modello «classico» e concludere che «la linea di sviluppo del fascismo italiano» si potesse considerare come «una linea classica obbligatoria in tutti i paesi». Tale visione differenziata era nelle sue corde, ma in questo caso mirava soprattutto a evitare di equiparare la situazione della Germania a quella dell’Italia. In altre parole, Togliatti seguiva gli imperativi del Comintern circa l’imminente crisi rivoluzionaria in Germania ma non faceva lo stesso quanto all’Italia52.
Il tratto politico della sua personalità si rifletté nella scarna autobiografia scritta nell’agosto 1932, secondo la prassi adottata dal Comintern come procedura di controllo burocratico e ideologico. Togliatti non concedeva niente alle motivazioni ideali, illustrando il proprio percorso con una serie di informazioni selettive. Queste erano soprattutto significative per le clamorose omissioni, che mutilavano la stessa identità ed eredità del gruppo dirigente del decennio precedente. Egli faceva il nome di Bordiga, riconoscendo di avere subito la sua influenza almeno fino al 1922 e rivendicando di averlo poi combattuto, ma evitava di menzionare il nome di Gramsci e persino il Congresso di Lione del 1926. Non mancava invece di riportare le critiche subite nel 1929, al momento della lotta contro «gli errori opportunisti di Tasca», precisando che ne aveva riconosciuto «la completa correttezza»53. Diverso il tono e il formato delle biografie dei dirigenti piú giovani, che rendevano conto in dettaglio della propria formazione giovanile, carriera politica e preparazione ideologica, come nel caso di Longo54. Tutti mostravano di sapere bene quali fossero gli aspetti, i momenti e i nomi da sottacere o da sottolineare per allinearsi al canone stalinista, che aveva l’obiettivo di obliterare la memoria dell’appartenenza al mondo socialista, ma anche fare ammenda o cancellare le diversità e i dissensi del decennio passato nel movimento comunista. Si innescava cosí un formidabile meccanismo di autodisciplina e autocensura.
Nel contempo, la narrazione della scelta esistenziale annullava i confini tra sfera privata e sfera politica, combinando tra loro elementi di un ordine religioso con il vocabolario della modernità politica, destinati a lasciare una lunga traccia nelle pratiche e nell’immaginario dei comunisti55. La nozione stessa del “rivoluzionario di professione” implicava un controllo sulle emozioni e una stretta vigilanza sulla vita privata, persino tra le militanti che facevano il loro apprendistato internazionalista nella Scuola leninista56. Completamente diversa l’esperienza di una figura piú giovane di Longo come Giorgio Amendola, iscrittosi al partito soltanto nel 1929 (per essere arrestato tre anni dopo), provenendo da una famiglia alto-borghese e figlio di una delle personalità di maggior spicco dell’antifascismo liberale. E tuttavia, ricostruendo anni dopo la propria motivazione di aderire alla forza ritenuta piú coerentemente antifascista, sotto l’influsso intellettuale del coetaneo Emilio Sereni, egli poneva l’accento sul fatto che si trattava di «un partito internazionalista, forte quindi del sostegno (e dell’indispensabile disciplina) di un grande movimento mondiale». In particolare, Amendola ricordava di aver letto il rapporto di Togliatti sulla questione coloniale al VI Congresso, che vide come un motivo in piú di distinzione dalle socialdemocrazie dell’epoca57. L’internazionalismo continuava a costituire un tratto unificante e un fattore costitutivo dell’identità e della «comunità immaginata» comunista, anche per coloro che non erano mai stati a Mosca.
2. L’antifascismo come internazionalismo.
Tramite la modernizzazione forzata staliniana, l’Unione Sovietica si ergeva al rango di potenza socialista in un mondo sconvolto dalla Grande Depressione. Agli occhi dei comunisti, questo nuovo capitolo della mitologia rivoluzionaria rendeva trascurabili gli spaventosi costi umani della “rivoluzione dall’alto” e della collettivizzazione delle campagne, che si inserivano nella narrazione di una necessaria «seconda rivoluzione» imposta dalla logica classista e anticapitalistica, ma anche dalle minacce percepite di una prossima guerra controrivoluzionaria. La fine della gigantesca e violenta trasformazione della società sovietica coincise con il drammatico cambiamento dello scenario europeo provocato dall’avvento al potere di Hitler nel 1933. Questo evento poteva giustificare i metodi utilizzati da Stalin per la costruzione della potenza sovietica e avvalorava l’idea che il fascismo costituisse l’autentico destino del capitalismo liberale e democratico. Ciò esaltava la missione universale e salvifica dello Stato sovietico, quale doveva trovare espressione propagandistica nella Costituzione del 193658.
Tutti i comunisti, salvo un esiguo numero di dissidenti estromessi dal movimento alla fine degli anni Venti, condivisero una simile visione del futuro, composta da leggi meccaniche e profezie catastrofiche. Sotto questo profilo, i gruppi dirigenti si legarono ancor piú di prima a una fede politica che per definizione non ammetteva il beneficio del dubbio e consegnava alla figura del leader un’investitura incondizionata. Il loro messianismo rendeva possibile vedere nella sfera della politica il regno privilegiato della massima spregiudicatezza, purché subordinata a una concezione fatalista della storia che si materializzava nel potere dello Stato59. Gramsci alluse a una simile concezione e la bollò con il termine di «statolatria» nei suoi scritti del carcere. Togliatti invece la fece propria, accettando il primato della potenza sovietica. Entrambi credevano alla «costruzione del socialismo» in Russia e condividevano questa fede con tutti gli altri dirigenti, quadri o semplici militanti, quale sostegno spirituale alle durezze del carcere o dell’esilio. Ma Gramsci vide nella modernizzazione staliniana una fase primitiva, di natura «economico-corporativa», e si interrogò sul suo futuro alla luce della rottura violenta delle relazioni tra città e campagna60. Una visione problematica che era inammissibile dal 1928 in avanti nel movimento comunista e destinata ai posteri. A differenza di Gramsci, Togliatti evitò di costruire mitologie sull’Unione Sovietica. I suoi accenni alla «costruzione del socialismo» furono sempre stringati ed essenziali, anche se aderí in pieno alla “rivoluzione dall’alto” di Stalin. Probabilmente egli riteneva che la forza del mito sovietico rilanciato dalla grande trasformazione staliniana fosse dotata di una sua autoevidenza e capacità di riproduzione. I suoi scritti la davano per acquisita e si autolimitavano alla sfera della politica.
Lo Stato-centrismo stalinista si nutriva di un formidabile fattore di persuasione, l’«accerchiamento capitalistico» e la sua minaccia presunta o reale per l’esistenza dell’Unione Sovietica. Sin dal suo soggiorno a Mosca nel 1926, Togliatti aveva assistito alla escalation della percezione della minaccia esterna nel gruppo dirigente bolscevico. Fu questa la premessa per assimilare un codice che non era appartenuto ai comunisti italiani, la lettura dei rapporti internazionali sotto il segno della dottrina dell’inevitabilità della guerra. A piú riprese, Stalin rese chiaro che l’«accerchiamento capitalistico» non era soltanto una nozione geopolitica ma anche una strategia di classe applicata alla politica internazionale da tutte le principali potenze senza distinzioni. È probabile che Togliatti abbracciasse piú per motivi di opportunità che per convinzione la dottrina dell’inevitabilità della guerra, della quale comprendeva bene l’importanza per lo Stato staliniano. Sta di fatto che la applicò in numerosi suoi scritti dal 1929 in avanti, assumendone in pieno la responsabilità insieme ai dirigenti in esilio a Parigi. Sin dalla sua polemica contro Tasca al X Plenum, egli presentò il pericolo di guerra come incombente e diretto contro l’Unione Sovietica, esprimendo nella scia di Stalin la profezia di una guerra del mondo capitalistico unito contro il bolscevismo61. Questo codice doveva influenzarlo a lungo, anche nei tentativi di distaccarsene qualche anno dopo. Egli giunse a rinnegare il tema della «lotta per la pace» da lui stesso proposto senza successo nel 1927, criticando le aperture dei comunisti francesi e tedeschi alla campagna contro la guerra ideata da Münzenberg, che nel corso del 1932 coinvolse personalità quali Henri Barbusse e Romain Rolland62. A questo punto, gli elementi di distinzione che i comunisti italiani avevano sviluppato si erano ridotti ai minimi termini. L’insistenza di Togliatti contro le analogie tra la situazione tedesca e quella italiana difendeva un elemento delle analisi passate, ma al prezzo di esprimere una profezia sbagliata sulla Germania, come egli stesso doveva riconoscere piú tardi.
L’ascesa al potere di Hitler ebbe l’effetto immediato di alimentare la persuasione che la guerra fosse inevitabile, non soltanto negli ambienti del comunismo internazionale. Era facile prevedere che il sistema di Versailles avesse i giorni contati e che si profilasse ormai un piano inclinato verso una seconda catastrofe europea e mondiale. Come molti altri, Togliatti non si chiedeva se ci sarebbe stata una nuova grande guerra, ma «dove sarà combattuta questa guerra, quando, da chi e contro chi»63. In questo contesto, egli ribadiva il ruolo del fascismo italiano quale istigatore di guerra, proprio per la sua natura di «imperialismo debole» rivolto a destabilizzare il sistema internazionale. Per i comunisti, lo scenario della guerra inevitabile costituiva una dottrina incontestabile e implicava anche la lettura dell’avvento di Hitler come possibile prologo alla rivoluzione. Togliatti contribuí ad alimentare la fatale illusione che, diversamente dalla Spd, la Kpd avrebbe avuto un ruolo di mobilitazione di massa nella Germania del 1933 e che, se fosse stata all’altezza di tale compito, avrebbe fatto esplodere le contraddizioni della nascente dittatura. Egli pronunciò parole di fiducia sulla Germania, alla luce della «edificazione socialista» in Unione Sovietica, persino al XIII Plenum dell’Ikki, nel novembre 1933. Nel febbraio 1934, seguendo l’ottica di Stalin, vide nella repressione sanguinosa delle manifestazioni operaie a Vienna l’annuncio dello scoppio di una guerra tra le potenze imperialistiche, sotto la spinta della fascistizzazione dell’Europa. A suo giudizio, persino le contemporanee proteste operaie e democratiche contro la minaccia fascista in Francia non costituivano un contrappeso adeguato e anzi «sperare che la marcia del fascismo sia arrestata dalla resistenza armata dello Stato “democratico”», come facevano i leader di Giustizia e Libertà, sarebbe stata «pura utopia reazionaria»64.
Fu questa una delle valutazioni piú miopi fatte da Togliatti nella propria carriera politica. Proprio la repressione a Vienna e la contemporanea manifestazione popolare a Parigi contro il pericolo della destra costituirono invece un punto di svolta per la nascita di uno spazio antifascista transnazionale. La minaccia rappresentata dal nazismo in Germania imponeva una risposta politica che non poteva ridursi alle profezie di guerra. Nel corso del 1934 i comunisti liquidarono la teoria del «socialfascismo», anche se non fecero ammenda per il suo contributo all’ascesa di Hitler, e si inserirono nello spazio dell’antifascismo, nel tentativo di costruire una nuova legittimazione in Europa dopo il fallimento della rivoluzione mondiale. Stalin incoraggiò e mise sotto controllo il cambiamento antifascista. Egli favorí la nuova politica e, al contempo, ne delimitò i confini. Il Comintern non aveva un posto primario nelle sue priorità. Tuttavia la sua presenza si fece piú che sentire nel 1934 e restituí al comunismo internazionale un ruolo connesso alla politica estera dell’Unione Sovietica. La scelta di Stalin cadde su Dimitrov, il comunista bulgaro dirigente del Comintern in Germania, reduce dal processo di Lipsia, nel quale si era difeso brillantemente dalle accuse naziste di avere appiccato l’incendio al Reichstag nel marzo 1933. Dimitrov giunse a Mosca alla fine di febbraio 1934 con la fama europea di un eroe antifascista. Stalin lo incontrò poco piú di un mese dopo e lo invitò a prendere la responsabilità della leadership criticando duramente i dirigenti che formavano il «quartetto» a lui ciecamente fedele dal 1929 (Pjatnickij, Manuiłskij, Kuusinen, Knorin)65.
Togliatti partecipò agli orientamenti del Comintern in un modo molto piú diretto e centrale di quanto non fosse accaduto alla fine del decennio precedente. Dimitrov lo cooptò subito nel gruppo dirigente che si stava ricostituendo sotto la propria direzione. Il nome di Togliatti comparve per la prima volta nel Diario di Dimitrov il 27 maggio 1934, quando lo inserí tra i relatori dell’imminente VII Congresso (insieme a Pieck, Manuiłskij, Wang Ming e Pollitt)66. Evidentemente la sua scelta costituiva un riconoscimento del ruolo del leader italiano, che aveva incontrato a Berlino, nell’analisi del fascismo. Togliatti giunse a Mosca pochi mesi dopo, probabilmente in agosto. Nel suo primo intervento al Comintern, il 29 agosto, affermò che era necessario fare «un bilancio della dittatura fascista in Germania e in Italia» e che su questa base il Comintern doveva «parlare alle masse»67. L’implicazione principale di queste parole era l’invito ad abbandonare le illusioni circa la fragilità e l’instabilità del regime di Hitler, nutrite in passato anche a proposito di Mussolini. Su questo punto cruciale, Togliatti aveva qualcosa da insegnare ai principali protagonisti del dibattito sul nazismo nel Comintern, come Varga, Knorin e Manuiłskij, inclini a vedere nella dittatura hitleriana una forma transitoria di potere sottoposta al dominio del capitale finanziario. Il macigno da aggirare per operare una revisione credibile era costituito dalla dichiarazione compiuta nel dicembre 1933 dal XIII Plenum del Comintern, che codificava il fascismo semplicemente come una «dittatura terroristica» espressione diretta del capitalismo finanziario, con buona pace delle elaborazioni sulle sue basi di massa compiute negli anni Venti. Paradossalmente, lo sfondamento del fascismo in una società a capitalismo avanzato, che le analisi comuniste avevano escluso all’apice di Weimar, alimentava uno schema classista perché poteva essere letto come una conferma del predominio degli interessi capitalistici nella fascistizzazione dell’Europa.
L’incontro con Dimitrov restituí a Togliatti una bussola politica smarrita negli anni precedenti. Per alcuni mesi la questione del nuovo congresso restò in sospeso, ma Stalin approvò il corso politico antifascista in Francia, sancito dal patto di unità d’azione tra comunisti e socialisti nel luglio 1934. Nel frattempo, Togliatti vestí i panni dell’emissario del Comintern e svolse missioni in Francia e in Belgio con l’obiettivo di verificare e orientare le nuove politiche di alleanza delle sinistre che delineavano il Fronte popolare. Non è chiaro quanto egli stesso fosse persuaso dell’opportunità di lanciare senza riserve una simile iniziativa politica, che vedeva in prima linea Maurice Thorez e il Pcf. Tuttavia, rientrato a Mosca alla fine dell’anno, si dedicò alla preparazione del Congresso e pose al centro dei suoi interventi la lotta per i «diritti democratici» nei paesi sotto la dittatura fascista o per la loro difesa negli altri paesi europei68.
Il suo «corso sugli avversari», una serie di lezioni tenute tra il gennaio e l’aprile 1935 ai quadri italiani, si inserí in questo contesto. Il corso rientrava nell’attività di pedagogia politica e formazione dei quadri che aveva conosciuto una forte espansione del Comintern stalinizzato sin dai primi anni Trenta, un autentico sistema di «pedagogia totale» rivolto al disciplinamento e alla fedeltà ideologica69. Ma le analisi togliattiane rivelavano anche il tentativo di salvaguardare forme di sorveglianza critica e lasciavano trasparire il lavoro in atto per aggirare le formule dogmatiche e preparare un cambiamento politico. Senza smentire apertamente la formula staliniana del 1933, Togliatti componeva un quadro analitico piú complesso sul rapporto tra masse popolari e regime fascista, che aveva anticipato in un articolo sulla stampa del Comintern. Le fonti concettuali dell’analisi di Togliatti risalivano alle comuni elaborazioni con Gramsci e con Tasca negli anni Venti. Il punto fondamentale era, come in passato, compiere un’analisi specifica del fascismo italiano adottando però ottiche e categorie dalle implicazioni piú generali, che divenivano un elemento indispensabile con l’avvento del nazismo in Germania. È evidente che il pensiero di Togliatti, pur nel codice pedagogico del linguaggio impiegato, si riferiva all’impatto della Grande guerra sulla politica di massa e alle risposte fornite dal fascismo e dal bolscevismo in Europa e in Russia. Le analisi fatte nel 1933-34 da Tasca, ormai divenuto un feroce avversario del comunismo, non erano diverse quanto al tema del rapporto tra masse e fascismo come soggetto della modernità antiliberale70. Togliatti compiva però alcune scelte selettive. Respingeva anzitutto la categoria del bonapartismo, che nel frattempo costituiva invece un punto di partenza dell’analisi del fascismo sviluppata da Gramsci in carcere71. Tale presa di distanza si può spiegare con il fatto che la categoria del bonapartismo era stata impiegata, tra gli altri, da Trockij e diveniva soltanto per questo motivo materiale incandescente. Il punto è però che Togliatti evitava di fissare la propria attenzione su categorie volte a definire l’autonomia del regime dall’influenza di tutte le classi sociali.
Egli elaborava un’analisi attenta e perspicua dell’architettura e delle basi sociali del regime fascista come forma della moderna politica di massa, che aveva l’obiettivo di far comprendere la complessità del compito di lottare contro la dittatura e per le «libertà democratiche»72. In particolare, analizzava la risposta del fascismo alla Grande Depressione, come passaggio dalla «disorganizzazione delle masse» e delle istituzioni di classe alla scelta di «portare le masse nelle sue organizzazioni», per ampliare le proprie basi sociali. La sua analisi evitava una dimensione comparativa in Europa. Alla luce dell’ascesa di Hitler, egli riconosceva come un «errore» aver pensato che il fascismo fosse soltanto «un regime proprio dei paesi a economia capitalista debole», ma non mancava di sottolineare una volta di piú le particolarità storiche dell’Italia, a cominciare dalla fragilità dell’organizzazione politica della borghesia. Osservava come il nazionalsocialismo, a differenza del fascismo, avesse conquistato basi di massa già prima della presa del potere e ciò avrebbe potuto piú facilmente generare forme di «ribellione» dei suoi capi «contro la dittatura aperta della grande borghesia» e lotte intestine al regime in rapida evoluzione, come era accaduto nella «notte dei lunghi coltelli»73. Ma non si spingeva oltre.
Nelle lezioni traspariva anche il gioco di specchi tra lo Stato fascista e lo Stato bolscevico nella nuova fase aperta dopo il 192974. Se però davvero il «corso» accostava implicitamente le esperienze del fascismo e dello stalinismo sotto il profilo dello Stato e dell’organizzazione delle masse, c’è da chiedersi quanto il suo autore fosse poco consapevole, o riluttante a riconoscere, che il consenso di Mussolini, e ancora piú di Hitler, era molto piú esteso di quello assai limitato goduto da Stalin, specie dopo la catastrofe della guerra contro i contadini e la morte di massa provocata dal suo regime nelle campagne75. Un segno possibile dell’influenza esercitata anche su Togliatti dal culto della personalità e dalle narrazioni mitologiche circa la nascita di una società senza classi in Unione Sovietica. Di certo, egli impiegava con estrema parsimonia il termine stesso di totalitarismo, che si prestava a definire l’organizzazione di massa del regime fascista ma presentava anche implicazioni troppo scoperte circa la sottomissione della società nel suo complesso da parte dello Stato. Sotto questo profilo, Gramsci in carcere era piú libero di Togliatti nell’applicare le categorie del «napoleonismo» e del totalitarismo anche alla realtà sovietica.
L’interpretazione togliattiana dell’ascesa al potere di Hitler era riconducibile alla lettura di Stalin: una sconfitta del movimento operaio le cui responsabilità ricadevano esclusivamente sui socialdemocratici. Le conseguenze del disastro in Germania, a suo giudizio, avrebbero prodotto un allargamento del «fronte di lotta» antifascista in una serie di paesi europei e una crisi profonda della socialdemocrazia. Si profilava in questo passaggio la preparazione della svolta antifascista del Comintern. Togliatti legittimava la prospettiva di difendere le istituzioni democratiche contro il fascismo presentandola come un modo per prevalere finalmente sulla socialdemocrazia. Egli utilizzava uno schema antinomico basato sulla coppia reazione-rivoluzione e poneva l’accento sul dualismo tra fascismo e comunismo in Europa. Il suo approccio al riguardo era realista e non nascondeva lo stato autentico del movimento comunista in Europa. Questo avrebbe potuto fronteggiare il fascismo soltanto se si fosse mostrato capace di superare le proprie «manchevolezze» e di conquistare la maggioranza della classe operaia76.
La visione di Togliatti escludeva il ruolo di altri attori in scena e presupponeva che il socialismo sovietico e il movimento comunista costituissero il solo vettore di trasformazione nella politica mondiale. Non è difficile notare la distanza di una siffatta impostazione, incentrata sulla dicotomia tra rivoluzione e controrivoluzione distintiva dell’immaginario della “guerra civile europea”, dall’analisi che Gramsci in carcere dedicava al tema dell’americanismo come fenomeno trasformativo sul piano globale e che intrecciava con l’influenza del fascismo in Europa, forgiando la categoria della «rivoluzione passiva»77. La diversità delle due visioni non rimanda soltanto alle rispettive realtà dei due protagonisti, lontane e incommensurabili, ma anche a divergenti tematizzazioni e gerarchie di senso. In particolare, la presenza o meno di interrogativi a proposito dell’Unione Sovietica, assai trasparenti in Gramsci e rimossi o censurati in Togliatti, presentava l’evidente riflesso di incrementare o semplificare la complessità delle visioni e delle analisi dell’ordine mondiale.
Le visioni di Gramsci in carcere e di Togliatti alla Scuola leninista di Mosca non sarebbero entrate nel bagaglio culturale dei comunisti italiani per un lungo periodo di tempo, fino al secondo dopoguerra e oltre. Il loro confronto ha un senso soprattutto per comprendere le continuità e le discontinuità tra le due personalità principali del Pcd’I, che per anni avevano costruito un tessuto comune ma si erano trovate improvvisamente in un conflitto politico nel 1926. Quel conflitto non si era ricomposto, ma al contrario allargato negli anni successivi. Gli anni della linea «classe contro classe» e del «socialfascismo» avevano marcato il momento di divergenza piú radicale nelle concezioni strategiche, contribuendo all’emarginazione di Gramsci e alla dissoluzione finale del gruppo dirigente italiano. Tale lacerazione pesava anche dopo che la svolta antifascista aveva rivalutato di fatto le ragioni dei dissidenti di pochi anni prima. In questa ottica, l’analisi storica delle rotture anche culturali dagli anni Venti in avanti smentisce le autorappresentazioni continuiste costruite molti anni dopo dallo stesso Togliatti, a lungo influenti sulla storiografia78. Ma soprattutto contribuisce a illuminare un cambiamento d’epoca e una frattura nelle traiettorie delle élite politiche comuniste tra le due guerre. Le idee e le visioni condivise anche dai dirigenti piú lucidi e strutturati intellettualmente, come Togliatti, bruciavano i ponti non semplicemente con le concezioni delle opposizioni del decennio precedente, ma anche con componenti sostanziali di un universo mentale e concettuale che si sarebbe dissolto per sempre nel Grande Terrore. L’assenza di interrogativi circa la strada presa dal regime postrivoluzionario in Russia non costituiva semplicemente l’adeguamento a un canone conformista. Liquidato il problema politico della «costruzione del socialismo» e dell’internazionalismo come egemonia, si delineava una cultura politica definitivamente incentrata sul primato dello Stato socialista, sul disciplinamento, sull’autocensura.
La stagione antifascista apriva la strada a ripensamenti molto seri, ma quei ponti difficilmente si potevano ricostruire, perché lo stalinismo aveva lasciato una sedimentazione. Qualche anno dopo, nel marzo 1938, dalla lontananza spaziale e temporale del confino, Terracini scrisse a Grieco una lettera molto eloquente al riguardo. Egli non nascondeva il disappunto per l’atteggiamento distaccato del partito e ricordava con severità che i confinati non erano «sepolti vivi» ma continuavano a nutrire la politica come unica passione («non sono degli “sportsmen” o solo dei curiosi del movimento rivoluzionario, ma dei militi devoti che gli hanno dedicata la vita e sacrificata la libertà»). Terracini aderiva alla svolta antifascista e ricordava di essere stato «classificato tra gli oppositori» dopo il 1929, insieme a Gramsci, soprattutto per aver negato la mera identificazione tra fascismo e capitalismo. Lamentava che si continuasse a trattare «per accenni condizionali ed indeterminati» un argomento come quello «del pensiero di Antonio circa la politica del partito nel corso dell’ultimo decennio». Non era però appagato di vedere riscattate le proprie ragioni, che aveva continuato a sostenere nella prigionia, ma rimarcava i limiti del cambiamento politico. Non c’era da stupirsi che la nuova linea incontrasse resistenze sorde o visibili tra dirigenti e quadri, scriveva, perché era mancata «una larga autocritica» e un chiaro distacco dalle posizioni precedenti79.
Quella condotta era una scelta di Stalin. Dimitrov e Togliatti lo incontrarono il 9 luglio 1935, alla vigilia del VII Congresso del Comintern. Al momento del Congresso, in una lettera a Molotov, Stalin dette un giudizio positivo sui lavori, osservando che sarebbero stati «ancora piú interessanti dopo le relazioni di Dimitrov e di Ercoli» rispettivamente sui compiti della lotta contro il fascismo e sulla «lotta per la pace»80. È evidente che tale giudizio esprimeva l’approvazione della linea antifascista, ma la circoscriveva a un cambiamento tattico. Stalin aveva da tempo ammonito Dimitrov a evitare cenni critici sugli anni passati, compresa la tesi del «socialfascismo»81. La novità della relazione consisteva nell’indicare il fascismo come «nemico principale» del movimento operaio e dell’Unione Sovietica e l’invito a compiere un’analisi differenziata del «mondo capitalistico», rivolta a sottolineare la diversità dello Stato fascista dalla «democrazia borghese»82. Il tema della «lotta per la pace» affidato a Togliatti si presentava piú controverso, malgrado fosse ovvio il parallelismo con la politica estera di «sicurezza collettiva» identificata nella personalità del commissario agli Affari esteri, Litvinov. Era piú facile indicare nel fascismo il «nemico principale» due anni dopo l’avvento di Hitler e mentre si annunciava l’aggressione italiana all’Etiopia, che non sovrapporre un linguaggio “pacifista” a quello della “guerra civile internazionale”, una mossa già fallita alla fine degli anni Venti.
L’analisi di Togliatti rappresentava uno spaccato del mondo visto da Mosca alla metà degli anni Trenta. Egli adottò uno sguardo globale che vedeva non solo la fine del sistema di Versailles in Europa ma anche quella del sistema di Washington nel Pacifico. Nella sua ottica, il nazismo in Germania prospettava ormai un’Europa «balcanizzata», il militarismo giapponese e la guerra italiana in Etiopia ponevano la questione della «pace indivisibile» su scala mondiale, i conflitti tra le grandi potenze si erano fatti incomponibili. La fascistizzazione costituiva il fenomeno centrale di questo scenario, mentre il ruolo americano era incasellato nello schema marxista-leninista dell’«antagonismo» tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Togliatti implicitamente riteneva irrilevante il significato del New Deal e derubricava alla sola politica di potenza le analisi sul ruolo globale americano compiute da Gramsci e Tasca nel primo decennio postbellico. Non ripresentava lo sprezzante giudizio sul «rooseveltismo» espresso meno di due anni prima, quando lo aveva accostato al fascismo sul piano ideologico e politico, ma neppure lo smentiva o modificava83.
Il linguaggio di Togliatti non rivelava soltanto la sua accortezza, ma anche una contraddizione di fondo tra la dottrina dell’inevitabilità e la politica di prevenzione della guerra. Egli oscillava tra due registri diversi. Indicava il fascismo e la guerra come unico sbocco del capitalismo in «putrefazione» nel cono d’ombra della Grande Depressione, mentre si affermava il socialismo in Unione Sovietica. Una prospettiva catastrofica dilagante in ambienti politici e intellettuali europei piú ampi del mondo comunista, ma che a Mosca presentava implicazioni molto stringenti di ortodossia dottrinaria. Invitava però a combattere il catastrofismo e a lottare per la pace e per la difesa dell’Unione Sovietica, anche utilizzando le «contraddizioni» tra le potenze capitalistiche. La conseguenza di una simile oscillazione era che egli dipingeva il movimento comunista come «un grande esercito che lotta per la pace» ma presentava l’esito della guerra come un fatto scontato. Parlava di «prevenzione della guerra», ma sosteneva che ci si trovava alla vigilia di un «secondo ciclo di rivoluzioni e di guerre». Poneva l’obiettivo minimo di «ritardare la guerra» precisando però che «in determinate circostanze, anche evitare la guerra è cosa possibile e realizzabile»84. In altre parole, Togliatti si muoveva entro i vincoli della teoria dell’inevitabilità della guerra, cercando però di prospettare una politica positiva orientata a evitare o dilazionare il conflitto, che recuperava la sua idea della «lotta per la pace» risalente al 1927. Gravavano su questa impostazione le aporie mai risolte degli anni precedenti e i vincoli posti da Stalin. L’ultrarealismo di Stalin non era affatto sganciato da una concezione ideologica dell’ordine mondiale, ma anzi presupponeva proprio la profezia della guerra inevitabile85.
I vincoli della Realpolitik staliniana emersero subito dopo il VII Congresso, quando Stalin in una lettera a Molotov e Lazar′ Kaganovič liquidò la proposta di Litvinov di mettere sanzioni unilaterali contro l’Italia a causa del nascente conflitto in Etiopia. A suo giudizio, il vero conflitto non era tra Italia e Abissinia ma tra Gran Bretagna e Italia86. L’impostazione di Stalin prescindeva dal tema del fascismo e contribuí, insieme a Londra, all’inefficacia dell’intervento della Società delle Nazioni. La sua visione in chiave di politica di potenza avrebbe esercitato un peso decisivo anche sul movimento comunista. Ciò nonostante, la questione della guerra dell’Italia fascista in Etiopia ebbe proprio in quel momento una eco mondiale e divenne un test per la nascita di un’opinione antifascista e pacifista in Europa87. Malgrado il suo carattere anacronistico, l’impresa bellica mussoliniana ricongiungeva l’imperialismo europeo al colonialismo sotto l’aspetto del fascismo. Di riflesso, sia pure per una congiuntura molto breve, sottrasse i comunisti italiani alla marginalità. La conferma del nesso che essi avevano stabilito tra il revisionismo fascista e il pericolo di guerra favorí un’azione internazionalista, la prima di un certo effetto da molti anni. In una conferenza svoltasi a Bruxelles nell’ottobre 1935, Ruggero Grieco, insieme al socialista Pietro Nenni, fece appello alla resistenza contro le operazioni belliche e profetizzò una crisi profonda del fascismo88. Togliatti richiamò alla prudenza e al realismo, ipotizzando semmai un graduale distacco delle masse dall’identificazione con il regime89. La successiva missione di Velio Spano in Egitto non sortí conseguenze rilevanti, pur avendo il senso di collegare l’antifascismo europeo con i sentimenti anticolonialisti ravvivati dall’invasione italiana in Etiopia90.
La questione dell’Etiopia suscitò un’oscillazione tra l’impiego del motivo anticapitalistico e la questione delle «libertà popolari» nella propaganda rivolta al paese, indirizzata agli stessi fascisti. Tale duplice registro emerse nei primi mesi del 1936. Nel Comintern prevalse la prospettiva disfattista e l’idea di fare appello alle condizioni materiali della popolazione italiana, che la guerra avrebbe aggravato invece di risolvere, da compiere utilizzando l’argomento della mancata realizzazione del programma fascista del 1919. Nelle sue lezioni ai quadri italiani del marzo 1936, Togliatti sostenne piuttosto che i comunisti dovevano raccogliere le aspirazioni popolari materiali ma orientarle alla questione della democrazia, perché «il problema della libertà non è per noi un espediente». Tale impostazione costituiva, a suo giudizio, un necessario adeguamento rispetto alle Tesi di Lione (che tornava a citare). Ancora piú insistentemente del «corso sugli avversari» di un anno prima, il dattiloscritto che riassumeva gli interventi di Togliatti riportava l’esigenza di «lottare per un’Italia democratica» e articolare un programma di «rivendicazioni democratiche» perché «nel momento in cui le masse si mettono in movimento, esse si mettono in lotta per la libertà»91. Al momento della proclamazione dell’impero, nel maggio 1936, la questione dell’Etiopia aveva già perso di incisività nel mobilitare l’opinione antifascista in Europa, che si era rivolta alla minaccia rappresentata dalla rimilitarizzazione nazista della Renania. Hitler era un motivo piú che sufficiente per rafforzare l’ottica eurocentrica che sin dall’inizio aveva contraddistinto la lettura comunista del conflitto in Etiopia, sebbene i suoi riflessi globali si amplificassero invece nel mondo coloniale e in particolare nei movimenti panafricani92. La speranza dei dirigenti italiani in un fiasco politico e militare del regime fascista, che avrebbe potuto destabilizzarlo, venne frustrata. Essi mantennero l’idea contraddittoria di promuovere un «movimento anticapitalistico e democratico», che sovrapponeva due motivi contrastanti tra loro e dava credito alla demagogia del programma originario del fascismo. Il risultato fu un appello ai «fratelli in camicia nera», approvato dallo stesso Togliatti, che impiegava la parola d’ordine della «riconciliazione nazionale» nel momento del trionfo di Mussolini, duramente criticato dagli altri antifascisti. Tuttavia il documento implicava anche una presa d’atto delle basi di massa del regime e una tematizzazione del Fronte popolare in chiave nazionale93.
3. Internazionalismo e Terrore.
Il VII Congresso non segnò un’inversione della tendenza al declassamento del Comintern iniziata nel 1929. Scelte e decisioni restavano il risultato di incontri informali e relazioni personali piú che di un esercizio dell’attività istituzionale. Il gruppo dirigente rappresentava un’oligarchia centralizzata e settorializzata, dotata di intermittenti canali di comunicazione con la sfera centrale del potere sovietico. La consuetudine dei dirigenti comunisti stranieri di frequentare e interloquire con i membri del Politbjuro non esisteva piú, per non parlare della possibilità di esprimere apertamente le proprie opinioni. Le élite politiche dello Stato sovietico formavano una cerchia inaccessibile e l’apparato del Comintern una burocrazia strettamente integrata e subordinata agli apparati sovietici, a cominciare da quelli di polizia. Una fitta cortina di segretezza era calata su tutte le attività dei comunisti, governate da rigorose regole di «cospirazione» nelle relazioni tra il centro e la periferia, non soltanto laddove i partiti agivano nella clandestinità. In questo senso, l’ambiente cosmopolita degli anni Venti era un lontano ricordo. Le comunità di comunisti stranieri a Mosca, incrementate dall’ondata di migrazione politica dalla Germania, costituivano una presenza transnazionale in un ambiente diffidente e ostile. La pratica dell’ospitalità internazionalista era ormai liquidata e il sistema di controlli sui cittadini stranieri si fece molto piú stringente, prevedendo per alcuni l’obbligo di prendere la cittadinanza sovietica e portando allo scioglimento dei club e scuole degli emigranti. Poco dopo l’assassinio di Sergej Kirov, nel dicembre 1934, il giro di vite persecutorio nei confronti di ex oppositori o presunti tali doveva investire presto il Comintern a tutti i livelli. Gli ambienti dell’emigrazione politica vennero esplicitamente indicati come un possibile canale di infiltrazione per attività spionistiche. L’internazionalismo antifascista e l’ondata del Terrore in Unione Sovietica conobbero cosí un intreccio e un corto circuito94.
Togliatti vi si trovò coinvolto in ragione del suo ruolo di vicesegretario del Comintern, incaricato di supervisionare l’area piú sensibile, costituita dalla Germania e dai paesi dell’Europa centrale95. L’idea di governare dal centro la “periferia” dei partiti contribuí ad alimentare una spirale di tensioni, dato che il principio di lealtà e il rispetto delle gerarchie non impediva ai leader locali di seguire visioni e strategie dissonanti o incoerenti con la volontà espressa a Mosca. La «lotta contro il trockismo» figurava ormai come un compito centrale dell’intera organizzazione e stava imboccando una strada pericolosa. Nel dicembre 1935, Togliatti tenne una lezione agli insegnanti della Scuola internazionale leninista incentrata sulla rilevanza di tale lotta per la formazione politica dei quadri96. In questa circostanza, operò una distinzione tra il «trockismo» in Unione Sovietica, dove riguardava la lotta con la «controrivoluzione», e in altri paesi, dove invece insidiava soltanto la formulazione di una «corretta politica» affrancata da residui socialdemocratici. Cosí egli probabilmente cercava di tenere a distanza dagli ambienti cominternisti le pratiche poliziesche che già dilagavano altrove. Ma una simile distinzione era destinata a rivelarsi insostenibile nel giro di pochi mesi. Togliatti indicò anche il modo giusto di riferirsi a Stalin criticando duramente una recensione di Otto Bauer alla biografia del dittatore sovietico scritta da Boris Souvarine, perché istituiva un paragone tra Stalin e i «capi fascisti». Cosí facevano ingenuamente anche quadri recentemente emigrati in Unione Sovietica, senza capire che Stalin assolveva la funzione di un giusto orientamento politico e ideologico, non soltanto quale artefice della modernizzazione sovietica ma come leader del movimento comunista internazionale. È evidente che Togliatti non stava soltanto tessendo le lodi di Stalin, ma lo dipingeva in una luce che egli stesso riteneva essere quella piú aderente alla realtà. Sotto questo profilo, la sua visione di Stalin era identica a quella di Dimitrov.
Le personalità di Dimitrov e Togliatti si distinguevano nel gruppo dirigente del Comintern per lo sforzo di aprire una prospettiva politica, anche se la loro influenza era limitata soprattutto da Manuiłskij e da Michail Moskvin, un agente della polizia politica. I due leader del Comintern interpretarono l’antifascismo come una forma di realismo politico, che guardava alla difesa della pace come obiettivo prioritario, respingendo il fatalismo e la percezione che la crisi internazionale innescata dalla Germania nazista preludesse per forza di cose a una replica del 1914. Tuttavia, l’idea che una simile replica fosse inevitabile continuò ad avere un peso specifico enorme sulle mentalità e le visioni delle élite politiche a Mosca. Il tema della «lotta per la pace» si presentò subito nella sua concretezza al momento della crisi in Renania del marzo 1936. Allora Togliatti sostenne l’idea di sanzioni contro la Germania ai fini di una politica di contenimento di Hitler. Se la prese con il «fatalismo», ritenendo che «sulla base dei rapporti di forza in Europa» vi fossero le condizioni per «la prevenzione della guerra»97. In sintesi, affermò la parola d’ordine del «mantenimento della pace» quale compito strategico del movimento comunista, mentre impartiva ai quadri italiani, come abbiamo visto, il suggerimento di difendere la democrazia98. Il suo punto di vista si rivelò però minoritario. Il gruppo dirigente del Comintern continuava a esprimere denunce generiche del «pericolo di guerra», che ignoravano le fragili innovazioni del VII Congresso. Il tentativo di Togliatti e Dimitrov di presentare la «lotta per la pace» come un obiettivo rivoluzionario naufragò con lo scoppio della guerra civile in Spagna nel luglio 1936.
La guerra di Spagna apparve subito come il banco di prova per una mobilitazione antifascista di massa, sino allora non realmente promossa, ma soltanto invocata. L’esperienza fallimentare di Weimar venne ribaltata. Il compito principale dei comunisti fu indicato nella difesa della Repubblica. Dimitrov concordò con Stalin le prime direttive per i comunisti spagnoli, che ordinavano loro di non andare oltre «la lotta per una genuina repubblica democratica»99. Questo orientamento doveva restare un punto fermo della politica comunista. Dimitrov e Togliatti lo giustificarono sostenendo l’idea che la guerra civile avrebbe generato una «democrazia di tipo nuovo» e uno «Stato antifascista», non una rivoluzione sul modello del 1917. Togliatti spiegò come la Repubblica spagnola non potesse ridursi a «una repubblica democratica borghese di tipo comune», perché forgiata «nel fuoco di una guerra civile» nella quale la classe operaia si faceva «parte dirigente», e nata in un’epoca storica che vedeva protagonisti il fascismo «in una serie di paesi capitalistici» e il socialismo in Unione Sovietica100. Una simile visione introduceva nel linguaggio comunista una nozione distinta dalla democrazia liberale, che conosceva in Europa la sua ora piú buia, e anche dal modello sovietico, sebbene questo restasse la stella polare.
Dimitrov e Togliatti cercarono di definire il ruolo del movimento comunista come il protagonista di una politica a sostegno della «sicurezza collettiva» e di indicare obiettivi politici praticabili, mettendo la sordina sul tema anacronistico della «dittatura del proletariato». Essi erano consapevoli che le parole d’ordine della «lotta per la pace» e della «democrazia popolare», necessarie ad allargare l’influenza politica del comunismo, contenevano i presupposti per una revisione concettuale. La prima implicava la possibilità di impedire lo scoppio della guerra, perciò l’abbandono della teoria che le guerre fossero inevitabili e che le guerre civili fossero l’obiettivo dei rivoluzionari, la seconda poneva in discussione l’unicità della forma di Stato creata dal bolscevismo e il carattere universale dell’esperienza sovietica. Tuttavia, né l’una né l’altra revisione vennero davvero svolte. Sotto questo profilo, è difficile non concordare con il giudizio di Hobsbawm, secondo il quale il problema del rapporto tra antifascismo e socialismo nel pensiero comunista doveva restare tale e «la nebbia che circondava il dibattito in proposito non si sarebbe mai dissipata»101. Lo stesso si può affermare in merito al rapporto tra antifascismo e guerra negli anni Trenta. Come ha osservato Giuliano Procacci, la dottrina dell’inevitabilità della guerra rimase anche dopo il VII Congresso un vincolo incompatibile con la possibilità di affermare senza ambiguità il fine di prevenire i conflitti102. Il linguaggio impiegato da Dimitrov e Togliatti non configurava una riforma della cultura politica comunista. La sua ambiguità aveva però un senso. Consentiva infatti di giustificare una mobilitazione internazionalista per obiettivi non rivoluzionari e favoriva l’insediamento dei comunisti nello spazio politico dell’antifascismo europeo.
L’antifascismo comunista presentò cosí vari volti. Era al tempo stesso una forma di realismo politico e un’identità sovrapposta alla tradizione classista e antimperialista. La mobilitazione antifascista in Spagna creò una ragion d’essere largamente condivisa, seppure con implicazioni diverse circa i suoi obiettivi ultimi. L’internazionalizzazione della guerra imposta da Hitler e Mussolini creò presto un’esperienza unificante di sentimenti e appartenenze, vissuta come riscatto dalle delusioni e dalle sconfitte del primo dopoguerra e come una promessa per il futuro a prescindere dalle sorti della lotta in corso. I comunisti furono pienamente coinvolti in un simile crogiuolo, dai “rivoluzionari di professione” ai semplici combattenti, anche se non tutti nutrirono il medesimo trasporto romantico. Essi avvertirono il senso di connessione a un movimento globale che gravitava attorno all’Unione Sovietica, ma presentava ramificazioni ovunque, come mostravano i volontari delle Brigate internazionali. Le mitologie della rivoluzione russa erano influenti anche sui combattenti non comunisti e vennero alimentate da una sensibile presenza militare, politica e culturale nel campo repubblicano. I linguaggi della propaganda internazionalista si riflettevano persino nelle lettere private dei combattenti103. Dopo le delusioni della guerra d’Etiopia, i militanti antifascisti italiani trovarono nuove motivazioni nel conflitto con il fascismo, che raggiunse il culmine nella battaglia di Guadalajara e nello scontro armato fra italiani sulle due sponde opposte. Tra i comunisti, il tema della «fraternizzazione» sostituí allora quello della «riconciliazione», proponendo un’idea nazionale piú limpida e coerente con l’antifascismo internazionale104.
La Spagna non fu però un laboratorio in grado di liquidare fratture consolidatesi nel tempo. Dette un formidabile impulso a coalizzare gli antifascisti ma non ne cancellò le divisioni, alimentate soprattutto dagli interessi statali dell’Unione Sovietica e dai riflessi internazionali del Grande Terrore. La mobilitazione antifascista presupponeva il rifiuto di sacrificare la lotta spagnola sull’altare di accordi diplomatici, specie alla luce dell’inconsistenza del patto di «non intervento» sottoscritto dalle potenze europee e anche da Mosca. Dimitrov perseguí l’obiettivo di ottenere un riconoscimento del carattere internazionale della sfida rappresentata dalla Spagna, evidentemente nella convinzione che una vittoria dei repubblicani avrebbe consolidato il prestigio dei comunisti e la forza dell’antifascismo in Europa. Una posizione opposta a quella di Litvinov, che riteneva invece necessaria la fine dell’intervento per ristabilire le condizioni di una credibile iniziativa diplomatica dell’Urss. Stalin scelse una terza opzione. L’Unione Sovietica sostenne la repubblica senza però abbandonare il patto di «non intervento». Una politica duplice, ispirata alla logica di tenere le mani libere e di non vincolarsi a scelte troppo impegnative. Proprio la guerra di Spagna indusse Stalin a percepire assai piú i pericoli che i vantaggi di un conseguente orientamento antifascista, vale a dire una rottura con le potenze occidentali e un possibile confronto con la Germania nazista. Il primo segnale di questa visione comparve in una sua conversazione con Dimitrov, Togliatti e André Marty, il capo delle Brigate internazionali, il 14 marzo 1937. Si considerò l’ipotesi di uno smantellamento delle Brigate internazionali, nel caso di un’intesa tra le potenze europee sul ritiro delle forze straniere dalla Spagna105. L’ipoteca della politica di potenza doveva gravare sull’intera esperienza dell’internazionalismo comunista in Spagna.
È probabile che in tale circostanza si sia valutata l’idea di una missione di Togliatti in Spagna, che egli stesso aveva prospettato a Dimitrov nel novembre 1936. Questi la ritenne imprudente e suggerí un viaggio a Parigi per parlare con Thorez e Jacques Duclos, ma senza varcare la frontiera. Togliatti si recò a Parigi soltanto nel giugno 1937 e la sua missione a Valencia iniziò circa due mesi dopo. Dimitrov scrisse al leader comunista spagnolo, José Díaz, che Togliatti lo avrebbe affiancato per un lungo periodo di tempo. Quest’ultimo si trovò in una situazione ambigua, in quanto privo di uno status legale e direttive precise, mentre la sua presenza divenne immediatamente nota negli ambienti antifascisti. Se ne lamentò con Dimitrov, ma tale era la volontà di Stalin106. Togliatti operò sin dall’inizio con l’obiettivo di consolidare le alleanze del Fronte popolare. Perciò propose di liquidare Codovilla, rappresentante del Comintern, e limitare Marty, capo delle Brigate internazionali, entrambi a suo giudizio inclini a metodi di tipo militaresco. In questo contesto, Togliatti doveva mantenere un profilo molto particolare. Si affidò a collaboratori spietati come Vittorio Vidali, il «comandante Carlos» presente in Spagna sin dall’inizio della guerra civile, stretto collaboratore dei consiglieri militari sovietici, figura emblematica del “rivoluzionario di professione” e protagonista di epurazioni cruente107. Ma non si identificò nell’ethos militarizzato che pervadeva largamente l’esperienza militante in armi. Fu questo soprattutto il caso di Longo, che divenne figura emblematica di solidarietà internazionalista e direzione strategica nelle Brigate internazionali108. Togliatti mantenne un profilo piú politico, rispondente agli interessi sovietici e alla scelta di moderazione fatta sin dall’inizio da Stalin optando per la difesa della democrazia repubblicana. Non certo per caso, tra i suoi numerosi pseudonimi dell’epoca, oltre al classico Ercoli e ad Alfredo, figurava anche quello di «Kautsky», un riferimento autoironico al piú fermo avversario di Lenin nel socialismo internazionale. Senza mai comparire pubblicamente, egli fu una figura d’influenza molto rilevante negli ambienti repubblicani, come mostra la costante presenza nelle riunioni al vertice attestata dalle sue agende di lavoro109.
Tra i suoi compiti rientrava l’obiettivo di isolare i «trockisti», che in Spagna erano largamente identificati con il Poum di Andrés Nin, figura di militante cosmopolita nell’Unione Sovietica degli anni Venti e sostenitore di Trockij fino all’espulsione nel 1929. L’assassinio di Nin a Barcellona nel giugno 1937, probabilmente su commissione dell’emissario sovietico Aleksandr Orlov, scavò definitivamente un fossato tra i comunisti e la sinistra radicale110. A questa data, il Comintern era già stato coinvolto nel Grande Terrore. La «lotta contro il trockismo» aveva definitivamente imboccato una strada cruenta. Lo stesso Togliatti aveva svolto una relazione sulla questione nel settembre 1936, subito dopo il primo dei processi inscenati contro gli ex oppositori a Mosca, che si concludeva con un pesante atto d’accusa nei confronti dei comunisti tedeschi, tra i piú falcidiati dalle epurazioni111. Nel febbraio 1937, in una conversazione con Dimitrov, Stalin varcò una soglia irreversibile accusando il Comintern di essere un covo di spie. Nei mesi successivi, i principali dirigenti del Comintern stalinizzato dei primi anni Trenta furono arrestati. La comunità politica e umana dei dirigenti cominternisti ospitata all’Hotel Lux di Mosca fu dilaniata e dispersa. Le repressioni acquisirono presto un carattere di massa alimentato dalla xenofobia e colpirono una vasta fascia di quadri e le comunità degli emigrati112.
Il Diario di Dimitrov mostra che questi approvò e subí i tratti essenziali dello stalinismo nelle loro motivazioni di fondo, anche se probabilmente non ne condivise tutte le conseguenze e temette di esserne vittima egli stesso. Non c’è motivo di ritenere che il pensiero di Togliatti fosse diverso. Egli avrebbe tra l’altro incaricato Vidali di sviluppare il tema della «quinta colonna», una formula che alludeva alla cospirazione contro la Repubblica in Spagna ma anche contro il regime sovietico, in una serie di articoli nella seconda metà del 1937, che contribuirono alla fama di nemico giurato dei trockisti del «comandante Carlos»113. La missione in Spagna evitò a Togliatti la fase del Terrore piú buia e piú pericolosa per la sua stessa incolumità, anche se non lo assolse da ulteriori responsabilità. Ma gli fece vivere fino in fondo la contraddizione ormai aperta tra l’internazionalismo e la deriva xenofoba del regime di Stalin, che nell’antifascismo e nel cosmopolitismo vedeva molto piú un motivo di sospetto che una virtú. La sua figura si trovò anzi al crocevia di quella tensione distruttiva. Egli rimase un’eminenza grigia della Repubblica fino alla fine e svolse un ruolo costante nella caccia alle streghe antitrockista114. Ciò non gli impedí di esprimere giudizi politici autonomi, ad esempio nel febbraio 1938, quando si pronunciò per la partecipazione dei comunisti al governo Negrín, contravvenendo all’indicazione di Stalin. Lo stesso Togliatti compose la vicenda inviando a Stalin un telegramma che accoglieva il consiglio del leader sovietico come uno stimolo di riflessione essenziale, anche se il partito spagnolo aveva poi agito diversamente115. La questione non era secondaria. La preoccupazione di Stalin di evitare ogni possibile frizione con le potenze occidentali aveva già provocato l’autoesclusione dei comunisti francesi dal governo del Fronte popolare nato nel maggio 1936. Togliatti insistette a lungo, come Dimitrov, per incrementare il reclutamento delle Brigate internazionali, ma alla fine dovette prendere atto della logica del disimpegno dettata dagli interessi di sicurezza sovietici. Rientrato temporaneamente a Mosca nell’agosto 1938, partecipò a una riunione con Dimitrov, Manuiłskij, Moskvin e i comunisti spagnoli, nella quale si ratificò il ritiro delle Brigate dalla Spagna116.
In quello stesso momento, Togliatti si trovò coinvolto in un nuovo capitolo del Terrore, che riguardava i comunisti polacchi: firmò l’atto di scioglimento del Partito comunista polacco, il cui gruppo dirigente era già stato falcidiato dalle epurazioni. In un clima del genere, il destino dei dirigenti italiani era in bilico. Il Centro estero parigino non si era mai configurato come un autentico gruppo dirigente in esilio, ma come un nucleo operativo sotto il comando di Togliatti, che agiva al tempo stesso da dirigente del Comintern. Dal 1934 in avanti questa modalità di organizzazione perdette colpi, malgrado la nuova iniezione di fiducia del Fronte popolare francese. I dirigenti a Parigi, privi della mediazione di Togliatti, si trovarono esposti alle critiche di Mosca mentre i tentativi di organizzare una rete clandestina in Italia erano in gran parte falliti. Nel marzo 1937, essi furono posti sotto tutela tramite l’invio a Parigi di Giuseppe Berti quale plenipotenziario del Comintern. Esponente della nuova generazione di comunisti staliniani, Berti aveva sostituito Grieco come rappresentante del Pcd’I nel Comintern nel 1930 e dal 1932 in avanti aveva diviso la propria attività tra Parigi e Mosca. Completando la propria opera inquisitoria, presentò un rapporto conclusivo che conteneva giudizi assai pesanti sull’operato dell’intero gruppo parigino, in particolare su Grieco117. Nell’aprile 1938, una delegazione del Pcd’I si recò a Mosca per rispondere di accuse molto simili a quelle che avevano già provocato nei mesi precedenti l’arresto e la repressione violenta dei dirigenti di altri partiti: violazione delle regole della cospirazione, mancanza di «vigilanza rivoluzionaria» e colpevole inefficienza nella lotta al «trockismo». In assenza di Togliatti, Berti prese misure equivalenti al commissariamento del gruppo dirigente. Il 14 giugno 1938, Manuiłskij pronunciò una requisitoria sulle insufficienze del partito italiano. L’ennesimo capitolo di una storia infinita che lo aveva visto molte volte nel ruolo dell’inquisitore, ma questa volta un possibile preludio a una repressione violenta118. In agosto il Centro estero parigino venne sciolto, ma la presenza di Togliatti consentí ai dirigenti italiani di non essere spazzati via. Il gruppo dirigente del Pcd’I evitò cosí il tragico destino dell’emigrazione italiana in Unione Sovietica, decimata dalle epurazioni violente, e forse la sua salvezza aggravò quel destino119.
Tra gli elementi centrali dell’inchiesta che minacciò il gruppo dirigente italiano figurava la lettera di Gramsci del 14 ottobre 1926, nella quale egli aveva criticato in un’ottica internazionalista la maggioranza raccolta attorno a Stalin, non meno dell’opposizione trockista. Il carattere assai controverso del documento, evidente sin da allora e rimasto nella memoria come una manifestazione di dissenso che bollava la figura di Gramsci in carcere, diveniva un precedente molto pericoloso. A rinfrescare la memoria a tutti aveva provveduto Tasca, pubblicando la lettera in Francia nell’aprile 1938. Manuiłskij aveva letto il documento all’epoca e di certo non ignorava la pubblicazione di Tasca. Nella sua requisitoria non mancò di citarlo120. Un anno prima, Togliatti aveva celebrato la memoria di Gramsci subito dopo la sua morte, tributandogli un omaggio che mirava a consacrarne la figura simbolica e intesseva un filo rosso di continuità, con l’obiettivo di allontanare ombre e dissidi121. L’operazione non era riuscita pienamente, anche se gettava le basi per una costruzione dell’identità comunista italiana a piú lungo termine. Nella Mosca del 1938, il fantasma di Gramsci tornò a minacciare contaminazioni con il dèmone del «trockismo». Questo marchio d’infamia non era ormai piú usato semplicemente contro gli ex oppositori, o contro i loro sospetti simpatizzanti degli anni Venti. Il termine aveva subíto un’espansione semantica arbitraria e incontrollabile. I capi d’accusa, i piú disparati, persino contraddittori tra loro, potevano essere plasmati e manipolati a seconda delle circostanze, utilizzando qualsiasi antecedente prestasse il fianco al sospetto del complotto, indipendentemente dalle sue presunte o reali finalità politiche. Una spirale priva di un codice decifrabile che destabilizzava l’architettura delle identità comuniste costruite nel tempo in una miscela di logiche razionali e di credenze indiscutibili, costringendo tutti a un surplus di cieca obbedienza.
Il 26 agosto 1938 Togliatti si incontrò con Stella Blagoeva, segretaria di Dimitrov e terminale degli apparati di polizia ai vertici del Comintern. Gli appunti di Blagoeva relativi alla «opinione del comp. Ercoli» riportavano i suoi giudizi personali e politici sui dirigenti del Centro estero. Nella sostanza, Togliatti riconosceva che il Centro si era mostrato incapace di osservare le regole della «vigilanza» e che i rapporti personali si erano gravemente deteriorati, ma evitava di trarre conclusioni piú generali. Nello stesso tempo, si chiamava fuori da passate o future responsabilità, precisando che i suoi consigli politici non erano stati raccolti dai dirigenti del Pcd’I e invitando esplicitamente a non contare su di lui122. Cosí Togliatti difese il gruppo dirigente dai pericoli piú gravi. La sua linea di condotta aveva anche il senso di una difesa personale. Nei mesi precedenti vi era stato almeno un sinistro segnale della possibilità che la crisi tra Mosca e il Pcd’I colpisse non soltanto il Centro parigino, ma anche la sua figura: l’arresto di suo cognato, Paolo Robotti, avvenuto nel marzo 1938. Sebbene Togliatti fosse coinvolto nella vicenda del Pcd’I piú come un dirigente del Comintern che come parte in causa, una simile situazione consigliava estrema prudenza.
Egli si sforzò di riportare l’attenzione sui nodi di natura politica, indicando sostanzialmente due orientamenti caratteristici dell’ispirazione antifascista: restare fermi «sulla linea del VII C.» e non ignorare «le differenze nel campo della borghesia sulla politica estera»123. Queste posizioni esprimevano una volta di piú il legame di Togliatti con Dimitrov e una differenza netta da Manuiłskij, il quale aveva ignorato il tema dell’antifascismo nella sua requisitoria contro il Pcd’I. Togliatti argomentò la propria visione nella relazione sul regime fascista italiano tenuta il 23 agosto a Mosca negli organismi del Comintern. La sua analisi riprendeva elementi del «corso sugli avversari» del 1935. Ma forniva anche spunti per una comprensione della congiuntura internazionale. Il punto principale era che l’annessione dell’Austria alla Germania, compiuta con la forza pochi mesi prima, e la conseguente «discesa di Hitler sul Brennero» costituiva «la piú grossa questione nazionale che si sia presentata dalla Grande guerra». Ciò fomentava, a suo giudizio, le «tendenze antihitleriane» nel fascismo, in opposizione a quelle filohitleriane dominanti nel regime, oltre che un disagio diffuso soprattutto tra i cattolici, e significava la possibilità di un’agitazione «per l’indipendenza nazionale» contro la politica dell’Asse Roma-Berlino124. La situazione del gruppo dirigente italiano era però del tutto inadeguata a realizzare questa ispirazione politica.
La tendenza dei comunisti italiani a fare ammenda del loro passato culminò nella proposta a Togliatti di presentare una pubblica autocritica sulla lettera di Gramsci del 1926. La replica di Togliatti fu nettamente contraria: «Non è consigliabile continuare a parlare di tutte queste cose del passato con questo metodo. Sarebbe un errore legare la vita a venire del partito su questa base. Le cose accadute non si cancellano, restano. Ma non si può legare le cose dell’avvenire a queste»125. Simili parole esprimevano un’accortezza molto superiore a quella sino allora dimostrata dagli altri dirigenti del Pcd’I e una coscienza dei meccanismi infernali delle epurazioni staliniane. Togliatti e i dirigenti italiani restavano comunque in bilico e il profilo di tutti usciva fortemente indebolito dagli anni del Terrore, anche se non vi furono conseguenze peggiori. Una lettera scritta a Togliatti oltre due anni dopo da Armando Cocchi, il fondatore insieme a Gramsci del «Club degli emigrati» italiani nel 1923, poi entrato nei ranghi dell’Armata rossa, costituisce una drammatica testimonianza del clima dell’epoca. Cocchi confidava a Togliatti che durante il periodo del suo arresto, dall’agosto 1938 al gennaio 1939, «mi volevano convincere che eri stato arrestato e fucilato», ma egli si era rifiutato di sottoscrivere una confessione preconfezionata. Dopo il suo rilascio, aveva redatto un promemoria per il rappresentante del Pcd’I nel Comintern, Rigoletto Martini, protestando la propria innocenza e la fede nel partito, ma non aveva avuto il coraggio di inoltrarlo. Ora lo inviava a Togliatti e si rallegrava di saperlo vivo, avendo visto la firma di Ercoli in un appello del Comintern126.
4. La fine del Pcd’I.
Gli orientamenti antifascisti del Comintern conobbero un rapido declino nella congiuntura segnata dalle conseguenze del Grande Terrore, dall’appeasement occidentale verso Hitler e dalla sconfitta nella guerra di Spagna. Dopo la Conferenza di Monaco e lo smembramento della Cecoslovacchia nel settembre 1938, Dimitrov rivolse senza successo appelli a Stalin, con l’obiettivo di rilanciare una mobilitazione antifascista. Anche Togliatti, inviato a Parigi, sollecitò alla metà di ottobre una pubblica presa di posizione sui problemi della lotta per l’unità e per la pace. In particolare, chiese il motivo della mancata resistenza dei comunisti cecoslovacchi e della diminuzione degli aiuti alla Spagna. Togliatti reclamava la necessità di «rinnovare i nostri rapporti politici con gli elementi democratici, i pacifisti, gli intellettuali ecc., tra i quali c’è confusione e un senso di impotenza, che può trasformarsi in ostilità verso la nostra politica di Fronte popolare»127. L’unica risposta fu quella indiretta, ma eloquente, di Manuiłskij. Questi sostenne che i comunisti dovevano parlare «non solo a nome del fronte popolare, ma a nome di tutta la nazione», contrapponendo due concetti che erano invece integrati tra loro nella visione antifascista, e superare le «illusioni pacifiste» per impegnarsi in una linea «nazional-rivoluzionaria»128.
Poco dopo, la guerra di Spagna conobbe il suo esito tragico per i repubblicani. Avendo percepito bene il disimpegno di Mosca, Togliatti si adoperò per una difesa della Repubblica in Spagna anche dopo la caduta di Barcellona, senza però sostenere la difesa a oltranza. Alla fine di febbraio, telegrafò a Mosca da Madrid chiedendo istruzioni circa l’ipotesi di «prendere con la forza» tutte le leve del potere e la «direzione della guerra» nelle mani dei comunisti, con l’obiettivo di prevenire un ammutinamento dei militari e il collasso del governo. La risposta di Dimitrov fu che mancavano le condizioni per una ulteriore assistenza militare sovietica. Prima di riparare in Francia dopo il colpo di Stato militare contro la Repubblica e l’esito catastrofico della guerra civile, Togliatti scrisse da Valencia il 12 marzo una lettera ai dirigenti spagnoli accusando Negrín di tradimento, ma riconoscendo che il Partito comunista aveva perso la fiducia delle masse. La lettera fu consegnata da Dimitrov a Stalin un mese dopo129.
Il peso della sconfitta in Spagna era di tale portata da coinvolgere in modo rovinoso i protagonisti della vicenda. Al suo rientro in Unione Sovietica, nel giugno 1939, Togliatti trovò un fitto e minaccioso dossier di accuse e sospetti a suo carico che lo attanagliò fino allo scoppio della guerra due anni dopo. Il problema principale era il suo ruolo nell’epilogo della guerra civile spagnola. Il 7 aprile 1939, Stalin in persona criticò duramente la mancanza di una strategia e la ritirata senza combattere dei comunisti spagnoli, che ovviamente coinvolgeva le responsabilità del Comintern. Il dittatore respinse l’argomento retrospettivo portato da Togliatti, circa l’impossibilità di aprire un fronte per rovesciare la giunta controrivoluzionaria a Madrid, esaltando come un modello la tattica a suo dire vincente che egli stesso aveva seguito a Caricyn durante la guerra civile russa130. Nel maggio 1939, Manuiłskij scrisse una lettera a Stalin, in cui accusava Togliatti di aver tenuto nascosto lo smarrimento degli archivi del partito spagnolo: un’accusa grave, che equivaleva a mettere in dubbio la capacità di «vigilanza» di Ercoli nella smobilitazione seguita alla fine della guerra civile131. Nel contempo, su Togliatti gravavano inchieste ancora aperte relative all’affidabilità ideologica del gruppo dirigente italiano e alla «questione Gramsci». Tra l’aprile e il giugno 1939 Robotti venne reiteratamente interrogato dall’Nkvd nell’intento di estorcere elementi accusatori132. Togliatti si trovò coinvolto in una indagine di Blagoeva conseguente alla denuncia inoltrata dalla moglie di Gramsci, Julija Schucht e dalle sue sorelle alla fine del 1938, in relazione alle responsabilità per la mancata liberazione del prigioniero133. Subito inviato in Francia da Dimitrov, evitò le conseguenze immediate di una simile situazione, ma molti problemi erano soltanto rimandati al suo ritorno.
La decisione di Stalin per il Patto con Hitler, siglato il 23 agosto 1939, liquidò in pochi giorni l’esperienza internazionalista antifascista dei comunisti. Il suo aggancio alla politica sovietica di «sicurezza collettiva» era finito con la caduta di Litvinov, sostituito da Molotov nel maggio 1939. Stalin scelse l’opzione della sicurezza unilaterale, ritenendo che la sfera d’influenza riconosciuta da Hitler a Mosca nell’Europa orientale, soprattutto la spartizione della Polonia, fosse un dato concreto e utile in vista di una guerra futura. Egli vide il Patto come l’autentico riconoscimento dello status di grande potenza dell’Unione Sovietica, oltre che come l’applicazione della linea bolscevica di dividere il «fronte capitalistico» evitando il pericolo mortale di una guerra antisovietica degli Stati imperialisti. All’inizio del settembre 1939, subito dopo l’invasione tedesca in Polonia e lo scoppio della Seconda guerra mondiale, dettò a Dimitrov le lezioni che dovevano essere tratte dagli eventi: la fine dell’opposizione tra democrazie e fascismi come criterio di orientamento politico e il rilancio della visione indifferenziata del mondo capitalistico, risalente all’epoca pre-Hitler134. Dimitrov si adeguò con riluttanza, abbandonando l’ingenua speranza di poter mantenere una distinzione tra la linea del Comintern e la strategia dell’Unione Sovietica.
Gli effetti del Patto furono disastrosi per tutti i comunisti europei, in primo luogo in Francia. Togliatti si illuse per alcuni giorni, al pari di Thorez, che fosse possibile salvaguardare una linea antifascista, come Celeste Negarville ricordava tre anni dopo nel suo diario135. Il suo arresto a Parigi, il 1° settembre, contribuí ad aumentare il disorientamento. Gli esuli italiani si trovarono allo sbando e senza una bussola da seguire, soprattutto dal momento che il Pcf fu messo al bando e Thorez dovette espatriare. Si verificò, ricorda Amendola, «una dissoluzione totale»136. Alcuni dirigenti di primo piano manifestarono dissenso, in particolare Giuseppe Di Vittorio. Questi fu subito emarginato, pur essendo una figura particolarmente autorevole, protagonista di una combinazione unica tra una lunga attività sindacale, che lo aveva portato alla direzione della Cgil in esilio, e un’esperienza internazionalista a Parigi, a Mosca e nelle Brigate internazionali in Spagna, fino a dirigere il giornale degli emigrati antifascisti in Francia: «La voce degli italiani». Anche Camilla Ravera e Terracini, al confino di Ventotene, respinsero l’annullamento della distinzione tra democrazie e fascismi, sostenuta invece da Scoccimarro e Secchia. In un memorandum scritto nell’autunno 1941, Terracini confermò e argomentò le proprie posizioni, sostenendo che le scelte fatte dal Comintern dopo il Patto fossero espressione di un «estremismo» che vedeva lo Stato sovietico «riadergersi al di sopra del mondo indifferenziato dell’imperialismo», quando invece il suo nemico restava la Germania nazista137. La conseguenza fu la successiva espulsione dal partito, probabilmente con il consenso di Longo, anch’egli al confino dopo l’arresto in Francia. Retrospettivamente, Terracini lo ricordava come l’episodio conclusivo di un dissidio risalente alla «svolta» di dieci anni prima138.
Dopo l’inizio della guerra, il Centro estero del Pcd’I fu trasferito da Parigi a New York, sotto la direzione di Berti. Le circostanze dell’incarico rimasero opache e mai pienamente chiarite. Togliatti riteneva Berti il responsabile principale del suo arresto, macchiatosi di una «negligenza quasi criminale», come scrisse a Dimitrov dopo essere uscito di prigione nel marzo 1940139. La decisione di spostare il Centro estero a New York era stata comunque presa a Mosca. All’inizio del giugno 1940, in una riunione con Dimitrov, Blagoeva annotava che le risorse finanziarie fornite a Berti avevano coperto quasi un anno di lavoro e che l’incarico era confermato, informandone il segretario del Partito comunista degli Stati Uniti, Earl Browder140. La dispersione del nucleo dirigente si completò dopo l’attacco nazista alla Francia. Dirigenti come Amendola, Dozza e Sereni si trasferirono a sud nella Francia di Vichy. Togliatti e Grieco fecero invece ritorno in Unione Sovietica. Togliatti si era adeguato alla linea dell’antimperialismo indifferenziato nelle Lettere di Spartaco, sebbene fosse scettico circa la possibilità che il Patto tra l’Unione Sovietica e la Germania sarebbe durato a lungo141. La sua identificazione con la linea antifascista negli anni passati costituiva un motivo di esposizione personale nel pieno dell’alleanza tra Stalin e Hitler.
Le inchieste a suo carico rimasero aperte. Poco dopo il rientro a Mosca, una nota di Blagoeva ribadiva l’esistenza di un dossier di sospetti attorno alla sua figura. In particolare, riportava il duro giudizio della famiglia Schucht su di lui, oltre a menzionare la lettera di Gramsci del 1926 e le «incertezze» dello stesso Togliatti nel 1929. Nel dicembre 1940, la vedova di Gramsci scrisse una lettera a Stalin, che costituiva l’atto di accusa definitivo e piú grave nei riguardi di Togliatti, giudicato colpevole di tradimento. La questione venne rinviata da Stalin a Dimitrov, il quale si incaricò di trovare una conciliazione e di evitare soluzioni poliziesche142. Nello stesso momento, Dimitrov sollecitò Togliatti e Vincenzo Bianco a scrivere sulla situazione in Italia e sulla guerra di Mussolini alla luce del disastro militare in Grecia, ritenendo che non se ne parlasse a sufficienza sulla stampa del Comintern143. Piú che un rimprovero, era un segno di attenzione, che preludeva alla ripresa dell’analisi congiunta di Germania e Italia nel Comintern, compiuta all’inizio del 1941. Sulle Lettere di Spartaco comparve uno scritto che riprendeva il motivo della possibile destabilizzazione del regime, risalente alla guerra d’Etiopia, ma guardava ai gruppi «antifascisti o afascisti» che si potevano attivare nel paese a causa dei primi rovesci militari144.
Dimitrov coinvolse Togliatti in alcune decisioni strategiche, come ad esempio la scelta di interrompere il legame tra il Comintern e il Partito comunista degli Stati Uniti, con il fine di evitarne la messa al bando, e la correzione della linea compromissoria dei comunisti francesi tra Parigi e Vichy145. Ma soprattutto, il 21 aprile 1941 Dimitrov riportò a Togliatti e Thorez la questione del possibile scioglimento del Comintern, posta da Stalin il giorno prima con l’invito a seguire l’esempio del partito americano per far meglio radicare i partiti nel proprio paese, mantenendo la loro identità «ma non con lo sguardo rivolto a Mosca». Togliatti e Thorez espressero il loro assenso all’idea di porre fine all’attività dell’Esecutivo e di sostituirlo con «un organo di informazione e di sostegno politico e ideologico dei partiti comunisti»146. In altre parole, il tema del rapporto con la nazione, posto dai Fronti popolari, non era stato cancellato dal Patto Molotov-Ribbentrop, ma piuttosto artificiosamente separato dall’antifascismo, come fu evidente nel caso della Francia147. La stessa “deradicalizzazione” degli obiettivi del movimento, limitati alla difesa delle istituzioni repubblicane in Spagna e alla liberazione nazionale in Cina, era un indirizzo rimasto sostanzialmente invariato. Persino il silenzio sulla nozione di rivoluzione mondiale, calato nei discorsi di Stalin dopo il 1934, non si era interrotto e anzi implicava un giudizio negativo sulla prospettiva strategica della guerra civile in Europa sin dal tempo di Lenin. Tale continuità rappresentava una carta da giocare per figure come Togliatti o Thorez, anche se la questione della fine del Comintern rimase in sospeso e non ebbe seguito per il momento.
Il giorno dopo l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica, avvenuta il 22 giugno 1941, Dimitrov formò una «direzione permanente» del Comintern con Manuiłskij e Togliatti148. L’annuncio di un immediato ritorno a parole d’ordine nazionali e antifasciste rappresentava un terreno molto piú congeniale a Togliatti. Ciò nonostante, questi conobbe ugualmente una vera e propria disgrazia, che sembrò intaccare persino il suo rapporto con Dimitrov. Le ombre su di lui legate alla questione spagnola non si erano mai dissipate. I dirigenti spagnoli ripresero ad alimentare sospetti subito dopo l’inizio della guerra. Díaz fece sapere a Dimitrov, tramite Blagoeva, di non avere fiducia in Togliatti. Il 19 luglio ribadí il proprio giudizio insieme a Ibárruri, che rincarò la dose affermando di avvertire nel dirigente italiano «qualcosa di estraneo, di non nostro». Dimitrov annotò la decisione di escludere Togliatti dalla partecipazione a «questioni strettamente segrete»149. Di fatto, Togliatti cessava di esercitare il ruolo rivestito dal 1935 in avanti quale dirigente di primo piano del Comintern, mentre il gruppo dirigente italiano, o ciò che ne restava, era disperso e diviso.
I dirigenti del Pcd’I avevano fallito l’obiettivo, tenacemente perseguito, di costruire contatti significativi nel paese, erano stati dilaniati da conflitti personali e si erano sottratti fortunosamente alle purghe. Il riscatto cercato nella lotta internazionalista spagnola aveva generato momenti esaltanti ma si era infine risolto in una cocente sconfitta. Dopo l’inizio della guerra costituivano, in sostanza, un gruppo di déracinés, staccati dalla realtà dell’Italia. Nella Francia caduta sotto il nazismo, Antonio Roasio ricorda come essi fossero «un piccolo gruppo di naufraghi, in balía delle onde infuriate», percepiti doppiamente nemici per la loro identità politica e nazionale150. Ma altri erano destinati alla marginalità e alla repressione anche nella “patria socialista”, compresi i reduci della guerra di Spagna. Il Patto tra Stalin e Hitler aveva declassato i protagonisti della stagione dei Fronti popolari a Mosca come altrove. L’angoscia per questa realtà, che investiva anche la sfera privata dei “rivoluzionari di professione”, è ben riflessa nel diario tenuto da Negarville nella Parigi occupata e nei costanti pensieri rivolti ai suoi cari che vivevano a Mosca151.
Il bilancio personale di oltre un decennio era per Togliatti estremamente controverso. Egli aveva seguito Stalin in nome del realismo per trovarsi completamente disorientato dalle conseguenze estreme della “rivoluzione dall’alto”. Si era adeguato con riluttanza alle tesi ultraradicali del Comintern stalinizzato sul «socialfascismo» ma ne aveva anche condiviso gli effetti, la liquidazione di personalità come Gramsci e Tasca e l’accantonamento di parte essenziale del patrimonio intellettuale costruito negli anni Venti. Aveva trovato il proprio riscatto nel ruolo svolto al momento della conversione antifascista del Comintern e fornito un contributo di idee all’analisi del fascismo, alla «lotta per la pace» e alla «democrazia antifascista». Ma in Spagna aveva seguito sia la linea del Fronte popolare sia le pratiche persecutorie contro il «trockismo», fortemente divisive dell’internazionalismo antifascista. Alla vigilia della guerra, la posizione dello stesso Togliatti sembrava minacciata da svariate fonti di tensione e indagini poliziesche, che riflettevano come in uno specchio deformato le ambivalenze delle sue scelte e responsabilità. Tra queste continuava a figurare la questione di Gramsci, piena di implicazioni personali, politiche e simboliche. Dopo la morte di Gramsci, egli si era impegnato per occultarne il dissenso e dipingerlo come il capo del comunismo italiano, con l’obiettivo di allontanare dal partito sospetti minacciosi ma anche di costruire una risorsa mitologica. Ora sapeva che il suo vecchio compagno si era ribellato al rituale del sacrificio in nome dell’interesse superiore del partito ed era giunto a sospettarlo di averlo abbandonato al suo tragico destino, affidando ai propri cari la pesante eredità di un conflitto politico e personale lacerante.
Sotto la pressione dell’indagine che ne era nata, ancora in corso a suo carico, Togliatti lesse i quaderni scritti in carcere da Gramsci, che erano giunti a Mosca nel 1938, mentre si trovava in Spagna. Il 25 aprile 1941 egli annunciò a Dimitrov di averli studiati «quasi tutti in modo scrupoloso». Si diceva contrario a lasciare presso la famiglia una copia dei manoscritti di Gramsci, perché questi contenevano «materiali che possono essere utilizzati solo dopo una precisa rielaborazione», in mancanza della quale «il materiale non può essere utilizzato e addirittura se alcune parti fossero usate nella forma in cui si trovano attualmente, potrebbero non essere utili al partito»152. Togliatti cercava di volgere a proprio favore la contesa con la famiglia Schucht utilizzando un collaudato argomento di controllo politico e ideologico, se non di censura. L’allusione al carattere scomodo degli scritti di Gramsci era molto trasparente, per quanto il linguaggio utilizzato da Togliatti fosse cauto. Egli conosceva bene gli stretti confini di ciò che era lecito in Unione Sovietica. E tuttavia, proprio l’argomentazione di Togliatti rivelava la sua consapevolezza tanto del carattere eterodosso degli scritti gramsciani quanto del loro valore. Quei materiali lo ricollegavano a un’eredità intellettuale e a un modo di pensare analitico che non gli erano certo estranei, sebbene il loro originario significato politico fosse ormai perduto.
Una simile duplicità di materiali, tra la cultura politica stalinista e l’eredità gramsciana, sarebbe riemersa anni dopo in condizioni storiche diverse e imprevedibili alla vigilia della guerra. Possiamo però facilmente ritenere che fosse evidente a Togliatti sin da quel momento. Il comunismo italiano aveva conosciuto rovesci analoghi a tutti gli altri partiti europei, senza poter vantare autentici momenti di gloria a differenza di quello francese o spagnolo. Restavano gli incunaboli di un patrimonio intellettuale che nessun altro movimento comunista possedeva in Europa e che sul piano globale, in circostanze profondamente diverse, forse soltanto i comunisti cinesi avevano accumulato in anni piú recenti sotto la guida di Mao Zedong. Come tutti i dirigenti comunisti, dopo l’attacco della Germania nazista all’Unione Sovietica, Togliatti fu libero di tematizzare la questione della nazione, con la differenza che i suoi strumenti culturali erano decisamente piú solidi di altri. Ora che la guerra di Hitler a Est prefigurava la possibilità di un riscatto, le visioni, le analisi e le identità legate all’antifascismo costituivano una risorsa essenziale.
PARTE SECONDA
Influenze: internazionalismo e nazione (1943-1964)
Capitolo terzo
«Partito nuovo» e guerra fredda
1. La “nazionalizzazione” dei comunisti.
La dissoluzione del Comintern nel giugno 1943 fu il prologo di una dimensione di massa senza precedenti per molti partiti comunisti. Una nuova legittimazione emerse dalla combinazione tra la guerra sovietica contro Hitler e l’efficacia dell’appello nazionale e antimperialistico sul piano globale. L’interazione tra la controffensiva dell’Armata rossa dopo Stalingrado e la crescita dei movimenti di resistenza antifascista favorí il reclutamento di una nuova generazione di giovani comunisti. Il loro internazionalismo non aveva piú bisogno di un «partito mondiale della rivoluzione», perché si combinava con una missione nazionale imposta dalla lotta al fascismo e coniugava con disinvoltura i concetti di classe e nazione. Ormai il vocabolario internazionalista aveva mutato lemmi e significati. Stalin non concepí una semplice operazione cosmetica quando affermò nel maggio 1943, a sostegno della scelta di sciogliere il Comintern, che occorreva impedire ai nemici di presentare i comunisti come «agenti di uno Stato straniero», rafforzare i partiti come «partiti operai nazionali» e cosí consolidare «l’internazionalismo delle masse popolari, la cui base è l’Unione Sovietica». L’idea di “nazionalizzare” i partiti comunisti non fu una retorica ma un progetto politico, che traeva qualche lezione dai fallimenti del Comintern1.
Il ruolo di Togliatti va compreso in questo contesto. Nell’opera di propaganda promossa dopo l’invasione nazista dell’Unione Sovietica, prima da Mosca poi, dopo l’evacuazione dell’apparato del Comintern, da Ufa in Asia centrale, egli aveva impiegato come tutti il linguaggio dell’«unità nazionale», adattandolo alla storia e alla cultura dell’Italia. Rivolta anche ai soldati dall’Armata fascista che aveva invaso l’Unione Sovietica e ai prigionieri italiani, la propaganda cominciò a presentare un’efficacia plausibile con i segni di crisi dell’impresa bellica di Mussolini e di malcontento popolare, in parallelo alla svolta della guerra determinata dalla battaglia di Stalingrado. In una lettera scritta a Vincenzo Bianco nel febbraio 1943, Togliatti sostenne una linea punitiva verso l’Italia, auspicando l’accoglienza degli anglo-americani come liberatori anche al prezzo dei bombardamenti sulle città italiane. Dipinse la dura lezione della disfatta dell’esercito invasore in Russia come una necessaria presa di coscienza, fino al punto di ostentare una crudele indifferenza per il tragico destino dei prigionieri italiani. Avrebbe anche discusso con Stalin l’impiego di prigionieri per formare un contingente armato antifascista, poi rimasto lettera morta. Togliatti partecipò alla decisione di sciogliere il Comintern nel giugno 1943, ben sapendo che Stalin aveva prospettato una simile operazione due anni prima, con motivazioni quasi identiche circa l’idea di favorire il radicamento nazionale dei partiti2.
I comunisti italiani furono tra coloro che maggiormente trassero beneficio dalla svolta del 1943, malgrado la mancanza di un rilevante radicamento popolare alle origini, il lungo periodo di illegalità alle loro spalle e l’influenza lasciata nella società dall’anticomunismo fascista. I motivi di questa ascesa furono molteplici, ma possono essere compresi soltanto alla luce della discontinuità profonda verificatasi nella storia italiana tra la caduta del fascismo il 25 luglio e l’armistizio dell’8 settembre. Il collasso dello Stato, la spaccatura territoriale tra il Sud liberato dagli anglo-americani e il Nord invaso dalla Germania nazista, la nuova irruzione della politica di massa convogliata dalla Resistenza e dagli antifascisti contro il nazismo e la repubblica collaborazionista di Mussolini, segnarono un punto di non ritorno. Per la prima volta nella storia dell’Italia unita, ha scritto Claudio Pavone, «gli italiani vissero in forme varie un’esperienza di disobbedienza di massa», che presentava significati di libertà nello sfacelo del paese3. Il crollo istituzionale, la frattura dell’unità territoriale e lo scoppio di una guerra civile crearono un’estrema fluidità e incertezza sociale ed esistenziale che investiva le forme e le basi stesse dell’autorità, generando la necessità di nuove strutture di senso individuali e collettive4. In questo contesto, è difficile sopravvalutare la congiuntura internazionale che per alcuni aspetti fece dell’Italia un laboratorio della fase finale della guerra in Europa. Il collasso italiano significava anche l’azzeramento dei confini tra le dimensioni nazionale e internazionale. La presenza sul territorio degli eserciti nazisti e anglo-americani proponeva modelli radicalmente opposti per il dopoguerra, ben decifrabili persino da una popolazione civile stremata e ripiegata sulla difesa quotidiana della sopravvivenza propria e dei propri cari. Gradualmente, l’influenza materiale e simbolica delle grandi potenze alleate, compresa l’Unione Sovietica, si impose, insieme alla Chiesa cattolica, come fattore di ordine e promessa di ricostruzione, interagendo in modi controversi con la mobilitazione resistenziale.
La fine del regime fascista in Italia impose repentinamente ai comunisti e agli antifascisti di trasformare gli appelli in una politica. Gli eventi di guerra misero cosí Togliatti in una posizione unica. Egli fu il primo dirigente comunista europeo, nell’esilio moscovita, a formulare le linee di una politica nazionale concreta per il dopoguerra. Togliatti scrisse a Dimitrov subito dopo la caduta di Mussolini, il 27 e il 30 luglio 1943, per sollecitare il proprio rientro nel paese. Egli delineava già allora una prospettiva politica: abdicazione del re, formazione di un governo provvisorio per il «ripristino delle libertà democratiche», convocazione di un’Assemblea costituente. Riteneva però sbagliato aprire una contrapposizione frontale con la monarchia malgrado le sue responsabilità per la catastrofe provocata dal regime fascista5. Cosí l’articolazione della politica nazionale si faceva un dato reale per i comunisti italiani, non una semplice retorica, subito dopo lo scioglimento del Comintern. Togliatti dovette però attendere a lungo per avere una risposta dalle massime autorità sovietiche. Il 14 ottobre, dopo la dichiarazione di guerra italiana alla Germania e alla vigilia della Conferenza di Mosca tra i ministri degli Esteri delle potenze alleate, protestò apertamente contro il fatto che la questione del suo rientro in Italia restasse irrisolta. Sollecitò anche una decisione circa la questione della partecipazione dei comunisti al governo Badoglio. A suo giudizio, nel caso di un invito ufficiale dello stesso Badoglio, sarebbe stato difficile per i comunisti italiani opporre un rifiuto6. In altre parole, Togliatti propose di tradurre il tema dei «fronti nazionali» in una scelta politica moderata di collaborazione con tutte le forze che si prefiggevano di combattere il nazismo e il fascismo.
La Conferenza di Mosca, nell’ottobre-novembre 1943, registrò un’impegnativa presa di posizione sovietica, che non si limitava al principio dell’eradicazione del fascismo come obiettivo fondamentale della politica alleata in Italia, compiuto nella Dichiarazione finale. I sovietici insistettero per la creazione di un Consiglio consultivo alleato sull’Italia, con sede ad Algeri. Mosca si aspettava di esercitare la propria influenza nel paese tramite questo organismo, nel quale venne nominato un personaggio di primo piano come Andrej Vyšinskij, il vice di Molotov, nell’ottica della «riorganizzazione» del governo Badoglio «tramite l’inclusione in esso di rappresentanti dei gruppi antifascisti»7. Tale posizione era pienamente consonante con quella espressa da Togliatti. Il 2 novembre, questi scrisse a Manuiłskij che la propria permanenza a Mosca era contraria «agli interessi del mio partito e ai nostri interessi generali, e senza significato»8. Gli inviò anche i nomi di un «ristretto gruppo di attivisti» per i quali chiedeva l’immediato rientro in Italia. Oltre al suo, figuravano quelli di Grieco, Bianco, Edoardo D’Onofrio, Teresa Mondini e Rita Montagnana. Non era il nucleo di un gruppo dirigente, né passato, né futuro, ma piuttosto il segnale di un’urgenza che riguardava la personalità del leader9.
La ricostruzione di un gruppo dirigente era tutta da compiere dopo la disgregazione del quindicennio passato e doveva avvenire, come prima della guerra, per cooptazione sotto la direzione di Togliatti10. La diaspora dei dirigenti comunisti provocata dalla guerra si doveva ricomporre solo in parte. Il Centro estero ricostituito a New York sotto la guida di Berti e Ambrogio Donini aveva tenuto in vita «Lo Stato Operaio» e lo aveva diffuso nelle comunità italiane, anche in America Latina. Togliatti era in contatto con il Centro11. Ma il gruppo newyorkese non rappresentò un’ipoteca sulla direzione politica da ricostruire. Ben diversa era la rilevanza dei dirigenti comunisti scarcerati o rientrati dall’esilio francese, come Scoccimarro e Amendola, che nell’autunno 1943 guidavano le prime mosse del partito al Sud e a Roma, e come Longo e Secchia, che nella Resistenza al Nord si richiamavano esplicitamente al modello della guerra di Spagna e svolgevano un’opera cruciale di direzione e organizzazione nel movimento di liberazione12. I due centri mostravano la vitalità dei comunisti nel banco di prova rappresentato per tutti gli antifascisti dalla presa di contatto con il paese reale, ma rischiavano anche, come accadde, di entrare in contrasto tra loro13. In ogni caso, i comunisti italiani si presentarono ben presto come una forza molto importante della Resistenza, inserendosi nella tendenza globale già delineata, che vedeva i partiti comunisti quasi ovunque protagonisti in Europa e in Asia, grazie al loro ethos militarizzato, alle tradizioni di clandestinità e alla capacità di fare proprio il senso della liberazione nazionale14.
Nel discorso tenuto il 26 novembre 1943 presso la Casa dei sindacati, Togliatti fissò i punti essenziali della linea politica da seguire, quali emergevano alla luce della Dichiarazione di Mosca: rinvio della questione istituzionale al dopoguerra, con la proposta di convocare un’Assemblea costituente, e accento sull’unità della nazione e delle forze democratiche. Queste coordinate seguivano lo spirito del primo incontro dei Tre Grandi svoltosi a Teheran pochi giorni dopo, che inaugurò lo scenario della coalizione antifascista. Tuttavia, la effettiva applicazione di una simile linea era subordinata al complicato gioco che si instaurò tra la diplomazia sovietica e gli antifascisti in Italia.
La decisione del Cremlino di inviare Vyšinskij in Italia nel dicembre 1943 e nel gennaio 1944, subito dopo Teheran, forní il segnale piú chiaro della rilevanza della partita ingaggiata tra le grandi potenze nel paese. La posizione maturata da Vyšinskij dopo i suoi colloqui con il segretario generale del ministero degli Esteri italiano, Renato Prunas, ci è ora nota grazie a una lettera inviata dall’emissario sovietico a Molotov da Algeri. Vyšinskij riteneva che si stesse chiaramente verificando un passaggio dell’Italia sotto l’influenza della Gran Bretagna, malgrado la preferenza a suo parere espressa dai «poteri italiani» per gli americani, e che ciò avrebbe prodotto un rafforzamento della monarchia, imponendo limiti all’azione delle sinistre. A suo giudizio, occorreva perciò «garantire la nostra influenza nel Comitato di Liberazione Nazionale»15. In sostanza, Vyšinskij non proponeva una mossa diplomatica dell’Unione Sovietica verso il governo Badoglio ma l’esercizio di un’influenza nel paese tramite il ruolo del Partito comunista nel Cln. Cosí la missione diplomatica di Vyšinskij si intrecciò con le opzioni della politica comunista e le influenzò seriamente.
Il 24 gennaio 1944 Dimitrov scrisse a Molotov, sottoponendogli un «progetto di risposta ai compagni italiani», che aveva stilato con Togliatti. Dimitrov era già a conoscenza delle informazioni trasmesse da Vyšinskij dopo i suoi incontri con Spano e con Prunas. Il documento indicava di mantenere la pregiudiziale antimonarchica e di non prendere parte al governo Badoglio16. Una posizione che liquidava l’apertura collaborativa avanzata in precedenza da Togliatti, accoglieva le posizioni intransigenti dei comunisti locali e seguiva l’idea di consolidare l’influenza comunista nel Cln, come suggerito da Vyšinskij. Molotov approvò il documento pochi giorni dopo, il 29 gennaio17. L’opzione intransigente fu perciò incoraggiata dal capo della diplomazia sovietica, che era anche la personalità piú vicina a Stalin. Un mese piú tardi, sotto la supervisione di Dimitrov e Manuiłskij, Togliatti redasse un documento «sui compiti attuali dei comunisti italiani» che recepiva questa linea politica intransigente. I suoi punti essenziali erano la proposta di formare un «governo provvisorio democratico» con a capo Sforza, la richiesta dell’abdicazione del re, il rifiuto di prendere parte al governo Badoglio, l’unità delle forze antifasciste rappresentate nel Cln, l’Assemblea costituente18. Il documento fu scritto dopo che Vyšinskij era rientrato a Mosca e si era incontrato con Stalin e con Molotov. Possiamo perciò concludere che, contrariamente a quanto si è piú volte sostenuto, la missione di Vyšinskij non aprí prospettive per un accordo diplomatico e anzi giocò un ruolo essenziale nel determinare un irrigidimento di Mosca e un’inversione di tendenza rispetto alla linea collaborativa prospettata negli ultimi mesi del 194319.
Il 1° marzo, Dimitrov chiese a Molotov di ricevere Togliatti prima della sua partenza, prevista per il 4 marzo 194420. L’incontro si svolse, in realtà, fra Togliatti e Stalin, alla presenza di Molotov e Vyšinskij, nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Le decisioni prese segnavano un nuovo ribaltamento di strategia. Si stabilí infatti di consentire la partecipazione dei comunisti al governo Badoglio e di abbandonare la pregiudiziale dell’abdicazione del re. Le motivazioni riportate da Togliatti a Dimitrov, all’indomani dell’incontro, si incentravano sull’esigenza di evitare una spaccatura nel campo delle forze avverse a Hitler e a Mussolini e di ostacolare l’influenza della Gran Bretagna: «L’esistenza di due campi (Badoglio-il re e i partiti antifascisti) indebolisce il popolo ital[iano]. Questo è vantaggioso per gli inglesi, che vorrebbero un’Italia debole nel mare Mediterraneo. Se anche nel futuro si protrarrà la lotta tra questi due campi, ciò porterà alla rovina del popolo italiano». Sulla base di quanto riferitogli, Dimitrov annotò anche che «i comunisti possono entrare nel governo Badoglio allo scopo di premere per l’intensificazione della lotta contro i tedeschi, di procedere alla democratizzazione del paese e pervenire all’unità del popolo italiano»21. Sin da questo momento, l’influenza del comunismo italiano venne concepita dai protagonisti sia in un’ottica nazionale, sia in un’ottica geopolitica, come mostra l’accenno al ruolo dell’Italia nel Mediterraneo in funzione antibritannica. In altre parole, il ruolo dei comunisti italiani si legava alla ripartizione degli interessi di potenza in Europa e nel Mediterraneo nel contesto dei nuovi rapporti di forza tra il mondo sovietico e il mondo capitalistico. Tale impronta restò nella loro missione, anche nelle svariate metamorfosi del dopoguerra.
L’incontro tra Stalin e Togliatti segnò un cambiamento di rotta congiunto nella strategia dell’Unione Sovietica e nella linea politica dei comunisti, che in gran parte ricalcava posizioni già emerse alla fine del 1943. Fino all’ultimo tutti i protagonisti oscillarono tra opzioni diverse. La scelta di collaborare o meno con il governo Badoglio dipendeva dalla decisione sovietica di intervenire sul teatro italiano mediante un’iniziativa politico-diplomatica o di reagire con una linea intransigente alla propria emarginazione, assecondando le posizioni dei comunisti locali. Stalin si pronunciò infine per l’orientamento collaborativo, scegliendo tra due opzioni che erano state entrambe delineate da Togliatti, la prima in solitudine, la seconda sotto l’influenza di Vyšinskij e di Molotov. Tale scelta era coerente con la mossa di riconoscere il governo Badoglio e mettere cosí in difficoltà gli anglo-americani. Probabilmente era anche la scelta piú congeniale a Togliatti, viste le posizioni che egli aveva preso autonomamente negli ultimi mesi del 194322.
Togliatti si trovò a ricoprire una responsabilità molto rilevante, nella veste del leader del partito comunista europeo che in anticipo su tutti gli altri doveva formulare una politica concreta. Le implicazioni del processo decisionale che lo vide coinvolto andavano molto oltre la questione italiana, perché riguardavano l’applicazione della formula dei «fronti nazionali», le visioni dell’Europa da ricostruire, la natura delle relazioni da instaurare tra gli alleati nella prospettiva del dopoguerra. Il suo ritorno in Italia doveva aprire la strada alla funzione dei dirigenti comunisti europei esiliati a Mosca, destinati a beneficiare di un’investitura indiscutibile quasi ovunque, con l’eccezione della Iugoslavia e della Grecia dove i gruppi dirigenti furono invece diretti dalle personalità legate all’esperienza resistenziale. Seguendo le indicazioni di Stalin, egli fece da battistrada per la linea realista rivolta a contenere il radicalismo dei dirigenti locali nei movimenti di liberazione nazionale. Ma fu anche un interprete dotato sin dall’inizio di una propria visione delle dinamiche tra politica nazionale e internazionale, che non può essere visto come un mero esecutore delle direttive di Stalin23.
La dichiarazione di disponibilità a entrare nel governo, fatta da Togliatti a Salerno il 30 marzo 1944, subito dopo il suo rientro in Italia, rappresentò cosí il lancio di una strategia dei comunisti in Europa. Come Stalin aveva suggerito di fare, Togliatti occultò nel suo discorso pubblico il nesso con la strategia dell’Unione Sovietica, ma esso era ovvio e ben compreso sia dai seguaci sia dagli avversari. Benedetto Croce annotò nel proprio diario che la «svolta di Salerno» era «un abile colpo della Repubblica dei Soviet vibrato agli anglo-americani»24. Le conseguenze in Italia furono immediate e portarono alla formazione di un nuovo governo Badoglio, liquidando la pregiudiziale antimonarchica nel campo antifascista. Una volta garantito l’ingresso dei comunisti nel governo di coalizione e accantonata temporaneamente la questione della monarchia, la linea da seguire poteva essere soggetta a diverse interpretazioni: come un ripiego tattico in vista del precipitare di una crisi rivoluzionaria e di una rottura della coalizione internazionale tra l’Urss e le potenze occidentali; oppure come una scelta strategica che mirava alla conquista pacifica del potere per via democratica e prevedeva la continuazione dell’alleanza dopo la fine della guerra. Le due posizioni erano entrambe rappresentate tra i dirigenti europei e sovietici. Lo stesso Togliatti, nei suoi primi mesi in Italia, si mostrò talvolta incerto e chiese lumi a Mosca su quale fosse la soglia da rispettare nelle critiche da rivolgere agli alleati anglo-americani. La risposta di Mosca, concordata da Dimitrov e Manuiłskij con Molotov all’inizio di giugno, fu di continuare a seguire la linea delle ampie alleanze antifasciste25.
Nell’ultimo anno di guerra, Togliatti seguí sempre piú strettamente una strategia rivolta a mantenere l’unità nazionale, evitare una guerra civile e garantire ai comunisti un rilevante ruolo di governo per la prima volta nella loro storia. L’idea che una rivoluzione sociale in Italia non fosse inevitabile contraddiceva un’opinione assai diffusa anche tra socialisti e azionisti. Il modo di essere «nazionali» creò fin da questo momento linee di frattura nel movimento comunista, che percorrevano trasversalmente il corpo dei partiti e i gruppi dirigenti. In un simile panorama, la «svolta di Salerno» e la successiva azione politica di Togliatti costituirono un modello politico che non era limitato alla congiuntura della guerra. Esso implicava un’alternativa internazionalista ai sogni rivoluzionari coltivati sul modello del primo dopoguerra, una ricerca d’influenza legata al nuovo ruolo mondiale dello Stato sovietico, un tentativo di stabilire il ruolo dei comunisti come componente legittima di una comunità nazionale da ripensare dopo il fascismo e una versione della politica di massa rivolta all’integrazione sociale.
La linea di «unità nazionale» seguita da Togliatti si trovò però sotto il fuoco di una critica intransigente, che nel settembre 1944 vide protagonista il rappresentante sovietico in Europa, Aleksandr Bogomolov. Nel settembre 1944, questi accusò il segretario del Pci di non avere un programma politico rivolto alla mobilitazione di massa in vista della fine della guerra26. La visione di Bogomolov non era isolata. Egli si faceva portavoce di tendenze radicali transnazionali del movimento comunista, che avevano il loro epicentro nel gruppo dirigente iugoslavo guidato da Josip Broz Tito, ma forse anche appoggi a Mosca. Nello stesso tempo, sentimenti molto simili erano nutriti dai dirigenti della Resistenza al Nord, come Secchia, che avevano mal digerito la «svolta di Salerno» e che, a differenza di Togliatti, vedevano la guerra di liberazione italiana in piena continuità con la «democrazia di tipo nuovo» della guerra di Spagna27. Emersero cosí visioni diverse circa il significato della preponderanza di potere stabilita dall’Armata rossa nell’Europa orientale dopo l’estate 1944, come il prologo annunciato di una realistica ripartizione delle sfere d’influenza tra gli alleati o come il possibile inizio di una escalation rivoluzionaria nei Balcani e nell’Italia del Nord. In questo contesto, Togliatti giocò un ruolo che non riguardava soltanto la politica italiana. Egli mantenne un’intesa a distanza con Stalin, risolutamente contrario ad azioni rivoluzionarie nei paesi sotto il controllo anglo-americano, che avrebbero potuto mettere a rischio la formazione della sfera d’influenza sovietica e i rapporti con le potenze alleate. Nell’incontro con Winston Churchill dell’ottobre 1944 sulla ripartizione delle sfere d’influenza nell’Europa sud-orientale, Stalin rassicurò il leader britannico circa le prospettive dei comunisti in Italia, affermando che Togliatti non era un politico incline a imbarcarsi in «avventure» senza sbocco28. La sostituzione di Bogomolov con Michail Kostylev, ambasciatore sovietico a Roma dall’ottobre 1944, fu un segnale del sostegno di Stalin a Togliatti. Questi si dichiarò contrario alla linea «classe contro classe» per motivi che riguardavano la situazione interna e internazionale. La sua condotta mostrò una decisa opposizione alle tendenze piú intransigenti e il rigetto di ogni ipotesi di insurrezione armata. In tal senso si espresse, ad esempio, nel suo incontro con Edvard Kardelj, uno dei principali collaboratori di Tito, nell’ottobre 194429. Egli sapeva che Thorez sarebbe rientrato in Francia da Mosca dopo aver concordato con Stalin una linea politica analoga a quella stabilita nella «svolta di Salerno», fin da allora pensata anche in relazione alla situazione francese30. Nel dicembre 1944, Togliatti impose al gruppo dirigente una netta opzione per la linea dell’unità nazionale, ammonendo che una simile scelta aveva anche un significato internazionale. Cosí mise in scacco le tendenze intransigenti rappresentate esplicitamente da Scoccimarro ma diffuse nel partito anche se silenti31.
Togliatti considerava il proseguimento dell’alleanza di guerra come un interesse dell’Unione Sovietica ai fini della sua ricostruzione economica, ma anche un’esigenza volta a rimuovere l’isolamento prebellico e il carattere settario di gran parte dei partiti comunisti, lascito di una condizione minoritaria ormai da archiviare. Il contesto collaborativo internazionale era soprattutto la condizione per definire un profilo dell’Italia inserito nel mondo bipolare e svincolato dalla velleità di svolgere una propria politica di potenza, ancora nutrita da una parte delle classi dirigenti del paese. In questo modo, Togliatti combinò il legame internazionalista del Pci con il suo profilo nazionale, che aveva preso a elaborare dopo l’8 settembre 1943. Questo discorso non costituiva soltanto una pedagogia volta a comprimere le potenzialità rivoluzionarie della mobilitazione resistenziale, come è stato talvolta interpretato. Al contrario, forniva un codice ben decifrabile per tutti, connesso con le aspettative messianiche e di redenzione morale e sociale diffuse nella lotta partigiana, che teneva assieme il tema del riscatto nazionale con il mito sovietico della società giusta. Il tema dell’internazionalismo come antidoto al nazionalismo e come dimensione irrinunciabile per un paese come l’Italia doveva ridefinire il senso stesso della nazione. Sotto questo profilo, la visione di Togliatti si inseriva in un contesto di idee internazionaliste piú largo di quello comunista, generato dalle reazioni alla catastrofe del nazionalismo e orientato dalla prospettiva di profondi cambiamenti sociali32.
Togliatti non si spinse cosí lontano come Browder, nell’immaginare la ricostruzione politica postbellica come una rinuncia al centralismo di partito della tradizione comunista. Egli non prestò il fianco all’accusa fatale, rivolta al leader americano prima da Dimitrov e poi, pubblicamente, da Jacques Duclos, di abbandonare i principî di classe trasformando il partito in un movimento di opinione33. Si serví anzi della forma partito come strumento della modernizzazione politica in Italia, modificando elementi costitutivi della pratica cominternista. Sin dal momento della «svolta di Salerno», annunciò che «la nostra politica è una politica di massa», con l’obiettivo di dare alla vita della nazione «un contenuto nuovo», rovesciando sull’imperialismo fascista e sulle classi dirigenti che erano state complici del regime l’accusa di essere stati «antinazionali». La lezione fatta propria da Togliatti era che «la nazione non si può limitare a prendere atto della catastrofe e a precisarne i responsabili» ma doveva trovare «una via di salvezza». Con un’allusione autocritica al ruolo svolto dai comunisti nel primo dopoguerra, affermò che «il nostro dovere è di indicare concretamente questa via e di dirigere il popolo verso di essa». Mettere in pratica tale visione significava che «il carattere del nostro partito deve cambiare profondamente» e che si doveva costruire un «partito di massa» diverso da «una ristretta associazione di propagandisti delle idee del comunismo e del marxismo»34. Due mesi piú tardi, dopo la liberazione di Roma, Togliatti comunicò a Dimitrov che il partito era in crescita ovunque e che un’alta percentuale degli iscritti era formata da credenti, mentre molti erano anche i «comunisti cristiani»35. Il progetto del «partito nuovo» sfidava le altre forze protagoniste della ricostruzione e anzitutto i cattolici, dato che presupponeva il rispetto della libertà religiosa. In linea di principio, esso implicava una concezione della nazione politica che bandiva unicamente i fascisti, piú inclusiva di quella prevalente nel mondo cattolico ufficiale, incline a escludere anche i comunisti36. L’apertura ai credenti si coniugava strettamente con la strategia di coinvolgimento delle donne attorno alla prospettiva dell’emancipazione, che mirava ad allargare la partecipazione politica femminile emersa nell’esperienza resistenziale. Sotto questo profilo, il Pci contribuí al risveglio di una coscienza di genere che doveva travalicare il perimetro dell’appartenenza ai partiti e rendersi autonoma dal loro controllo37. La “femminilizzazione” della politica investí la sfera della cittadinanza democratica, molto meno invece quella dell’internazionalismo.
Alla fine del 1944, la visione di Togliatti si era definitivamente affermata nel gruppo dirigente del Pci. La sua decisiva declinazione internazionale fu recepita pienamente da Giancarlo Pajetta, membro della Direzione Nord ed esponente della Resistenza a fianco di Longo e Secchia, avendo alle spalle una breve ma intensa attività internazionalista a Mosca, nell’Internazionale giovanile, prima di trascorrere un decennio nelle carceri fasciste38. Pajetta sostenne che sarebbe stato sbagliato concepire «il contrapporsi successivo di due mondi assolutamente antitetici: il mondo democratico-sovietico e il mondo capitalista-imperialista», cosí come l’idea di «zone di esclusiva influenza». Per questo respingeva «una concezione semplicistica» che si proponeva di «estendere di qualche chilometro quadrato la superficie direttamente ed esplicitamente sotto il governo sovietico»39. Questa visione riconosceva l’emergere di un ordine bipolare dopo la guerra, ma poneva l’accento sulle interazioni e non sulle antinomie. La nascita di un mondo bipolare non implicava inevitabilmente un antagonismo irriducibile, come pensavano invece i leader iugoslavi. Traspariva un’evidente polemica contro le loro ambizioni all’espansione territoriale. Anche i comunisti piú riluttanti dovettero fare i conti con la visione togliattiana, che si presentava come un’alternativa alle tendenze radicali e come un modo di prospettare uno sbocco costruttivo all’etica del sacrificio e all’enorme potenziale popolare accumulato grazie alla lotta di liberazione, evitando un destino catastrofico. La direzione politica del movimento insurrezionale nei primi mesi del 1945 avvenne sotto il segno di tale visione del mondo del dopoguerra.
Tuttavia, il precipitare della precaria situazione interna e internazionale era una possibilità incombente. Nelle conversazioni dei dirigenti comunisti italiani con l’ambasciatore sovietico trasparí piú volte la preoccupazione che potessero verificarsi eventi drammatici. Il fantasma peggiore era quello di un colpo di Stato e di una messa fuori legge del Partito comunista italiano, anche se le opinioni espresse variavano. Togliatti confidò a Kostylev il timore che forze reazionarie si potessero muovere nell’ottica di un colpo di Stato sul modello franchista40. I comunisti italiani salutarono Jalta come un evento molto positivo in quanto confermava la coalizione dei Tre Grandi. Ma ritennero anche che i risultati della conferenza avrebbero potuto mobilitare coloro che la interpretavano come un cedimento occidentale a Stalin. Togliatti non escludeva che le forze anticomuniste potessero provocare un conflitto con l’obiettivo di distruggere l’organizzazione del Pci41. Nel contempo, la crisi di Trieste mise a dura prova il quadro armonico della combinazione tra la coalizione delle grandi potenze e l’identità nazionale dei comunisti italiani.
La questione della Venezia Giulia era stata oggetto di una intesa generica tra i comunisti italiani e quelli iugoslavi nell’ottobre 1944, che rimandava alla fine della guerra le questioni territoriali piú delicate. Togliatti incontrò Kardelj e Milovan Đilas evitando di prendere posizioni vincolanti su Trieste, ma verosimilmente sottovalutando le ambizioni iugoslave. Sin dall’inizio del 1945, la condotta baldanzosa dei dirigenti iugoslavi lo costrinse a fare appello a Mosca in funzione arbitrale, insistendo sul grave problema che una eventuale annessione di fatto avrebbe creato al comunismo italiano come forza credibilmente nazionale. Egli insistette per una soluzione che prevedesse trattative dirette italo-iugoslave e l’internazionalizzazione della città, pur riconoscendo legittime le mire iugoslave42. A lungo Mosca evitò di rispondere alle sollecitazioni da Roma, mentre Tito non nascondeva le proprie intenzioni annessioniste. Si creò cosí una forte tensione tra comunisti italiani e iugoslavi.
Nella vicenda di Trieste giocò un ruolo rilevante Eugenio Reale, che svolgeva la propria attività a stretto fianco di Togliatti sia nel partito, sia nel governo ricoprendo la carica di sottosegretario agli Esteri. Formatosi in un percorso tormentato tra il carcere e l’emigrazione in Francia, come molti altri, Reale non aveva alle spalle un’esperienza cominternista. Togliatti gli affidò un ruolo di responsabilità internazionale nel contesto del cambiamento generazionale del Pci. In momenti cruciali, egli assolse una delicata funzione nei rapporti con i sovietici. Il 17 aprile 1945, Reale riportò a Kostylev la preoccupazione di Togliatti per il pericolo di un isolamento dei comunisti e per una possibile spaccatura del partito, alludendo alla necessità di evitare il fatto compiuto a Trieste43. Mosca mantenne però un atteggiamento attendista nei rapporti con il Pci anche per qualche tempo dopo l’occupazione iugoslava della città, iniziata il 1° maggio. Il 4 maggio, su incarico di Togliatti, Reale interrogò Kostylev circa l’attendibilità dell’indiscrezione che Stalin avesse promesso Trieste a Tito nell’incontro svoltosi tra i due alla metà di aprile44. È evidente che i comunisti italiani la ritenevano quanto meno verosimile. Alla Direzione del 13 maggio, Togliatti ribadí però che la linea del Pci non cambiava («non accettazione dei fatti compiuti. Necessità di una collaborazione con la Iugoslavia. Difendere italianità di Trieste, non compromettere avvenire di Trieste, rispettare la volontà delle popolazioni iugoslave»)45. Nel frattempo, Togliatti inoltrò a Dimitrov una nuova richiesta di lumi e criticò duramente la condotta unilaterale di Tito, giudicata in contrasto non solo con gli interessi del Pci, ma anche con quelli dell’Unione Sovietica46.
Stalin infine accolse la proposta di Dimitrov per l’annessione di Trieste alla Iugoslavia. Togliatti ne fu informato con un messaggio inviato il 28 maggio47. Il 31 maggio incontrò Kostylev limitandosi a comunicare che poco tempo prima era entrato in contatto con Tito e ammise che il porto di Trieste sarebbe stato piú utile alla Iugoslavia e ai paesi danubiani, che non all’Italia, la medesima argomentazione con la quale gli era stata comunicata la decisione di Stalin48. Nel frattempo, le armate iugoslave confermarono le previsioni piú pessimistiche circa le conseguenze dell’occupazione e iniziarono una sistematica azione di terrore ed esecuzioni sommarie contro la popolazione italiana a Trieste, in Dalmazia e nella Venezia Giulia. Si delineava cosí una situazione insostenibile per la credibilità nazionale del comunismo italiano, che avrebbe potuto compromettere il progetto togliattiano. Non troppo paradossalmente, fu Stalin a fornire una soluzione. Avendo realizzato che la reazione occidentale poteva provocare un conflitto dalle conseguenze imprevedibili, nel giro di pochi giorni egli tornò sulle proprie scelte e ritirò l’appoggio alle rivendicazioni di Tito. In sintesi, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 1945, Stalin pose i comunisti italiani dinanzi al fatto compiuto della decisione in favore degli iugoslavi e poi la ritirò.
Cosí la vicenda di Trieste mise in luce tutta la fragilità della “nazionalizzazione” del Pci nelle mutevoli dinamiche geopolitiche alla fine della guerra. La relazione tra l’«unità nazionale» in Italia e gli interessi dell’Unione Sovietica, stabilita un anno prima, rimase però in piedi grazie al principio non scritto delle sfere d’influenza, che Tito aveva cercato di violare. Poco dopo, all’inizio di agosto, Togliatti affermò in Direzione che «cambieranno i rapporti tra Iugoslavia e Russia» e giunse a indicare l’obiettivo di «evitare il pericolo di una guerra tra Iugoslavia e Russia»49▲. Una tesi estrema e sorprendente, che costituiva segno eloquente delle lacerazioni percepite nella crisi di Trieste e intuiva una frattura destinata a emergere clamorosamente tre anni dopo. Era implicito l’ammonimento a tenere ferma la prospettiva dell’unità del «campo socialista» in formazione ma era anche ovvio che i comunisti italiani, nel caso di un precipitare drammatico dei rapporti tra i due Stati, potevano stare da una parte sola. Inviato a Mosca nell’agosto 1945 in qualità di segretario generale della Cgil per negoziare il doloroso problema dei prigionieri di guerra, Di Vittorio presentò a Stalin una proposta di mediazione su Trieste, che prevedeva uno statuto autonomo transitorio negoziato da Italia e Iugoslavia. Egli colse l’occasione per elogiare il progetto del partito di massa, che contava ormai un milione e mezzo di membri, e ribadire la scelta di evitare la deriva di una guerra civile come quella scoppiata in Grecia, guardando invece alle elezioni all’Assemblea costituente, destinate a costituire una «svolta storica»50. La determinazione a continuare nello spirito di Salerno costituí un deterrente essenziale al dilagare delle violenze e delle vendette che si manifestarono in varie zone del paese dopo la fine della guerra, lasciando intravedere il pericolo di una nuova guerra civile.
2. Il problema dei «blocchi» internazionali e nazionali.
Nel suo discorso al V Congresso del Pci del 29 dicembre 1945, Togliatti illustrò la propria visione incentrata sul rifiuto dei «blocchi» quale interesse principale dell’Italia democratica e sull’opportunità di evitare speculazioni attorno ai contrasti tra le grandi potenze. Il rigetto del nazionalismo di potenza fascista, finalizzato a ripensare il posto del paese nel mondo, costituiva l’ottica principale e il contributo dell’antifascismo a definire le basi dell’interesse nazionale. Questa prospettiva costituiva però, a suo avviso, un obiettivo da conquistare e non un fatto già acquisito. L’indipendenza dell’Italia, affermò, «deve essere riconquistata con un’azione politica lenta, accorta, muovendosi tra scogli e pericoli numerosi». L’ordine mondiale che si delineava nel dopoguerra consentiva però, a suo giudizio, di impegnarsi in una simile azione politica, anche in quanto stava tramontando l’epoca degli imperi, ormai giunti «al punto critico della loro esistenza»51. Togliatti non si impegnava in un’analisi puntuale della politica internazionale ma le implicazioni di questo argomento erano rilevanti, perché alludevano tanto alla fine annunciata degli imperi coloniali europei, quanto a una crisi e trasformazione della nozione stessa di imperialismo nel mondo del dopoguerra. Il tono misurato che i comunisti impiegavano nei riguardi degli Stati Uniti si legava alla costruzione di credenziali nazionali e al tentativo di lasciare persino aperta una porta all’apprezzamento dell’eredità di Roosevelt e del “capitalismo democratico”52. Il rifiuto dei «blocchi» come interesse italiano accomunava il linguaggio dei comunisti a quello dei democristiani, anche se con un diverso grado di internazionalizzazione delle rispettive visioni. Nel caso della Democrazia cristiana, l’idea di tenere l’Italia fuori da logiche dualistiche seguiva una ispirazione neutralista assai presente nella cultura politica cattolica, che combinava la vocazione universalista con un nazionalismo moderato, mentre il legame internazionale con gli Stati Uniti era ancora debole. I comunisti e i socialisti seguivano la strategia collaborativa dell’Unione Sovietica, nella speranza che le sfere d’influenza si mantenessero aperte53. Il comune denominatore consisteva nella consapevolezza della fragilità del tessuto unitario della nazione.
Togliatti rinnovò largamente il gruppo dirigente ai fini del progetto del «partito nuovo» ma anche alla luce dell’internazionalismo postcominternista. La sua scelta fu di promuovere accanto ai Longo e ai Secchia la generazione che per vie diverse era divenuta antifascista e comunista negli anni Trenta e nella Resistenza, non meno legata al mito sovietico e piú disponibile a connettere la “nazionalizzazione” con una visione internazionale aggiornata. Fu questa la logica che presiedette alla cooptazione in Direzione di figure come Amendola, Pajetta e Sereni, dotate di una propria personalità intellettuale. Tuttavia il consenso apparente nel gruppo dirigente del Pci si incrinò dinanzi alle crescenti tensioni tra l’Unione Sovietica e gli alleati occidentali dopo il discorso di Stalin del febbraio 1946, che parve sminuire il ruolo della coalizione parlando del carattere «imperialista» della Seconda guerra mondiale, e il discorso di Churchill a Fulton il mese dopo, sulla «cortina di ferro» calata nell’Europa centro-orientale. Nel mese di aprile, Togliatti subí un attacco pubblico dei comunisti francesi che non era episodico e segnava un cambiamento di clima. In una dura lettera a Thorez dell’aprile 1946, rivolta a difendere le posizioni del Pci sull’«italianità» di Trieste, affermò di vedere la questione del confine orientale e delle «sfere» esistenti in Europa in modo diverso dal «terribile schematismo» degli iugoslavi. A suo giudizio, le «sfere» esistevano in ogni paese, «cioè forze democratiche e reazionarie in lotta per avere la meglio». Egli riteneva che la partita in vari paesi europei fosse ancora in gioco e che la decisiva carta «nazionale» sarebbe stata compromessa da una concezione territoriale e ideologica delle «sfere d’influenza». Togliatti ricordava che gli iugoslavi avevano manifestato tale visione sin dalla fine del 1944, rompendo l’accordo con il Cln del Nord, che prevedeva di rimandare alla fine della guerra la questione di Trieste54. Sotto questo profilo, riemergeva una divergenza di sensibilità e inclinazioni trasversale nel movimento comunista europeo, rimasta sottotraccia nella fase finale della guerra ma ora destinata ad approfondirsi.
Il successo della Repubblica sulla monarchia nel referendum di giugno ebbe il significato di una svolta che poteva assegnare un primato alla sinistra nella divisione del paese in due blocchi politici, delineata dal risultato elettorale per l’Assemblea costituente. La nozione stessa di repubblica era parte essenziale del patrimonio politico della sinistra antifascista, che aveva tenuto vivo nella Resistenza il simbolismo dell’esperienza di Spagna, riempiendo il vuoto di potere creatosi dopo l’8 settembre55. La fondazione della Repubblica costituiva un esito che comunisti e socialisti avevano perseguito con nettezza rispetto alle forze moderate. Anche se l’argomento era molto controverso, i comunisti potevano rivendicare come proprio la «svolta di Salerno», criticata per il suo eccesso di cautela, fosse all’origine dell’indebolimento dell’opzione monarchica, e sostenere di essere la forza che piú accortamente aveva contribuito alla fondazione della Repubblica. Ciò nonostante, l’esito elettorale che classificava il Pci come terzo partito, sia pure con un margine minimo di differenza dai socialisti, generò una ripresa polemica verso la strategia togliattiana.
Secchia considerò insoddisfacente il risultato. Egli si espresse secondo la logica del “rivoluzionario di professione” deluso dallo scarso impatto del «vento del Nord» dopo la fine della guerra e denunciò il malcontento esistente nella classe operaia per l’assenza di una «lotta piú energica» contro «la parte piú reazionaria della Democrazia cristiana e del clero» e per la preoccupazione che si sviluppasse «in seno al nostro movimento una specie di nazional-comunismo». Il ruolo di responsabile dell’organizzazione, una postazione centrale nella costruzione del «partito nuovo», conferiva particolare autorità alle sue parole. Nella politica nazionale il suo potere era solo in parte equilibrato dalla presenza di Amendola, un convinto sostenitore della «svolta di Salerno»56. Secchia non si limitò alla questione elettorale e portò al tempo stesso un’argomentazione internazionalista. «Noi siamo isolati internazionalmente», lamentò, in quanto i partiti comunisti avevano «posizioni contrastanti su una serie di questioni “nazionali”» e conducevano «la polemica tra loro». A suo giudizio, «questo non è certo un elemento positivo ed a noi favorevole». Secchia impiegava un linguaggio molto simile a quello dei francesi e degli iugoslavi, che non era difficile interpretare come una bordata contro Togliatti57. La prima frattura nel gruppo dirigente del Pci nel dopoguerra presentò cosí subito implicazioni diverse circa il nesso internazionale. Le rispettive visioni di Togliatti e di Secchia si presentavano come due paradigmi opposti, dal momento che il primo paventava una separazione tra la questione della nazione e l’internazionalismo, mentre il secondo la invocava.
Secchia esprimeva una visione circolante tra le leadership di vari partiti comunisti, che non avevano mai veramente digerito il progetto della “nazionalizzazione” dopo lo scioglimento del Comintern. Nessuno ne proponeva apertamente la ricostituzione, ma alcuni come l’ungherese Rákosi avanzavano l’idea di riorganizzare il movimento sul piano internazionale. All’inizio di giugno 1946, Stalin e Tito discussero la costituzione di un nuovo organismo del movimento comunista internazionale, diverso dal Comintern. In quella circostanza, i due leader sembrarono liquidare le ruggini lasciate dalla crisi di Trieste dell’anno precedente e Stalin avrebbe addirittura investito Tito del ruolo di suo erede, esprimendo tra l’altro un giudizio sprezzante su Togliatti («è un teorico, un giornalista, può scrivere un buon articolo, è un bravo compagno, ma radunare le persone e “indirizzarle”, questo no»)58. Un simile giudizio personale poteva alludere anche a una valutazione negativa circa la priorità istituzionale e parlamentare della linea seguita dai comunisti italiani. Si sarebbe cosí ripresentata la divisione trasversale del comunismo europeo tra realisti e radicali già emersa prima della fine della guerra, con la differenza che Stalin sembrava spostare il peso della propria autorità verso i secondi dopo aver percepito il probabile collasso dei rapporti con gli anglo-americani. In ogni caso, difficilmente Togliatti poteva vedere con favore l’idea di un nuovo organismo internazionale comunista, dato che ciò implicava una visione bipolare antagonistica e volta a contrapporre lo spirito militante internazionalista al progetto di “nazionalizzazione” dei partiti.
Parallelamente, riemerse la preoccupazione per una destabilizzazione della situazione politica proprio a seguito dell’esito del referendum istituzionale. Reale riferí a Kostylev che Togliatti non escludeva lo scoppio di una guerra civile, a seguito dell’ambiguo atteggiamento del re dopo la vittoria della Repubblica59. Esprimere un simile timore rispondeva anche alla funzione di confermare una linea moderata e volta a evitare l’isolamento. Il discorso di Togliatti del 29 giugno al gruppo parlamentare eletto all’Assemblea costituente seguí questa priorità60. Togliatti prevedeva una «crisi profonda» legata anzitutto alla situazione internazionale. Si profilavano infatti «condizioni di pace dure» e si trattava di «pagare per il fascismo». Togliatti ribadiva l’esigenza di spiegare al popolo come l’Italia avesse evitato «la sorte della Germania», ma temeva «una campagna di tipo nazionalista e fascista». Il punto politico era perciò porre il problema dell’«indipendenza nazionale» evitando che questa divenisse la bandiera di forze reazionarie. L’abbandono della politica estera di due anni prima, a suo giudizio, privava il paese del sostegno sovietico e lo lasciava «senza nessun appoggio internazionale», esposto alle strategie della Gran Bretagna, che preferiva un’Italia debole al fine di «dominare incontrastata nel Mediterraneo». Come si vede, Togliatti riprendeva quasi alla lettera una delle coordinate principali del suo colloquio con Stalin prima della «svolta di Salerno». I tempi però erano cambiati anche per scelta di Stalin. Togliatti citava la questione irrisolta di Trieste, per la quale pensava a uno statuto autonomo «con condominio di sovranità italo-iugoslava». Evitava invece di dire che Mosca sosteneva Belgrado, come Molotov aveva chiarito a Reale dieci giorni prima a Parigi, frustrando la speranza dei comunisti italiani di ripetere il colpo di teatro del marzo 194461. La posizione di Togliatti era perciò piú complicata di come egli stesso la presentava. Ma era comunque volta a trovare formule di intesa politica che consentissero di portare avanti i governi di coalizione e il lavoro della Costituente, anche nelle difficoltà internazionali descritte.
Per molti aspetti, quella di Togliatti non era una scelta obbligata, ma un’opzione meditata alla luce della sua esperienza in Italia, in Germania e in Spagna negli anni tra le due guerre. Piú di una volta aveva constatato da vicino gli effetti disastrosi dell’uso della violenza politica e dell’immaginario della “guerra civile europea” sui progetti di emancipazione sociale. A fini di legittimazione, egli inserí la scelta dell’«unità nazionale» in una scia lunga iniziata all’epoca del Fronte popolare, sorvolando sul fatto che nel decennio precedente il tentativo di “nazionalizzare” i partiti comunisti europei era finito miseramente in Francia sotto lo shock del Patto tra Stalin e Hitler. Ma la sua azione politica rifletteva la profonda discontinuità creata dalla guerra. Togliatti si attenne all’idea che lo scivolamento in una catastrofe nazionale verificatosi in Italia nel settembre 1943 avesse generato un fondamentale riscatto morale e politico, ma che una seconda catastrofe di pari portata avrebbe annientato quello stesso patrimonio. La lezione della guerra civile greca scoppiata nel dicembre 1944 giocò un ruolo molto serio. La bestia nera di Togliatti divenne quella che egli stesso definí la «prospettiva greca», cioè il precipitare dei conflitti sociali in uno scontro armato tra le forze del «fronte antifascista» e l’esercito. Perciò vide la divisione bipolare in blocchi internazionali come un pericolo e non un’opportunità, imponendo questa visione ai dirigenti e ai quadri che avrebbero potuto seguire suggestioni ispirate al nesso tra guerra e rivoluzione. Egli era consapevole che l’interdipendenza tra politica nazionale e internazionale si sarebbe accentuata nel mondo del dopoguerra e che perciò la dinamica tra le grandi potenze costituiva un elemento decisivo nella politica italiana62.
Il nesso tra il rifiuto dei «blocchi» e l’interesse dell’Italia era difficilmente contestabile e non costituiva un monopolio dei comunisti. In piú, tale visione consentiva di immaginare modalità di ibridazione e transizione tra capitalismo e socialismo. Il discorso togliattiano sulla «democrazia progressiva» faceva eco alla nozione di «democrazia popolare» come forma di Stato distinta dal modello sovietico e dalla democrazia liberale, legittimata da Stalin nell’Europa centro-orientale in piú di una circostanza63. Tutti i comunisti erano profondamente convinti della “superiorità” del sistema sovietico su ogni forma di capitalismo, un elemento essenziale dello stalinismo che nella guerra aveva trovato piena conferma ai loro occhi. Togliatti e il suo gruppo dirigente non facevano eccezione. La loro formula della «democrazia progressiva» alludeva tuttavia alla possibilità di creare intersezioni e zone intermedie tra i due sistemi sociali dominanti, consentite dall’esperienza dell’antifascismo. L’ordine mondiale fondato sulla coalizione antihitleriana avrebbe potuto presiedere alla ricostruzione postbellica e permesso scelte economiche e sociali progressiste in Europa, anche tenendo conto dell’esistenza delle sfere d’influenza. L’Italia si trovava in una posizione geopolitica particolarmente idonea per beneficiare di una simile prospettiva, che consentiva di rimandare al futuro le scelte di una trasformazione socialista.
Tuttavia, lo sforzo di combinare i diversi aspetti del ruolo del Pci fu soggetto a tensioni incomponibili. La mancata conclusione della pace sulla questione tedesca pose il tema dei «blocchi» al centro della politica internazionale dopo la Conferenza di Parigi dell’estate 1946. Togliatti dichiarò che «accettare la definizione di blocchi in lotta vuol dire già in un certo senso mettersi sul terreno di un avversario, di un nemico». Il problema non era, a suo giudizio, quello dei «due blocchi», ma quello di «due concezioni di politica internazionale», perché «oggi, internazionalmente, non esistono due blocchi che stiano per farsi la guerra»64. Su questa base Togliatti impostava la prospettiva di una «politica internazionale autonoma» da parte dell’Italia, quale si doveva esprimere verso le principali questioni dell’assetto europeo. Ma ciò implicava l’aspettativa per una politica attiva e benevola dell’Unione Sovietica verso l’Italia, che invece non si doveva manifestare su nessuna delle questioni piú importanti della pace, compresa quella di Trieste. La stessa politica sovietica di manipolazione, controllo e repressione nell’Europa centro-orientale stava contribuendo a produrre l’esito della divisione in blocchi e rivelava l’influenza di concezioni mai abbandonate, fondate su una visione integralmente classista della politica internazionale65. In altre parole, Togliatti giocò le proprie carte riponendo fiducia in una stabilità internazionale che Stalin in realtà non riteneva praticabile fino in fondo. In questa luce, le visioni di Togliatti avverse all’antinomia tra i due «mondi» si potrebbero accostare a quelle di Litvinov. Ormai privo di incarichi e in dissenso con le scelte di Stalin, questi era convinto che l’Unione Sovietica, dopo aver vinto la guerra, stesse perdendo la pace, perché tornava a prevalere l’idea di un conflitto inevitabile tra il mondo comunista e il mondo capitalista66. Il leader italiano non aveva però mai avuto una vocazione al dissenso, semmai alla dissimulazione. Stalin prese le sfere d’influenza piú seriamente della democrazia antifascista. Togliatti dovette adeguarsi di conseguenza, mantenendo fermo il principio di lealtà senza rinunciare al progetto del «partito nuovo».
I tasselli decisivi della strategia ispirata dalla «svolta di Salerno» non andarono al loro posto. L’elemento nazionale e quello internazionale della strategia iniziale si separarono l’uno dall’altro con il consolidamento delle sfere d’influenza. Tuttavia, la visione e la pratica sino allora seguite da Togliatti avevano conseguito risultati imprevedibili. Il rifiuto della soluzione greca non era soltanto una questione di strategia piú o meno convincente per tutti i dirigenti e i militanti del partito, ma l’assunzione di una prospettiva legalitaria e parlamentare. Il voto per l’Assemblea costituente del giugno 1946 costituí un passaggio decisivo, perché assegnava ai comunisti un ruolo istituzionale, li rendeva difensori della cittadinanza democratica e li legittimava quale componente della nazione politica. Il «partito nuovo» era il motore di questa strategia. Alla fondazione della Repubblica, il Pci presentava già i caratteri di un’organizzazione di massa molto ben radicata, anzitutto nelle regioni di insediamento tradizionale del movimento operaio e socialista nel primo Novecento. Piú ancora che lo slogan di una «via italiana» al socialismo e la vaga idea della «democrazia progressiva», era questo carattere di massa, rivolto a penetrare i diversi strati della società senza vigilare troppo la propria purezza ideologica, a caratterizzare il progetto togliattiano67.
Il cuore di quel progetto stava nel tentativo di conciliare l’internazionalismo con la “nazionalizzazione” del partito. Ciò implicava la costruzione di un’idea di nazione che facesse proprie eredità politiche essenziali della storia italiana68. Nel dopoguerra, Togliatti sviluppò cosí un registro discorsivo inserito nella tradizione nazionale e, insieme, una grammatica storica alternativa, che si rivolgeva agli intellettuali e al popolo per enfatizzare il ruolo del movimento operaio nella rinascita della nazione democratica. Il momento costituente forní pieno significato alla narrazione di un «secondo Risorgimento» che avrebbe unificato le esperienze divise della Seconda guerra mondiale. La legittimazione dei comunisti non passava però soltanto dalla creazione di un tessuto comune, istituzionale e patriottico, ma anche dalla divisione ideale e simbolica. Il «secondo Risorgimento» era un’idea contesa e destinata a mostrare presto i limiti della memoria condivisa nello spazio repubblicano. A differenza dei cattolici, i comunisti assegnavano infatti il posto centrale alla mitologia della Resistenza come rinascita nazionale e democratica, diretta a cambiare il volto della società italiana69. L’immagine dell’Unione Sovietica integrava la narrazione resistenziale e dotava i comunisti di una peculiare miscela nazionale e internazionale. Il mito di Stalin rilanciato dalla Seconda guerra mondiale giocava un ruolo divisivo nell’immaginario collettivo, come speranza o come paura, ma aggregava l’identità comunista e ne alimentava gli elementi messianici70. Le pratiche repressive e autoritarie già messe in atto nell’Europa centro-orientale alla fine della guerra non si ripercossero troppo sui comunisti italiani, che non erano i soli a interpretarle come un’opera di sradicamento di vecchie classi dirigenti filofasciste. Le loro credenziali democratiche erano fragili, ma per molti contava di piú il fatto che essi avessero combattuto per la libertà contro la dittatura fascista. Nessuna delle forze politiche di massa del dopoguerra italiano presentava riferimenti internazionali ineccepibili sul piano della tradizione liberale e democratica. I socialisti condividevano largamente con i comunisti miti e riferimenti all’Unione Sovietica. Era però evidente anche il rapporto problematico fra la tradizione cattolica e gli Stati Uniti, per non parlare delle concezioni che nella Chiesa cattolica guardavano alla Spagna franchista come un modello di Stato. Alla fine della guerra, l’ironia di Togliatti circa il fatto che gli anglo-americani potessero guardare con diffidenza a un ministro degli Esteri cattolico come De Gasperi non era senza fondamento71. A differenza degli altri, i comunisti vantavano un legame di ferro con una delle grandi potenze vincitrici della guerra, portatrice di un modello sociale che si presentava come un’alternativa radicale ai fallimenti del capitalismo prebellico.
Il progetto togliattiano del partito di massa non era affatto il fondamento di un’anomalia italiana nel panorama del dopoguerra europeo, sebbene sia stato spesso presentato in questa luce. Rappresentava semmai la notevole variante nazionale di un movimento globale in espansione, dotato di nuove dimensioni sociali e statuali. I comunisti italiani conquistavano soltanto un quinto dell’elettorato, un risultato ragguardevole ma lontano, ad esempio, dal successo del Partito comunista cecoslovacco e inferiore ai numeri dei comunisti francesi. Però la massa critica di oltre due milioni di persone costituiva una risorsa senza precedenti. Il Partito comunista italiano poteva essere visto come una variante sui generis nella ricostruzione dei partiti comunisti nel dopoguerra, che offriva un panorama assai variegato seppure orientato dall’archetipo leninista dell’avanguardia rivoluzionaria, dalle pratiche del «centralismo democratico» e dal primato dell’organizzazione72.
Con tutte le sue particolarità nazionali, la ricostruzione dell’Italia nel secondo dopoguerra non doveva rappresentare un caso a sé stante e anzi fu inserita molto piú che in passato nelle dinamiche internazionali73. Il radicamento di una sinistra strettamente legata all’Unione Sovietica fu parte di quelle dinamiche, anche se assunse la peculiarità imprevedibile di una massiccia forza comunista. Il ristabilimento della comunità nazionale italiana nel secondo dopoguerra fu nello stesso tempo consolidato e spaccato dalla presenza comunista, che contribuí a evitare il conflitto nel campo antifascista e rappresentò un’ipoteca alternativa sul futuro del paese. Obliterare uno dei due aspetti, come tante volte si è fatto nella storiografia raffigurando nei comunisti un soggetto endogeno o alieno, significa precludersi la comprensione dei molteplici motivi di tenuta e frattura della nazione italiana nel «lungo dopoguerra» europeo. È invece essenziale comprendere la duplice frattura lungo l’asse comunismo-anticomunismo e fascismo-antifascismo, che ancora oggi viene rimossa o ricondotta a narrazioni unilaterali, esclusivamente incentrate sulla storia nazionale74. Vissuta dagli italiani sin dall’ultimo anno di guerra non soltanto sotto il profilo politico ma anche culturale ed esistenziale, tale duplice frattura dette forma alle percezioni e alle aspettative di una società segnata dall’esperienza della guerra civile anticipando le divisioni della guerra fredda, piuttosto che semplicemente rifletterle.
Nell’Europa risorgente dalle ceneri di una catastrofe trentennale, le idee progressiste ispirate a una modernizzazione sociale e politica della democrazia sembravano avere il vento nelle vele75. I comunisti beneficiavano del nuovo consenso pubblico antifascista e aperto al tema della programmazione economica statale, che permetteva loro di entrare in vari paesi in competizione con i socialisti, a differenza del primo dopoguerra. Mentre il loro riconoscimento come componente legittima della nazione politica europea era variamente contestato, ripristinavano le loro basi popolari in Francia, in Cecoslovacchia e persino in Germania, e ne acquisivano di nuove altrove, come in Iugoslavia e in Grecia, ma anche in Belgio o in Finlandia. La democrazia antifascista poteva essere vista come una nuova forma di modernità politica caratterizzata da varianti ed esperienze molteplici, che non ricalcavano necessariamente il dualismo tra capitalismo liberale e socialismo sovietico. Cosí il comunismo italiano presentava il volto di una realtà periferica, segnata dall’eredità del regime fascista e dalla guerra civile. Ma rivelava anche il carattere di un’esperienza volta a rovesciare il segno di quella prospettiva catastrofica, coltivando l’immagine di un partito nazionale e popolare, che nel mondo bipolare poteva liquidare il nesso originario tra guerra civile e rivoluzione senza rinunciare alla propria identità. Le divisioni della comunità nazionale non erano un fatto nuovo nella storia italiana. Il problema autentico era se nel secondo dopoguerra si sarebbe riprodotta o meno una spirale catastrofica come era accaduto nel primo dopoguerra.
3. Tra Piano Marshall e Cominform.
Il confronto bipolare prese a condizionare direttamente la politica europea occidentale sin dalla fine del 1946. Sulla scena italiana emersero ipotesi di rottura della coalizione di governo. Togliatti non escluse un cambiamento d’indirizzo in chiave nazionalista, che però accantonò subito76. Il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti nel gennaio 1947 mostrò come le forze anticomuniste si proponessero di opporre ai comunisti un proprio legame internazionale piú stabile e riconoscibile, che ancora non preludeva a una logica di schieramento ma era destinato a ripercuotersi sulla politica nazionale. La promessa di una presenza americana nel Mediterraneo compiuta dall’amministrazione Truman nel mese di febbraio alimentò il senso di un passaggio dall’antifascismo all’anticomunismo nelle priorità delle classi dirigenti europee. Nel maggio-giugno 1947, la coincidenza tra la fine dei governi di coalizione nazionale in Italia e in Francia e il lancio del piano di aiuti americano per la ricostruzione economica dell’Europa inaugurò una nuova stagione, che rendeva inutile l’obiettivo di prevenire la formazione dei blocchi. Gli interrogativi si fecero molto presto drammatici in Italia, dove erano già nati in precedenza. Subito dopo la crisi di governo e l’estromissione dei comunisti e dei socialisti, nella riunione della Direzione del Pci svoltasi all’inizio di giugno, Togliatti sostenne che il Pci doveva continuare a muoversi come un «partito di governo» e «impedire che il partito e le masse che ci seguono scivolino su posizioni che conducono alla lotta e alla insurrezione armata»77. Gli altri membri della Direzione approvarono questa linea. Togliatti non fece cenno all’aspetto internazionale, ma poco dopo, in un colloquio con l’emissario sovietico Dmitrij Ševljagin, espresse la persuasione che «la maggior parte delle questioni di politica interna del nostro paese siano questioni di carattere internazionale»78.
Il lancio del Piano Marshall acuí questo giudizio. Nella relazione tenuta il primo luglio al Comitato centrale, Togliatti presentò una lettura della situazione italiana come conseguenza dell’offensiva delle «forze dell’imperialismo». Egli osservava che gli Stati Uniti avevano conquistato una posizione di forza nettamente superiore a «tutte le altre potenze imperialistiche» e si ponevano il compito della «conquista di un dominio mondiale». Nello stesso tempo, Togliatti riteneva che l’«espansionismo» degli Stati Uniti fosse provocato dalla «minaccia di una crisi economica», che a suo giudizio avanzava inesorabile ed era all’origine del «nervosismo» americano. Egli percepiva il disegno egemonico americano ma non riconosceva al Piano Marshall la potenzialità di un volano della ricostruzione europea. La sua visione della supremazia americana si riconduceva a categorie del passato, che prendevano il sopravvento sui timidi e impliciti spunti di revisione emersi nei due anni precedenti. Il «pericolo di guerra» contro l’Unione Sovietica tornava al centro della scena ed evocava una ovvia analogia con il decennio prebellico. Togliatti riproponeva però in questo contesto la propria inclinazione anticatastrofista: si chiese se la prospettiva di una «terza guerra» fosse «una prospettiva reale, imminente» per rispondere negativamente, in quanto una simile tendenza era «frenata da una serie di fattori di cui il principale è l’esistenza di un movimento democratico in tutti i paesi europei». Il suo sguardo fu anche retrospettivo, con l’obiettivo di rivendicare le scelte strategiche fatte sin dalla fine della guerra. «Se noi avessimo accettato la sfida alla guerra civile in certi momenti e soprattutto quando la sfida poteva essere accettata – nel periodo cioè che va dal luglio all’ottobre del 1945», si chiese, «quale risultato avremmo ottenuto?» La sua risposta fu che il risultato sarebbe stato soltanto una divisione del paese. Una sua parte avrebbe avuto «uno sviluppo economico e politico piú avanzato» perché occupata «da truppe non anglo-americane», al prezzo però che il resto dell’Italia non sarebbe stato «un paese unito, libero e indipendente»79. In altre parole, Togliatti suggerí che l’unità nazionale era preferibile alla trasformazione del Nord in una «democrazia popolare».
Egli evitò di fare previsioni circa le conseguenze nazionali e internazionali della nuova situazione politica. La sua prudenza era anche dettata dalla coincidenza temporale della riunione del Pci con la Conferenza di Parigi sul Piano Marshall, che vedeva la partecipazione della delegazione sovietica guidata da Molotov. In quella sede, Molotov interrogò Reale sull’estromissione dal governo dei comunisti italiani e fece notare con dispetto che le loro dichiarazioni tacevano sull’ingerenza degli Stati Uniti nella vicenda80. Cosí il ministro degli Esteri sovietico suggeriva già una forte internazionalizzazione della politica italiana, malgrado che Washington non avesse giocato un ruolo diretto nella crisi di governo81. Il problema, come confidò Molotov a Đilas, non era la politica nazionale dei comunisti occidentali (che invece gli iugoslavi attaccavano), ma il fatto che essa non era coordinata con le «democrazie popolari» e con l’Unione Sovietica82. La decisione della delegazione sovietica di abbandonare i lavori della conferenza e di respingere il piano americano non rappresentò un fulmine a ciel sereno, ma prometteva un grave inasprimento della tensione. I comunisti italiani vedevano compromessa l’opportunità di recuperare un ruolo nel governo del paese, evitando di opporsi al piano di aiuti americano. Presto fu chiaro che la scelta sovietica chiudeva una simile possibilità e li spingeva verso posizioni incompatibili con il profilo di un partito di governo. Nelle sue conclusioni al Comitato centrale, il 4 luglio, Togliatti cambiò registro. Contraddicendo le sue stesse affermazioni di un mese prima, considerò la possibilità che la «democrazia progressiva» non fosse un percorso pacifico83.
Tuttavia, la sua condotta politica non mutò di molto. Egli presentò la propria scelta di consentire la ratifica del Trattato di pace italiano con l’astensione in sede parlamentare, malgrado il silenzio di Mosca, come un atto di responsabilità nazionale e un tentativo di arginare la spirale creata dalla politica internazionale. Il suo discorso del 29 luglio all’Assemblea costituente fu una requisitoria contro la tendenza occidentale a dividere l’Europa, considerata come «un primo passo verso nuovi conflitti e forse verso una nuova guerra». Proclamò tuttavia che la guerra non era «fatale» e rivendicò di aver difeso questa tesi nel 1935 «contro le posizioni estremiste che dicevano che la guerra non poteva in nessun modo essere evitata». Togliatti evitò riferimenti al leninismo e si collegò a una tradizione piú lontana, ricordando che «come socialisti, sappiamo la grande verità di quelle parole di uno dei nostri grandi, Giovanni Jaurès, quando disse che il capitalismo porta in sé la guerra come la nube porta in sé l’uragano». Il cambiamento nel mondo del dopoguerra si rivelava però decisivo, perché esistevano forze sufficienti «tali che, unendosi, possono impedire una guerra». Tra queste, il ruolo cruciale spettava evidentemente all’Unione Sovietica. Ciò che induceva a maggiore fiducia era dunque il rapporto di forze con il mondo capitalistico. Non rientravano nella sua visione le nuove dimensioni assunte dalla questione della guerra dopo la bomba atomica americana su Hiroshima e Nagasaki84.
Non era difficile pronosticare come la decisione di Stalin di respingere il Piano Marshall implicasse un giro di vite nell’Europa centro-orientale e la mobilitazione antiamericana dei partiti comunisti in Occidente. L’8 agosto 1947, in un colloquio con Dimitrov, Stalin criticò i comunisti francesi e italiani per la loro blanda condotta nella crisi di governo85. Ciò che Togliatti e gli altri leader comunisti non potevano sapere è che i sovietici stavano segretamente architettando la creazione di un nuovo organismo del comunismo internazionale, destinato ad aggravare uno scenario già cupo e pericoloso. Attorno alla metà di agosto, Secchia venne informato dai capi polacchi Władysław Gomułka e Bolesław Bierut che si prevedeva l’iniziativa di una conferenza genericamente rivolta a creare un coordinamento dei partiti86. L’agenda della conferenza, convocata in Polonia per l’ultima decade di settembre, non era nota neppure al momento dell’invio delle delegazioni. Togliatti intuí il clima politico e istruí di conseguenza i delegati italiani, Longo e Reale, raccomandando loro di difendere la visione e la strategia seguite sino allora. Le parole di Togliatti sono riportate da Reale nelle sue memorie, scritte dopo il distacco dal Pci («se vi rimprovereranno che non abbiamo saputo prendere il potere o che ci siamo fatti cacciar via dal governo – ci disse congedandoci – ebbene, dite loro che non potevamo trasformare l’Italia in una seconda Grecia. E ciò nell’interesse non soltanto nostro ma degli stessi sovietici»)87.
Lo svolgimento della conferenza confermò la previsione di Togliatti. I rappresentanti dei partiti dell’Europa centro-orientale, gli italiani e i francesi svolsero le proprie comunicazioni rituali, ma subito dopo la delegazione sovietica mise in scena un colpo di teatro. Il capo della delegazione, Andrej Ždanov, tenne senza preavviso un’impegnativa relazione sulla situazione internazionale che era stata accuratamente preparata con Stalin. Non poteva sfuggire ai presenti che per la prima volta dalla fine degli anni Venti uno dei massimi leader sovietici teneva un discorso di simile rilievo in un consesso di partiti comunisti, sia pure a porte chiuse. Era facile interpretare l’evento come un rilancio internazionalista che in una buona misura invertiva la scelta di sciogliere il Comintern presa quattro anni prima. La tesi enunciata da Ždanov circa la scissione del mondo in «due campi», divisi tra imperialismo e antimperialismo e rispettivamente guidati da Washington e Mosca, rispondeva al Piano Marshall lanciando una sfida mirante a compattare il blocco orientale e a destabilizzare il processo di formazione del blocco occidentale. La formula della divisione del mondo tra capitalismo e socialismo non era nuova e risaliva anzi agli anni Venti. Il suo impiego presupponeva però adesso una lettura della Seconda guerra mondiale come genesi di un ordine bipolare antagonistico. Il suo corollario piú evidente era il ritiro del sostegno alla linea realista e parlamentare seguita dai comunisti occidentali, la restaurazione di forme di controllo sulle loro mosse e il richiamo a svolgere azioni extraparlamentari rivolte contro la presenza americana. Il bersaglio di Ždanov era il «parlamentarismo» e la strategia legalitaria. Egli si guardava bene dal ricordare che quella strategia era stata decisa a Mosca e risaliva, nella sua prima formulazione, all’incontro tra Stalin e Togliatti del marzo 194488.
I delegati sovietici riferirono puntualmente a Stalin sull’andamento dei lavori manifestando, tra l’altro, l’impressione che il Pci «grazie agli errori e all’irresolutezza della Direzione, non sa che cosa fare e attende lo sviluppo degli eventi»89. La requisitoria di Ždanov all’indirizzo dei comunisti occidentali trovò ampia eco nel fuoco di fila degli interventi dei dirigenti dell’Europa orientale e soprattutto dagli iugoslavi, secondo un copione preparato dietro le quinte. Kardelj accusò Togliatti di covare l’illusione che nei paesi capitalistici fosse praticabile una via legale al potere e una transizione pacifica dal capitalismo al socialismo. Egli sostenne che alla fine della guerra si era perduta un’occasione rivoluzionaria nell’Italia del Nord, un pensiero certamente condiviso da molti dirigenti e quadri del Pci. La logica piú conseguente di questa tesi portava a rovesciare il suggerimento dato da Togliatti a Longo e Reale. Si doveva guardare la guerra civile in Grecia, secondo il leader iugoslavo, come un esempio da seguire anche in Italia e in Francia. Longo accolse le critiche di Ždanov, manifestando la propria disciplina internazionalista, ma glissò sulle tesi ultraradicali di Kardelj90. La distinzione tra mobilitazione di massa e modello greco si fece cruciale, sebbene piú facile da compiere a parole che nella pratica. La fondazione del Cominform sembrava cosí segnare un netto rialzo delle quotazioni degli orientamenti militanti su quelli moderati nel movimento comunista. Tuttavia, Ždanov non rivolse al Pci la critica della «mancata occasione rivoluzionaria», che avrebbe chiamato in causa gli orientamenti decisi da Stalin alla fine della guerra. Il Partito comunista greco non era stato invitato alla Conferenza costitutiva del Cominform, perché Stalin, fedele alle sfere d’influenza, non riteneva che una internazionalizzazione della guerra civile rientrasse negli interessi sovietici. Nel suo discorso conclusivo alla conferenza, Ždanov non si espresse in merito alla prospettiva insurrezionale. Ciò non sfuggí all’osservazione acuta di Reale91. Non erano perciò chiare le finalità ultime, ed eventualmente i limiti, del cambiamento imposto alla strategia dei comunisti in Occidente.
Il Cominform costrinse i comunisti italiani sul fronte della nascente guerra fredda in Europa. La loro appartenenza al «campo socialista» li esponeva a un conflitto dalle potenziali conseguenze catastrofiche e li spingeva verso l’isolamento politico, malgrado la loro consistente forza sociale. Le critiche mosse al loro indirizzo confermarono una riserva di fondo mai rimossa, sin dall’epoca del Fronte popolare, sul significato delle istituzioni democratiche come terreno dell’azione politica, oltre che l’aspettativa di nuove crisi e rivolgimenti nelle società capitalistiche. Ma la nuova svolta «classe contro classe» stimolava anche spiriti animali e motivi identitari che la “nazionalizzazione” aveva relegato in secondo piano. L’appello a privilegiare il terreno della mobilitazione extraparlamentare e di massa toccava corde profonde nella psicologia e nella cultura di tutti i comunisti. Riemergeva cosí la frattura tra realisti e intransigenti nata durante la guerra, con la differenza che i secondi potevano ora aspirare a conquistare la guida dei partiti con la benedizione di Mosca e sotto la pressione della polarizzazione politica in Europa.
Il 7 ottobre 1947, Longo riferí alla Direzione le critiche subíte alla Conferenza fondativa del Cominform, riconoscendo la necessità di modificare la linea politica «soprattutto in considerazione del fatto che esistono oggi, nel mondo, due blocchi, e che non si tratta soltanto di evitare la loro costituzione». Si doveva anche evitare l’errore di credere «che solo sul piano legalitario si possano realizzare certi risultati politici»92. Longo ripeté la strategia difensiva già adottata durante i lavori della conferenza, che prevedeva un pieno allineamento a Mosca sulla tesi dei «due campi», senza cedere alle critiche piú estreme degli iugoslavi. Secchia non operò invece una simile distinzione. Egli richiese «un profondo mutamento» della linea politica, tramite la mobilitazione di massa e la ricerca di nuove alleanze sociali. Tratto distintivo del suo intervento alla Direzione fu il riconoscimento di una «debolezza» della politica del Pci «non tanto adesso, io credo, quanto nel 1945, fino al due giugno e anche dopo, quando avevamo una notevole posizione di forza che forse non abbiamo sfruttato». Simili posizioni non si identificavano con una critica frontale del «parlamentarismo», ma non costituivano neppure una difesa delle scelte di fondo di Togliatti, che fu invece fatta da Reale. Terracini si collocò fuori dal coro ed espresse riserve sul significato stesso del Cominform, osservando che una brusca radicalizzazione esponeva il partito alla perdita di contatto con i ceti medi93. Il suo intervento fu oggetto di numerose critiche, che ribadivano la disciplina internazionale. Togliatti fissò il perimetro dell’adeguamento inevitabile. Proclamò l’esigenza di schierarsi «dalla parte della politica di pace dell’Unione Sovietica» e di riconoscere che «lo scioglimento dell’Internazionale comunista non ha posto fine alla funzione dirigente del Partito comunista bolscevico». Ma fu apertamente dubbioso sullo scenario insurrezionale. Sostenne infatti che un comunista non poteva escluderlo «in eterno», ma quanto ad avanzare «una prospettiva immediata» di quel genere riteneva non fosse giusto «porre cosí la questione»94. Le misure da prendere sul piano organizzativo e cospirativo furono probabilmente dibattute ma non riportate nei verbali. Poco dopo, Reale disse a Kostylev che nel Nord i partigiani si stavano riorganizzando e creando «formazioni paramilitari», ma sostenne di non conoscere i dettagli di quelle che egli definiva «misure necessarie»95.
Il rapporto di Ždanov fu reso pubblico il 22 ottobre 1947, depurato nei suoi passi esplicitamente critici verso i comunisti italiani e francesi. La tesi della divisione del mondo in «due campi» fu percepita in Occidente come una dichiarazione di guerra fredda. Sebbene formulata da un organismo interamente eurocentrico e selezionato, la sfida cominformista presentava evidenti implicazioni globali, chiamando a raccolta attorno a Mosca le forze «democratiche e antimperialiste». L’Italia si trovò al centro di una simile sfida. Malgrado la censura sulle critiche al «parlamentarismo», la percezione di una spinta conflittuale e pericolosa fu immediata nell’opinione pubblica. In piú, nacque un vero e proprio «caso» attorno a Terracini. Riammesso nel partito nel 1944 dopo l’espulsione a seguito del dissenso sul Patto tra Stalin e Hitler, Terracini manteneva una libertà di giudizio che rifletteva la sua distanza personale e biografica dal culto dello Stato sovietico96. Il suo incarico di presidente dell’Assemblea costituente gli conferiva particolare autorevolezza. Egli rivendicò in una intervista una posizione di non allineamento ai blocchi, sostenendo che in caso di guerra il popolo italiano avrebbe dovuto schierarsi contro l’aggressione, qualunque fosse la sua provenienza. La segreteria del partito lo costrinse a una parziale rettifica97. In realtà, Terracini seguiva un filo logico coerente con le visioni adottate fino a pochi mesi prima da Togliatti, sostenendo che sebbene la formazione dei due blocchi fosse «obiettivamente contenuta “in nuce” nella stessa conclusione della guerra», la correzione delle tendenze spontanee era appunto «la ragion d’essere della politica». Togliatti vide bene il nucleo forte dell’argomentazione e accusò Terracini dinanzi al Comitato centrale, l’11 novembre, di aver presentato la politica dell’Unione Sovietica come «un complesso di azioni provocate dalla politica dei paesi occidentali» implicitamente negando che Mosca avesse «una sua propria politica di pace»98.
Il “caso Terracini” fu una cartina di tornasole delle conseguenze della nascente guerra fredda. Mettere all’indice la sua critica della condotta sovietica e aderire senza riserve alla lotta contro il Piano Marshall significava indebolire la credibilità dei comunisti sotto il profilo dell’interesse nazionale. La sua emarginazione espungeva simbolicamente dalla scena un elemento essenziale della stessa immagine nazionale dei comunisti. Egli però non fu colpito da alcun provvedimento disciplinare e poté apporre la propria firma sulla Costituzione pochi mesi dopo. In sostanza, la nascita del Cominform metteva a nudo la contraddizione profonda dei comunisti tra la fedeltà incondizionata all’Unione Sovietica e la costruzione di un’identità nazionale e democratica. Il Pci di Togliatti manteneva un risicato ma decisivo margine di manovra, escludendo un rovesciamento delle coordinate nate con il progetto del «partito nuovo». Gli scenari aperti dalla guerra fredda in Italia erano tuttavia drammatici e imprevedibili.
4. Lo scenario della guerra civile.
La nascita del Cominform rimise in gioco le visioni antagoniste che avevano animato le forze e gli uomini piú inclini a soluzioni rivoluzionarie negli ultimi anni della guerra. Si prospettava apertamente la tendenza a sostenere le sfide di un conflitto inevitabile tra capitalismo e socialismo. La prudenza seguita alla fine della guerra poteva essere stata giusta o sbagliata, ma ora diveniva superflua. La cultura politica dei comunisti, compresa la nuova generazione della guerra, era predisposta ad accogliere una simile visione manichea dell’ordine mondiale. L’influenza giocata dalle componenti militanti nei singoli partiti, specie in quelli occidentali, era potenzialmente piú significativa di quanto non risultasse dalle posizioni espresse negli organismi dirigenti. Cosí va compreso il ruolo assunto da Secchia. Egli era in sintonia con l’ispirazione cominformista di un rinnovato internazionalismo, basato sulla preponderanza di potere dell’Unione Sovietica. Il suo ruolo si faceva tanto piú rilevante quanto piú si poteva ritenere che la traiettoria moderata di Togliatti fosse giunta al capolinea. All’inizio di dicembre, Secchia dichiarò a Kostylev di non escludere che gli Stati Uniti avrebbero potuto arrestare l’evacuazione delle loro forze dall’Italia «se solo ritenessero che stia inevitabilmente per scoppiare a breve termine una nuova guerra mondiale». Ma riguardo a ciò, osservò che «gli americani non sono soli al mondo, e se essi decidessero di mantenere le loro forze in Italia, anche altre forze potrebbero essere mantenute in altri paesi»99. Le sue parole si collocavano in un contesto nazionale già fortemente scosso dagli scioperi contro il Piano Marshall e dalle tensioni politiche crescenti. Negli stessi giorni, il gruppo dirigente della Dc si riuní per esaminare concretamente, cosí come stavano facendo i comunisti, l’ipotesi di far fronte a una guerra civile, mobilitando tutte le risorse disponibili dell’apparato statale100.
Secchia si recò in missione a Mosca a metà dicembre 1947. A differenza di Thorez, Togliatti evitò di fare un simile passo. La scelta di inviare Secchia costituiva un riconoscimento della sua influenza nel partito, ma lo esponeva anche al rischio di un insuccesso. Togliatti era forse a conoscenza del fatto che nel suo incontro con Thorez, avvenuto un mese prima, Stalin si era espresso sulla situazione francese in modo molto piú cauto di quanto non lasciassero prevedere le aspre critiche cominformiste e non c’era motivo di ritenere che la sua visione dell’Italia fosse molto diversa. La mossa di Togliatti fu forse azzardata ma vincente. Sin dal suo incontro con Ždanov, Secchia sollevò la questione centrale, chiedendo l’opinione dei sovietici sulla prospettiva insurrezionale e sull’eventualità dello scoppio di una guerra civile in Italia. Egli riferí che Togliatti si rifiutava di porre l’alternativa secca tra «insurrezione» e «pacifico sviluppo parlamentare». L’argomento di Togliatti era che soltanto una diretta minaccia di guerra avrebbe reso inevitabile una guerra civile in Italia, ma la situazione internazionale non era ancora giunta a questo punto e perciò l’idea che non fosse possibile proseguire sulla «via democratica» sarebbe stata sbagliata. Tuttavia, Secchia non si limitò a riferire la posizione di Togliatti e presentò una visione alternativa. Egli sostenne che fosse ormai all’orizzonte in Italia uno scontro violento e che, se si voleva evitare di ripetere gli errori del passato, era necessario passare alla controffensiva. Stava ai sovietici decidere se la situazione internazionale consigliasse di evitare una guerra civile oppure se «una lotta decisa, in Italia, sia utile e necessaria». Sarebbe allora stato necessario impedire «che sia il nemico stesso a decidere se mantenere la lotta su di una base democratica oppure se trasportarla sul terreno della lotta armata nel momento a lui conveniente». «Noi stessi», aggiunse, «dobbiamo scegliere il momento a noi conveniente». Ždanov non si pronunciò e rimandò il dirigente italiano al confronto con Stalin101.
Stalin sconfessò l’alternativa proposta da Secchia anche se non la escluse completamente. «Riteniamo che non bisogna puntare sull’insurrezione», disse, anche se occorreva «essere pronti se l’avversario attacca»102. Di fatto, Stalin dette ragione a Togliatti. L’impatto della fondazione del Cominform si rivelava perciò meno sconvolgente di quanto non fosse apparso probabile in un primo momento. Togliatti meglio di tutti aveva capito l’orientamento di Stalin103. Questi scelse anzi di evitare ogni tipo di esposizione in Italia, persino di tipo pacifico. Secchia presentò a nome di Togliatti la proposta di preparare un incontro ufficiale, da svolgersi alla vigilia delle elezioni, nel quale da parte sovietica si sarebbero promessi aiuti economici all’Italia in caso di vittoria delle sinistre. La richiesta era rivolta a controbilanciare l’impatto del Piano Marshall nell’opinione pubblica. Ždanov riferí la risposta di Stalin dichiarando che con un simile passo i sovietici si sarebbero «assimilati» agli americani e avrebbero dato luogo «a una violazione dell’indipendenza nazionale e della sovranità del paese»104. Mosca si asteneva cosí da qualunque forma di intervento in Italia, evidentemente per evitare ripercussioni nella sfera d’influenza sovietica.
Secchia pronunciò comunque a Mosca, il 16 dicembre, un discorso che riproponeva nella sostanza la propria opzione. Egli presentò l’Italia come il luogo geopolitico centrale dell’«attacco» preparato dagli americani contro l’Unione Sovietica e i paesi di «nuova democrazia». Criticò le «illusioni parlamentaristiche» in una chiave retrospettiva, sostenendo che il partito aveva rinunciato «con molta leggerezza» allo strumento dei Comitati di liberazione nazionale, «quando sarebbe stato necessario estenderli su tutto il territorio italiano». Ricordò anche che la lotta per «l’estensione della democrazia» si svolgeva in un paese «dove le posizioni della reazione sono ancora forti», e che, di conseguenza, il partito doveva «essere pronto a passare alla lotta armata in caso di necessità»105. L’opzione del Pci in favore di una «democrazia progressiva», fondata sulla pace civile, restava cosí condizionata a una futura diversa valutazione delle condizioni oggettive, secondo quanto lo stesso Stalin aveva suggerito.
Sotto questo profilo, si poteva contestare persino la costruzione del partito di massa. Secchia chiese esplicitamente il parere di Stalin circa l’opportunità di mantenere il carattere di massa del partito o di creare un partito di quadri. Stalin rispose che «là dove ci sono altri partiti, i comunisti non possono contenere l’adesione al partito, perché la gente andrebbe in questi altri partiti. […] Perciò i comunisti italiani non possono limitare l’adesione al partito, ma devono rafforzare il lavoro politico tra gli iscritti»106. La critica del partito di massa era stata un cavallo di battaglia degli iugoslavi alla Conferenza del Cominform. Stalin e Thorez avevano affrontato l’argomento un mese prima. Richiesto di un parere, il leader francese aveva espresso perplessità circa la dimensione di massa del Pci, che a suo giudizio induceva talvolta i comunisti italiani «a rinunciare alle proprie opinioni su problemi di principio». Stalin parve liquidare la questione con un riferimento alle particolarità dell’Italia, non privo di perspicacia circa la continuità tra la politicizzazione di massa realizzata dal fascismo e quella del dopoguerra. Osservò infatti con malizia che «Mussolini ha insegnato loro qualcosa. Se in Francia ci fosse stato Mussolini, anche là avrebbe insegnato qualcosa ai comunisti»107. Ma questo giudizio non rimuoveva un fondo di seria perplessità.
In sintesi, la missione di Secchia a Mosca non indebolí la leadership di Togliatti, ma lo accreditò come un dirigente internazionale di primo piano. Su indicazione di Stalin, egli portò il cospicuo contributo finanziario sovietico alla campagna elettorale del Pci facendo tappa in Iugoslavia, dove incontrò Kardelj e Đilas. Poco dopo venne nominato vicesegretario del Pci108. Il VI Congresso del Pci, nel gennaio 1948, registrò l’escalation delle tensioni della guerra fredda in Italia e in Europa. La campagna elettorale italiana si annunciava come uno scontro senza quartiere alimentato da entrambe la parti con toni infuocati. Togliatti si limitò a presentare una visione internazionale basata sulla tesi dei «due campi». Il rappresentante sovietico, Pavel Judin, riferí a Mosca una propria conversazione privata con Togliatti, ricavandone l’impressione che i comunisti italiani si preparassero seriamente all’eventualità di un conflitto armato analogo a quello scoppiato in Grecia109. Tuttavia, Togliatti replicò all’insistenza dei delegati iugoslavi per imboccare la strada di «un’aperta lotta rivoluzionaria», affermando che «quando si tratta della rivoluzione in Italia, lasciate fare a noi»110.
Nel febbraio 1948, il colpo di Stato comunista a Praga completò l’instaurazione delle dittature monopartitiche in tutta l’Europa centro-orientale e acuí le reciproche percezioni del pericolo. Gli Stati Uniti vi videro una modalità operativa che si poteva ripetere in Italia, ormai divenuto il paese chiave per la presenza americana in Europa. Ciò portò George Kennan a suggerire l’opportunità di mettere fuori legge il Pci e cancellare le elezioni, anche a costo di intervenire militarmente, impiegare la violenza di massa e dividere in due il paese, poiché a suo dire il Nord sarebbe caduto verosimilmente nelle mani dei comunisti aiutati dalla Iugoslavia. L’eventualità di un simile esito fu considerata anche dall’ambasciatore James Dunn e nel National Security Council111. Le ipotesi interventiste che emersero all’interno dell’amministrazione Truman si basavano sulla percezione del fatto che Mosca non avrebbe rischiato una guerra per aiutare la sinistra italiana. In effetti, la prudenza di Stalin appare evidente. In una lettera inviata ai primi di marzo a Kostylev, Vyšinskij accusò l’ambasciatore di superficialità per aver sostenuto che i compiti del Fronte popolare fossero simili a quelli del Cln alla fine della Seconda guerra mondiale, questa volta con il fine di evitare «a ogni costo» l’ingresso dell’Italia nel «blocco occidentale». A suo giudizio, era un’ingenuità pensare che il destino dell’Italia non potesse essere separato dall’Europa centro-orientale112.
Le opinioni dei comunisti italiani riflettevano in modo speculare gli scenari dello sbocco cruento, rivelando incertezze strategiche e visioni diverse. Si poteva stabilire una certa analogia tra la Cecoslovacchia e l’Italia sotto il profilo della forza del movimento operaio e del mito sovietico. Per alcune componenti del partito, Praga rappresentava una tentazione e un’opzione da considerare113. La differenza cruciale era che in Italia le forze anticomuniste detenevano il monopolio degli apparati militari e di sicurezza. In un colloquio con Kostylev, svoltosi alla metà di marzo, Secchia giudicò possibile un attacco armato contro il Fronte popolare vittorioso, verosimilmente destinato ad aver luogo il giorno stesso delle elezioni o quello seguente. Egli si spinse persino a delineare diversi scenari. Osservò che «se non ci sarà un intervento americano, i lavoratori armati riusciranno a prendere nelle proprie mani quasi tutto il territorio dell’Italia settentrionale e centrale», mentre la restante parte del territorio nazionale sarebbe certamente rimasta in mano alle «forze reazionarie». A suo giudizio, non si poteva affatto escludere un intervento americano e perciò uno «scontro internazionale»114. Meno ottimista circa le previsioni sui risultati elettorali, Reale usò toni diversi e confidò all’ambasciatore sovietico che il gruppo dirigente italiano si chiedeva se un intervento armato degli americani potesse «risolversi in una guerra mondiale o se la guerra in Italia avrà un carattere locale, come in Grecia». Ma aggiunse, «l’Italia non è la Grecia, e le forze progressiste in Italia non sono poche»115.
Il momento decisivo fu un incontro segreto di Togliatti con Kostylev, il 23 marzo 1948. Secondo il resoconto dell’ambasciatore, Togliatti dichiarò di non poter escludere gravi provocazioni prima e dopo le elezioni contro il Fronte popolare, che a suo parere avrebbe prevedibilmente prevalso, e di ritenere che il Partito comunista dovesse prepararsi a ogni eventualità, compresa quella dell’insurrezione armata nell’Italia settentrionale. Lo stesso Togliatti avrebbe anzi richiesto, non diversamente da quanto aveva fatto tre mesi prima tramite Secchia, il parere dei dirigenti sovietici sulla prospettiva dell’insurrezione armata. La differenza era che Togliatti sembrava ora prendere molto piú seriamente in considerazione la possibilità del precipitare della situazione in Italia. Tuttavia, egli affermò che, anche in caso di risposta positiva da Mosca, il partito italiano sarebbe passato all’azione solo se si fossero verificate circostanze estreme. Invitò soprattutto a tenere conto del fatto che un simile passo avrebbe potuto portare a una nuova guerra mondiale, nella quale si sarebbero trovati su fronti opposti i paesi di «nuova democrazia», a fianco del Fronte popolare, e i paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, a fianco della Democrazia cristiana. La risposta di Molotov non si fece attendere. Il 26 marzo il ministro degli Esteri sovietico telegrafò a Kostylev, perché questi ne informasse Togliatti, che il Cremlino consigliava di passare alla lotta armata soltanto nel caso di un attacco militare delle forze reazionarie, ma riteneva in quel momento del tutto inopportuna un’insurrezione. Molotov si premurava di avvertire i comunisti italiani di non dare ascolto ai consigli degli iugoslavi, precisando che questi non erano informati sulle posizioni sovietiche, anche se sostenevano di esserlo116.
Cosí Togliatti si adoperò per scongiurare una catastrofe italiana e la sua posizione fu approvata da Stalin. Il resoconto del suo incontro con Kostylev rivela un clima di forte apprensione e incertezza, ma anche una precisa determinazione del segretario del Pci. Egli si proponeva di evitare un esito violento sino al verificarsi di condizioni estreme e cercava di esercitare un’influenza moderatrice sull’opinione dei partner sovietici, nel segno del loro stesso interesse. L’argomento che una guerra civile in Italia potesse accendere la miccia di una terza guerra mondiale era chiaramente inteso ad alimentare la cautela di Stalin. A differenza di quanto ritenevano gli intransigenti del Pci e gli iugoslavi, tale argomento costituiva un potente fattore di dissuasione a Mosca. Togliatti aveva sempre evitato affermazioni di principio sul nesso tra «democrazia progressiva» e pace civile. Si era espresso esclusivamente in termini di realismo politico, insistendo sulle possibilità non esaurite della democrazia e della legalità nella società nazionale. Alla prova dei fatti, egli ribadí però con fermezza questa scelta. La sua bussola principale fu la necessità di evitare che il conflitto politico in Italia degenerasse in una seconda guerra civile, dopo quella del 1943-45.
Perciò il ruolo della personalità di Togliatti nella congiuntura italiana e internazionale del 1948 non dovrebbe essere sottovalutato. Il sopravvento di una spirale incontrollabile era una possibilità autentica. La disponibilità all’uso della violenza serpeggiava tra componenti della sinistra ed ex partigiani frustrati dalla mancata insurrezione alla fine della guerra, ma era anche contemplata, sul piano internazionale, dagli americani e dai britannici. La Chiesa cattolica dipingeva il conflitto politico in Italia come uno scontro di civiltà e il comunismo come una forma estrema di ateismo moderno. Togliatti e De Gasperi furono gli attori piú moderati e realisti in un panorama incendiario117. Al momento di prendere decisioni politiche cruciali, Togliatti mostrò di aver fatto i conti con la dottrina dell’inevitabilità della guerra, molto piú di quanto non fosse accaduto negli anni Trenta. Sin dalla fine della guerra, era implicita nelle sue scelte la memoria del decennio prebellico assai piú nella chiave di un disastro da non ripetere che nella chiave dell’eredità internazionalista della guerra di Spagna.
Il trionfo elettorale della Dc e la sconfitta rovinosa del Fronte popolare, il 18 aprile 1948, presentò evidenti riflessi internazionali, nel senso di una stabilizzazione dei blocchi. Dal punto di vista di Washington, fugate previsioni piú gravi, l’Italia poteva divenire un modello vincente di warfare politico motivato dall’ideologia anticomunista, volto a impiegare ogni mezzo possibile, tra operazioni «coperte» e campagne di propaganda, salvo l’impiego della guerra118. La sconfitta elettorale non produsse reazioni significative a Mosca, dove non sarebbe stato difficile utilizzarla quale prova degli effetti perniciosi prodotti dalle «illusioni parlamentariste». Stalin prese atto delle elezioni italiane e le considerò probabilmente, come fecero gli americani, un punto di svolta nella formazione dei blocchi in Europa. Il 26 aprile, Togliatti fece notare all’ambasciatore sovietico che Washington non doveva essere soddisfatta degli esiti del voto, perché ora l’ipotesi di sostituire il governo democristiano con «un altro governo reazionario» diveniva molto piú difficile da realizzare119. In realtà, egli non coglieva nel segno. Gli americani recepirono con entusiasmo la vittoria schiacciante della Dc e la considerarono come il prologo di una stagione riformatrice e modernizzatrice dell’Italia, tramite l’implementazione del Piano Marshall120. Tuttavia, le parole di Togliatti avevano il significato di considerare De Gasperi e la Dc come un argine verso il precipitare di una soluzione reazionaria, con il beneplacito degli Stati Uniti. Con questa considerazione, egli stabiliva lo scenario di una «guerra di posizione» che si imponeva sulle illusioni di una «guerra di movimento» nell’Italia del dopoguerra.
All’indomani dell’aprile 1948, il Pci era ormai fuori dal mirino del Cominform. Lo scenario di un’azione del comunismo internazionale rivolta a impedire la formazione del blocco occidentale si era dissolto. Si addensavano invece nubi sui partiti dell’Europa orientale. Togliatti e Secchia formarono una delegazione al massimo livello alla II Conferenza del Cominform, a differenza che nella prima. Con qualche anticipo i dirigenti italiani furono informati che la conferenza era chiamata a pronunciare la clamorosa scomunica voluta da Stalin contro gli iugoslavi, con evidenti conseguenze per il disciplinamento e la sovranità degli altri Stati comunisti dell’Est europeo. Nei suoi colloqui riservati con i delegati sovietici a Bucarest, il 20 giugno 1948, Togliatti non esitò ad accusare gli iugoslavi di aver svolto un gioco pericoloso, riferendosi alla questione di Trieste121. Nei lavori ufficiali, i rituali della liturgia comunista furono rispettati e le condanne senza appello pronunciate anche da coloro che dovettero avvertire la rottura tra Mosca e Belgrado come un sogno rivoluzionario infranto. Tra questi figurava molto probabilmente Secchia. Togliatti non si limitò però alla liturgia. Egli colse l’occasione per difendere la costruzione del partito di massa e dichiarò che era stato «politicamente giusto dopo la seconda guerra mondiale impiegare lo sviluppo del movimento democratico e operaio per la creazione di partiti di massa»122. Come sappiamo, non erano soltanto gli iugoslavi a storcere il naso per la scelta del reclutamento di massa e il conseguente annacquamento della vigilanza ideologica. La condanna di Tito non significava un mutamento di rotta sulla questione e anzi annunciava un giro di vite nell’Est europeo. Togliatti si spinse persino oltre, spiegando che la polarizzazione interna e internazionale della guerra fredda non imponeva di invertire l’opzione per il «partito nuovo» e neppure un passo indietro nello sviluppo delle «democrazie popolari». È evidente che le conseguenze di una simile presa di posizione non erano confinate a una specificità nazionale. Togliatti riteneva fosse possibile rivendicare il caso italiano come l’esempio di una scelta ancora giusta per il movimento comunista, rovesciando cosí la visione negativa adottata dal Cominform meno di un anno prima.
L’attentato a Togliatti del 14 luglio 1948 riportò drammaticamente di attualità lo scenario della guerra civile in Italia e di una sua internazionalizzazione. La proclamazione dello sciopero generale e la mobilitazione popolare spontanea rischiarono di sfuggire al controllo dei dirigenti politici e di rilanciare prospettive insurrezionali dopo la frustrazione della sconfitta elettorale. L’esperienza compiuta nei mesi precedenti, quando la visione di Togliatti si era imposta sulle suggestioni militanti e aveva ricevuto l’appoggio di Stalin, si rivelò decisiva. Sulla scorta dell’appello lanciato dallo stesso Togliatti, prevalse tra i massimi dirigenti del Pci una condotta volta a preservare la legalità. La condotta tenuta dal capo della Cgil Di Vittorio fu particolarmente importante per evitare lo «sciopero insurrezionale»123. Nelle ore concitate seguite all’attentato, Secchia disse a Kostylev che «secondo la direzione del Pci e sulla base di recenti analisi degli amici dei comunisti italiani», non era il momento per un’insurrezione armata124. È evidente che egli si riferiva agli scambi tra Mosca e Roma risalenti alla fine di marzo, sapendo che l’appello alla moderazione fatto da Togliatti in ospedale alludeva a quella scelta cruciale. Non conosciamo la discussione che si svolse tra i dirigenti del Pci, ma è facile ritenere che le parole confidenziali pronunciate da Secchia rispecchiassero un orientamento condiviso dai piú. Non va dimenticato che la clamorosa rottura tra Mosca e Belgrado costituiva anch’essa un rilevante fattore di deterrenza verso un’insurrezione in Italia. Il retroterra promesso dagli iugoslavi a una rivoluzione nell’Italia del Nord sin dalla fine della guerra si era improvvisamente dissolto e ciò rafforzava obiettivamente le posizioni dei realisti.
Nel discorso tenuto al Comitato centrale del settembre 1948, rientrato sulla scena politica, Togliatti ribadí la scelta del self-containment. A suo giudizio, la situazione era «in tutto il mondo e nel nostro paese una situazione di lotta di classe», ma sbagliavano quei comunisti che davano «partita vinta all’avversario» affermando che fosse ormai l’ora di «prepararsi alla guerra». La democrazia progressiva poteva «voler dire anche guerra civile», ma considerare la possibilità di scivolare nell’illegalità e pensare che la guerra fosse «già alle porte» equivaleva a mettersi «in un cul di sacco»125. In altre parole, Togliatti riteneva che i comunisti italiani potessero combattere una «guerra di posizione» nel sistema internazionale a egemonia americana, a condizione di salvaguardare le scelte di fondo compiute alla fine della Seconda guerra mondiale, che tenevano insieme legalità, sovranità e politica di massa. Come ha osservato Norman Naimark, nel contesto della «lotta postbellica per la sovranità» in Europa, egli può essere visto come un leader che perseguiva la sovranità postfascista e la costruzione della democrazia in Italia, malgrado la sua indiscutibile lealtà a Mosca126. Ciò presupponeva una visione dell’ordine bipolare e della guerra fredda come una prospettiva non necessariamente catastrofica, che Togliatti mantenne anche negli ultimi anni dell’epoca di Stalin.
5. Sovietizzazione e pacifismo.
Tra il 1948 e il 1949 l’antifascismo cedette il passo all’anticomunismo in tutta l’Europa occidentale, mentre diveniva un’ideologia di regime nell’Europa centro-orientale. L’emergere della Democrazia cristiana come forza dominante in Italia e in Germania fu il principale segnale della stabilità conservatrice generata in Occidente dalla divisione del continente. Il containment americano pose i comunisti italiani e francesi in una posizione di minorità, anche se non ne poteva prosciugare il bacino sociale. L’ispirazione riformatrice e modernizzatrice americana fu temperata e mediata dalla Democrazia cristiana utilizzando l’anticomunismo come strumento della propria centralità politica127. Togliatti intuí che il potere della Dc poteva assicurare una posizione di rendita per i comunisti. Ma sottovalutò le conseguenze del Piano Marshall per la stabilizzazione consensuale dell’Europa occidentale. La divisione dell’Europa collocava i comunisti italiani nella difficile posizione di un avamposto del «campo socialista» nel paese piú esposto del blocco nemico e indeboliva seriamente la loro influenza politica. Le scissioni dei sindacati, avvenute simultaneamente sul piano internazionale e nazionale, costituirono la conseguenza piú deleteria dopo l’estromissione dalla sfera di governo128. La strategia di Stalin incentrata sulle sfere d’influenza geopolitiche apriva scarse prospettive ai comunisti in Occidente, senza contare gli effetti devastanti sull’Europa centro-orientale e i loro riflessi internazionali. La sconfitta strategica subita dal movimento comunista rendeva ardua ogni prospettiva di una «guerra di posizione».
La guerra fredda richiedeva ferree modalità operative e canali “coperti” a fini di sicurezza. I legami transnazionali dei comunisti italiani, irrobustiti dopo la fondazione del Cominform, furono largamente orientati dall’eredità cospirativa risalente agli anni tra le due guerre. I loro collegamenti con gli apparati di intelligence sovietici e delle «democrazie popolari», volti a adottare misure difensive paramilitari, interagirono con la presenza di organismi segreti anticomunisti quali Stay Behind129. Nel suo ruolo di responsabile dell’organizzazione, Secchia fu il principale tessitore e terminale di connessioni e dati sensibili. Spostato a Bucarest dall’originaria sede di Belgrado dopo la rottura tra Stalin e Tito, il Cominform si dotò di una segreteria permanente che costituí la principale struttura di raccordo tra il blocco socialista e i comunisti occidentali. I legami con Praga furono particolarmente rilevanti. Militanti coinvolti nelle violenze e nelle sanguinose vendette del dopoguerra nel cosiddetto «triangolo rosso», che avevano costituito un possibile focolaio di guerra civile, furono espatriati per evitare condanne penali nella capitale cecoslovacca, dove si formò una piccola comunità di comunisti italiani130. A Praga e a Mosca vennero trasferiti e conservati depositi di materiale selezionato dall’archivio corrente sin dalla vigilia delle elezioni del 1948, anche in questo caso recuperando una pratica ampiamente diffusa tra le due guerre nei rapporti con l’Unione Sovietica131. Cosí gli archivi furono preservati da eventuali sequestri di polizia ma costituivano, allo stesso tempo, strumenti di controllo molto concreto dei partiti-Stato dell’Est sul partito italiano. Il principale fattore di dipendenza restavano però i finanziamenti distribuiti ai partiti comunisti, che assegnavano quote privilegiate agli italiani e ai francesi, giocando un ruolo essenziale per sostenere i costi di apparati forti, stampa periodica, strumenti della guerra fredda culturale, campagne elettorali132. Sempre a Mosca, in continuità con le pratiche prebelliche, riprese quella della formazione dei quadri, che integrava ora le scuole di politica create in Italia e implicava scambi e incontri con i comunisti di varie parti del mondo133. Nell’ordine bipolare, tutto ciò configurava relazioni strutturate e gerarchiche, piú che una rete transnazionale paragonabile alla mobilità cominternista degli anni tra le due guerre. Le risorse messe in campo da simili relazioni costituivano un fattore di sopravvivenza ma non aggiungevano molto alla forza autonoma del mito sovietico e alla visione del destino socialista. In modo consapevole o istintivo, i comunisti italiani sapevano che la diffusione del mito poteva dipendere dalla loro capacità discorsiva e agitatoria assai piú che dalla stereotipata propaganda sovietica ed esteuropea, spesso una zavorra inefficace134.
La natura delle connessioni con l’Est europeo rifletteva una precisa visione dell’ordine bipolare. La dottrina dei «due campi» esprimeva un’ottica antagonistica, quale semplice evoluzione della visione dell’assedio reciproco tra capitalismo e socialismo risalente all’epoca prebellica. La nuova egemonia degli Stati Uniti e la ricostruzione del capitalismo europeo furono letti sempre piú attraverso le lenti degli anni Trenta, nella prospettiva del crollo economico, della fascistizzazione e della guerra. Il modello della sovietizzazione e le pratiche di autosovietizzazione si fecero imperative nel «campo socialista», spazzando via l’idea di zone intermedie e uniformando le diversità dei singoli paesi135. La fine delle «vie nazionali» nell’Europa orientale ebbe ripercussioni ovvie per i partiti comunisti occidentali, che si trovarono a rivendicare la sovranità nazionale contro l’imperialismo americano mentre quella nozione perdeva di senso nel «campo socialista».
In sostanza, la creazione del Cominform segnò la fine del modello di “nazionalizzazione” dei partiti comunisti europei nato con lo scioglimento del Comintern, ma non lanciò una strategia internazionalista ben definita, meno ancora riesumò la tradizione bolscevica del «partito della guerra civile». Le conseguenze immediate piú pericolose rappresentate dalla possibile fine dell’esistenza legale dei partiti di massa in Italia e in Francia furono disinnescate. Ciò che andava perduto, almeno per un’intera fase storica, erano invece la possibilità di accrescere quote di potere nella società nazionale e la potenziale influenza internazionale del modello di massa italiano, che presupponeva un ordine cooperativo mai davvero nato. L’influenza comunista in Italia non era però affatto liquidata. La guerra fredda perimetrava l’influenza dei comunisti in Occidente ma li dotava anche di risorse che gli italiani sfruttarono a fondo. Sul piano mitologico, la sovietizzazione dell’Europa orientale poteva apparire come una “rivoluzione dall’alto” rivolta a espandere il socialismo in Europa e una conferma della sua marcia inarrestabile nel mondo del dopoguerra, che suscitava paure o speranze come era accaduto mezzo secolo prima ma conferiva legittimità al progetto comunista. Sul piano ideologico, il ricorso all’antiamericanismo divenne un forte strumento di mobilitazione di massa e un nuovo collante per l’identità comunista dopo la fine del fascismo. Sul piano delle visioni strategiche, la scelta del pacifismo, malgrado il suo carattere scopertamente unilaterale e filosovietico, si rivelò un terreno favorevole per esercitare influenza sociale, molto al di là dei confini della sinistra. I tre piani furono strettamente intrecciati fra loro e confluirono in una concezione strategica della guerra fredda culturale, che non costituiva un semplice strumento di propaganda ma interessava le strutture identitarie dei dirigenti come dei militanti136.
Togliatti impostò la strategia pacifista del Pci in stretto coordinamento con le indicazioni di Stalin per i comunisti occidentali137. In un durissimo discorso parlamentare contro l’adesione dell’Italia al Patto atlantico, il 15 marzo 1949, equiparò l’egemonia americana al disegno di dominio hitleriano138. Il discorso riservato non era molto diverso. Togliatti spiegò al gruppo dirigente che il Patto atlantico andava considerato «un atto di guerra» e mise in guardia dal rischio di un nuovo conflitto provocato dalle politiche dell’Occidente139. I comunisti italiani si presentarono come parte di un movimento paneuropeo, rivolto ad attraversare i confini della «cortina di ferro». In Italia tale impianto presentava potenzialità politiche piú incisive che in Francia, data l’incertezza regnante tra le stesse classi dirigenti circa la collocazione del paese rispetto alla nascente Alleanza atlantica. La campagna dei comunisti contro l’ingresso dell’Italia nella Nato venne condotta nella speranza che le divisioni nel fronte moderato e conservatore, provocate dalle sirene del neutralismo soprattutto nel mondo cattolico, avrebbero potuto produrre il risultato sperato. In realtà, l’argomento della difesa della sovranità contro l’imperialismo americano poteva toccare corde nazionaliste ancora vibranti, ma in una larga parte nell’opinione pubblica perdeva credibilità alla luce del giro di vite staliniano nell’Europa orientale. De Gasperi seppe svolgere un’azione assai incisiva sul piano internazionale, portando a compimento l’ingresso dell’Italia nella Nato, un esito che non era affatto scontato. Il risultato fu una seconda dura sconfitta della sinistra dopo quella elettorale dell’anno precedente e la presa d’atto che lo scenario politico si era definitivamente cristallizzato. Il leader della Dc tenne cosí saldamente in pugno le scelte decisive della collocazione internazionale dell’Italia, mettendo la sinistra in una posizione subalterna. Il nesso da lui stabilito tra l’adesione all’Alleanza atlantica e la scelta per l’integrazione europea dell’Italia costituiva la chiave di una supremazia politica che aveva implicazioni di lunga durata140.
I comunisti poterono svolgere soltanto un’opera di propaganda, sebbene con una notevole efficacia: utilizzarono la congiuntura internazionale per dispiegare un’incisiva campagna pacifista, che faceva appello ai sentimenti contro la guerra diffusi nel paese. La nascita dei «partigiani della pace» configurò un movimento di massa in grado di raggiungere settori sociali e di opinione pubblica piú larghi del loro bacino elettorale, facendo leva sulle paure diffuse e giustificate nell’opinione pubblica. In Italia e in Francia la propaganda pacifista non giunse a influire sulle agende governative ma fu capillare ed efficace nel fare proprie istanze universaliste contro lo spettro di un olocausto atomico. Emilio Sereni fu il dirigente ideale del movimento, figura emblematica dell’internazionalismo staliniano, con la sua incrollabile fede marxista-leninista, e intellettuale di fama, in grado di organizzare e collegare interlocutori diversi su scala europea141. La mobilitazione pacifista dei comunisti occidentali suscitò l’allarme degli Stati Uniti, perché molto piú incisiva della propaganda anticapitalistica142.
Si impiantò allora una narrazione destinata a persistere molto a lungo tra i comunisti, ma anche in vari ambienti della sinistra italiana, basata su uno schema manicheo, che presentava la politica sovietica come una reazione difensiva all’aggressività del blocco occidentale. Lo schema non era nuovo e anzi rispolverava una propaganda risalente agli anni Trenta. Ma l’idea dell’Unione Sovietica come “potenza pacifica” si rinnovò nel dopoguerra quale ingrediente essenziale per il mito sovietico, che contribuiva al contenimento degli spiriti piú bellicosi. La visione degli Stati Uniti come il nuovo «nemico principale» del progresso e del socialismo cancellò ogni sfumatura e tentativo di analisi differenziata. Essa precludeva soprattutto la comprensione dell’intreccio tra liberalismo economico e modello newdealista come chiave dell’americanismo e della sua influenza in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Nell’Europa occidentale, il pacifismo rappresentò il punto di fusione tra mito sovietico e antimito americano. Un discorso che dava credibilità agli obiettivi di contestare la modernità capitalistica liberale, cementare la contro-società comunista e fornire il senso di una comunità separata dai modi di vita e di sentire delle società occidentali. Tali risorse simboliche e ideologiche furono impiegate per arginare la penetrazione dei modelli culturali americani tra le giovani generazioni o incorporarne gli aspetti materiali in un differente universo valoriale, che riproponeva l’identificazione tra sfera privata e sfera pubblica, l’etica collettivista, la condanna dell’individualismo. Le simbologie prevalenti erano spesso estranee alla dimensione nazionale e legate invece alla «comunità immaginata» del comunismo internazionale143.
Sotto questo profilo, i comunisti italiani non esprimevano alcuna specificità. Questa risiedeva semmai nel dato di fatto che le forme di una «religione politica» e l’autorappresentazione di una «comunità di credenti», alimentate da miti e antimiti della dicotomia tra socialismo e capitalismo, nascessero in Italia tardivamente rispetto ad altre esperienze del comunismo europeo. Il lungo periodo dell’illegalità aveva coinciso con il momento fondativo della sacralizzazione della politica in epoca staliniana, che era stata recepita da poche migliaia di esuli largamente sradicati dalla loro società e dispersi nell’emigrazione. Ciò non significa che la forza dei miti sovietici fosse minore in Italia. Al contrario, la congiuntura degli ultimi anni di guerra, con i suoi effetti di disgregazione politica e sociale e di disorientamento esistenziale, costituí un terreno decisivo per la nascita di nuove identità e orizzonti di senso. In questa luce, il mito sovietico aveva rappresentato assai piú un fattore spontaneo che non il prodotto di un’organizzazione, una risorsa simbolica e sincretica che nell’apocalisse della guerra dava forma a sentimenti messianici e persino credenze tradizionali nella cultura popolare144. Anche per questo motivo, quasi invariabilmente, la scelta politica continuò a presentare anzitutto una motivazione esistenziale che precedeva l’adesione e la formazione ideologica, per i semplici militanti come per gli intellettuali145. Il momento della scelta politica costituí però un passaggio pieno di ambivalenze. Per molti giovani, l’adesione all’antifascismo nacque dalla disillusione verso il fascismo come «religione politica», che poteva implicare la ricerca di un credo diverso e opposto ma anche una visione piú secolarizzata della politica, internazionalista e antinazionalista. Una simile ambivalenza si riprodusse nell’incontro con il potere e con le ideologie cattoliche nell’Italia del dopoguerra, destinato a creare tra i comunisti sia sentimenti di emulazione nella sfera della morale e nella gerarchia dei valori, sia la spinta a farsi interpreti della secolarizzazione della società italiana. Cosí la dimensione del comunismo italiano come subcultura si contaminò e diluí nelle pieghe della massa dei militanti e fu permeabile alle trasformazioni della società italiana146.
La peculiarità dei comunisti italiani si affermò nella relativa articolazione di visioni e idee che non seguivano il livellamento ideologico della guerra fredda. In primo luogo, la conquista degli intellettuali fu volta a controbilanciare l’egemonia politica dei cattolici e incentrata su una risorsa culturale esclusiva, gli scritti del carcere di Gramsci, pubblicati tra il 1948 e il 1951 sotto l’attenta redazione di Togliatti. Gli scritti di Gramsci si rivelarono subito un formidabile strumento di legittimazione nazionale nel mondo della cultura, malgrado la polarizzazione della guerra fredda. La strategia comunista di attrazione degli intellettuali esercitata tramite la lettura «nazional-popolare» di Gramsci presentava un orizzonte strettamente nazionale e implicava scarsa apertura verso le trasformazioni sociali e culturali in atto, destinate a cambiare il volto della società e la funzione degli intellettuali147. Tuttavia, essa consolidò l’interazione tra un nucleo dirigente capace di parlare linguaggi rivolti alle classi colte come agli operai e ai contadini, da una parte, e un ambiente allargato di intellettuali politicizzati che si potevano sentire in contatto con la realtà popolare, dall’altra parte148. In secondo luogo, la mobilitazione di massa dal 1950 in avanti fu condotta anche in difesa della Costituzione della Repubblica, intesa come espressione del mito resistenziale, un documento programmatico volto a cambiare il volto della società italiana e un antidoto contro la reazione. L’investimento simbolico nel discorso sulla Costituzione fu direttamente proporzionale alla sua genericità149. Sotto questa luce, il Pci si poteva però autorappresentare quale forza antigovernativa ma non antisistemica, sebbene la sua appartenenza internazionale e il suo stesso riferimento alle «democrazie popolari» creassero abbondanti spinte nella seconda direzione.
In entrambi i casi, era il profilo nazionale del partito a essere esaltato, coesistendo con le rappresentazioni della «comunità immaginata» transnazionale. Tuttavia, simili peculiarità nazionali sarebbero state inconcepibili al di fuori della prospettiva di una «guerra di posizione» internazionale basata sulla presenza del «campo socialista». Togliatti si premurò di tracciare un profilo storico del Pci come forza progressista e «necessaria» della nazione italiana, ma si guardò bene dal diminuirne il nesso internazionale. Il suo scritto Appunti e schema per una storia del Partito comunista italiano del 1951 cercava di fornire una versione storicamente credibile, ancorché infarcita di narrazioni mitologiche. Pubblicato in un Quaderno di «Rinascita» dedicato al trentennale del Pci, il suo scritto ebbe notevole diffusione. Egli si rivolgeva a una platea unitaria secondo l’idea di «un largo fronte nazionale democratico della cultura»150. Nella sua argomentazione, il canone nazionale gramsciano e il canone marxista-leninista internazionale trovano un loro punto d’incontro. Il primo rimandava a una lettura della storia italiana condivisa da molti, incentrata sulla ristrettezza delle basi popolari dello Stato unitario e sulla cronica debolezza delle classi dirigenti borghesi. Il secondo accoglieva senza riserve le coordinate del Breve corso staliniano, ampiamente diffuso tra i militanti del partito, circa l’ineluttabilità dei processi storici aperti dall’Ottobre, il culto dello Stato sovietico e la mutilazione della storia rivoluzionaria151. La sapiente regia di Togliatti teneva cosí insieme due narrazioni apparentemente dissociate, entrambe valide per i dirigenti e i quadri come per i militanti senza alcuna separazione né distinzione gerarchica. Come è stato notato, la divisione concettuale della cultura politica comunista in una sfera elitaria legata a Gramsci e una sfera di massa legata allo stalinismo appare in buona parte fuorviante152. Il legame simbolico costruito nell’iconografia comunista attorno alle figure congiunte di Gramsci e Togliatti aveva la funzione di un forte riferimento alle origini e rappresentava l’unico culto legittimante non esclusivamente circoscritto all’epoca staliniana nel panorama del comunismo europeo153. Si metteva invece la sordina sulla genealogia cosmopolita rappresentata da Gramsci, in particolare sugli interrogativi che questi aveva posto circa il nesso tra l’esperienza sovietica e la rivoluzione mondiale. Formulati in un passato ormai sepolto, quegli interrogativi mantenevano una loro attualità nel mondo della superpotenza sovietica e della rivoluzione cinese, ma non potevano essere espressi.
6. I limiti dell’internazionalismo staliniano.
La personalità di Togliatti continuò ad apparire imponente anche dopo la nascita del Cominform. Alla fine del 1949 egli ricevette un’ulteriore investitura da Mosca. Fu infatti relatore alla III Conferenza del Cominform, tenuta a Budapest dal 16 al 19 novembre, che di fatto celebrò la nascita del blocco sovietico. In questa sede, Michail Suslov, astro nascente tra i dirigenti staliniani, presentò la «lotta per la pace» come la parola d’ordine chiave nel repertorio di Mosca lanciando, in realtà, la prospettiva della guerra incombente, con un’evidente allusione al ritorno degli scenari di dieci anni prima, alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Togliatti tenne un discorso piatto e allineato, che si ricollegava ai momenti di piú feroce scontro con le socialdemocrazie. Oltre a giustificare, con la sua stessa presenza, la spirale della sovietizzazione, attaccò l’«europeismo» e il «cosmopolitismo» delle socialdemocrazie come «arma di propaganda dell’imperialismo», che niente aveva a che fare con l’internazionalismo socialista. La sua requisitoria incluse senza riserve tutti i leader socialisti europei, accusati tra l’altro di favorire la «diplomazia atomica» e la conversione dell’Europa occidentale in un mercato «coloniale» degli Stati Uniti. Non risparmiò neppure le nazionalizzazioni e il welfare del Partito laburista, che a suo giudizio non avevano intaccato il potere dell’«oligarchia finanziaria». Tutto ciò favoriva, a suo dire, la mobilitazione di massa da parte dei comunisti, particolarmente sulla questione della pace154. Era già evidente che la lotta contro Tito, condotta con gli espedienti piú velenosi della propaganda staliniana, producesse una deriva di sospetto e di persecuzioni nei paesi di «democrazia popolare», iniziata con la rimozione di Gomułka in Polonia e proseguita in Ungheria e Bulgaria con i casi di László Rajk e Trajčo Kostov. Togliatti assunse consapevolmente la responsabilità di porsi in prima linea nell’internazionalismo staliniano della guerra fredda. Una simile scelta si prestava facilmente all’accusa di privilegiare una lealtà compromettente e inconciliabile con la sua immagine nazionale. Eppure egli non sembrò curarsi delle ripercussioni in Italia e guidò una delegazione composta da esponenti legati a doppio filo a Mosca quali D’Onofrio e Cicalini. Dopo la divisione della Germania in due Stati e del continente europeo in due blocchi, questo tipo di legittimazione sembrava costituire un elemento irrinunciabile per l’esercizio della leadership comunista. Le persecuzioni antititine furono messe in atto anche in Italia, colpendo dirigenti di un certo rilievo in Emilia e nel movimento pacifista, come Valdo Magnani e Aldo Cucchi155.
Il 26 dicembre 1949 Togliatti incontrò Stalin per la prima volta dopo cinque anni, in occasione delle celebrazioni per il settantesimo compleanno del dittatore, nel pieno dell’espansione mondiale del movimento comunista. La prospettiva di un rilancio rivoluzionario in Asia, dopo la proclamazione della Cina popolare, si combinava con lo scenario della guerra incombente, anche se l’atomica sovietica costituiva per i comunisti un motivo di rassicurazione. Stando agli appunti presi dallo stesso Togliatti, Stalin fece cenno al progetto di estendere il Cominform in Asia, che però avrebbe incontrato la resistenza di Mao Zedong con l’argomento che si rischiavano infiltrazioni spionistiche156. Non è senza significato che Stalin confidasse a Togliatti un’informazione cosí sensibile. La questione di un «Cominform asiatico» era molto controversa. Pechino poteva vederla come un’occasione per istituzionalizzare il proprio ruolo di hub internazionalista in Asia, in una ripartizione geopolitica di ruoli già delineata prima della presa del potere; Mosca invece poteva intenderla come un modo di esercitare maggiore controllo sui comunisti cinesi, limitando la loro sovranità rivoluzionaria. In ogni caso, Stalin riconosceva nuovamente a Togliatti un ruolo di primo piano nel comunismo internazionale.
Il colloquio tra Togliatti e Stalin gravitò attorno al tema delle «vie nazionali», ormai riservato ai soli comunisti occidentali. Stalin confermò la sua ambiguità. Da una parte, non era propenso a incoraggiare un conflitto violento in Italia, per le sue pericolose implicazioni internazionali, e suggerí anzi un improbabile «governo borghese» a partecipazione comunista. Dall’altra parte, però, insistette sull’importanza dell’azione extralegale come strumento per preparare il partito alle future battaglie, anche se tale scenario non valeva per l’immediato. Gli scarni appunti presi da Togliatti nel colloquio con Stalin inquadravano il tema fondamentale della contraddizione fra il retaggio della “guerra civile europea” e la prospettiva di una «guerra di posizione». In generale, Stalin pose enfasi sulla spregiudicatezza tattica piuttosto che su qualsiasi principio strategico. Le sue parole in tema di religione fornirono l’esempio piú eloquente: «Non attaccare la religione; potete credere anche nel Dio-gatto, come gli Egiziani»157. Forse era questo il suo modo di commentare la scelta dei comunisti italiani di aprire le porte del partito ai credenti. Ma il tema del partito di massa restava delicato e controverso, ancor piú negli scenari di guerra che si profilavano.
Nell’aprile 1950, Togliatti disegnò al Comitato centrale lo scenario di una «confusione e disgregazione del mondo occidentale» che poteva avvicinare la guerra e presentò il blocco democristiano come un mero «dispositivo politico e sociale» che avrebbe portato verso la catastrofe. Il suo riferimento al ruolo dei comunisti nella Resistenza non era un fatto nuovo, ma annunciava una mobilitazione particolarmente impegnativa data la crescente «psicosi di guerra»158. Una settimana dopo, Secchia riferí alla segreteria del Cominform circa il cospicuo sforzo di mobilitazione di massa attuato dal Pci sul tema della pace159. Era alle viste una campagna antiatomica che rappresentò il culmine della mobilitazione pacifista e che vide in prima fila tutti gli esponenti principali del gruppo dirigente. Lo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950 portò repentinamente la tensione a un livello ancora piú elevato, proponendo lo scenario di una militarizzazione globale dei blocchi. Le piú fosche previsioni di guerra si diffusero in un’opinione che travalicava i confini delle zone d’influenza del comunismo europeo. Nella pubblicistica comunista si moltiplicarono le profezie catastrofiche. Togliatti mantenne però alta la guardia del suo anticatastrofismo. In una riunione della Direzione, il 12 luglio 1950, pur riconoscendo giustificato l’allarme piú forte, egli avrebbe sostenuto che malgrado tutto la guerra non era inevitabile e che il governo non avrebbe messo al bando il Pci160. La continuità con le posizioni assunte sin dal 1947 appare evidente. Nel discorso pubblico, egli invitò la classe dirigente democristiana a comprendere la lezione di Giolitti, valutando il ruolo progressivo del movimento operaio invece di reprimerlo. Ma quello stesso discorso era anche un messaggio rivolto alla sua parte, quando ricordava che i feroci attacchi al giolittismo avevano giovato soltanto ai nazionalisti e alla destra161.
Il gioco di specchi delle reciproche percezioni della minaccia tra i due blocchi nella politica italiana profilava la medesima dinamica di due anni prima: i riflessi delle tensioni internazionali, la tendenza a identificare il pericolo in un nuovo «fascismo» o «totalitarismo», la predisposizione di misure di natura paramilitare, la caparbietà dei leader nella ricerca di una soluzione politica. De Gasperi giunse a definire il Pci come una «quinta colonna» sovietica nel blocco occidentale e fece varare misure eccezionali dal ministro degli Interni Scelba, ma la sua condotta fu nel complesso moderata162. Questa volta però la moderazione di Togliatti rischiava l’isolamento. In settembre, l’opzione extralegale sarebbe stata presentata da Secchia e Longo come una possibilità autentica che chiedeva una preparazione organizzativa adeguata163. Poco dopo le sorti della guerra in Corea si aggravarono sensibilmente, delineando un conflitto sul campo tra la Cina popolare e gli Stati Uniti. Nel novembre, si riuní a Sofia il segretariato del Cominform per esaminare un piano di rilancio dell’organizzazione internazionale, attribuito alla volontà di Stalin e rivolto a consolidare il controllo centrale di Mosca sui partiti europei. In questa occasione i delegati italiani, Pietro Ingrao e D’Onofrio, aderirono al piano ma furono messi sotto accusa perché il Pci sembrava ancora indugiare nelle sue attività legalitarie e indulgere a una scarsa vigilanza ideologica164.
Fu in questo clima che Stalin chiese a Togliatti di assumere la guida del Cominform a Praga. La scelta di Stalin per Togliatti aveva un senso. Dopo la defezione di Tito e la morte di Dimitrov, egli rappresentava la personalità piú rilevante del comunismo europeo. La Conferenza del Cominform del novembre 1949 aveva confermato questo riconoscimento. Come leader del piú grande partito comunista in Occidente, la sua esposizione in un ruolo del genere avrebbe assunto il significato di una mobilitazione contro l’Alleanza atlantica non piú confinata all’orchestrazione dei movimenti pacifisti. Nello stesso tempo, figure come Secchia e Longo promettevano, grazie all’allontanamento di Togliatti, una sterzata del comunismo italiano verso opzioni extraparlamentari rispondenti alla prognosi di un conflitto internazionale imminente. La vicenda che ne seguí rimase avvolta nel segreto all’epoca, ma le sue implicazioni furono molto rilevanti per il Pci e per il Cominform. Ospite a Mosca per curarsi dopo un incidente automobilistico sospetto, Togliatti si trovò quasi ostaggio di Stalin per alcuni mesi. Siamo a conoscenza soltanto genericamente del contenuto dei suoi incontri con il dittatore165. In ogni caso, egli rifiutò la proposta di fare il segretario del Cominform senza consultare i propri compagni e instaurò un inopinato braccio di ferro con Stalin. Le motivazioni di Togliatti nella sua lettera a Stalin del 4 gennaio 1951, inviata dopo un colloquio informale tra i due, furono di ordine nazionale e personale, ma rimandavano anche a una diversa visione degli scenari della guerra fredda. Togliatti dichiarò di preferire il proprio incarico come segretario del partito italiano e ribadí le ragioni che mantenevano aperta la strada di un radicamento del partito nella società nazionale. Sostenne che le possibilità di un’azione legale del Pci non erano esaurite e si poteva anzi pensare di «estenderne l’influenza». Mise anche in dubbio l’utilità stessa del Cominform, da lui visto come «un’organizzazione clandestina», a confronto della dimensione politica di massa assicurata dal movimento dei «partigiani della pace»166. In sostanza, il suo messaggio a Stalin era che la guerra fredda non dovesse necessariamente precipitare in un conflitto armato e che il bipolarismo militarizzato non avrebbe comunque impedito lotte legali di massa in Europa.
Stalin non accolse gli argomenti di Togliatti e si impegnò in un’opera di persuasione con l’appoggio dei massimi dirigenti del Pci. Alla fine di gennaio, Stalin incontrò Togliatti alla presenza di Secchia e Longo, nel frattempo convocati a Mosca, sostenendo che una guerra poteva scoppiare da un momento all’altro e che i partiti comunisti europei sarebbero presto piombati nell’illegalità. Il leader sovietico riteneva necessario consolidare il Cominform quale centro organizzativo di una rete comunista clandestina composta anche dai partiti comunisti dell’Europa occidentale. Con questa fosca prognosi Stalin scioglieva a suo modo il nodo del 1947-48. Sul terreno non c’era l’opzione dell’insurrezione, ma dinanzi alla prospettiva della guerra si affermava comunque quella dell’azione extralegale, proprio come era accaduto nel 1939. Nella mentalità staliniana, propensa a leggere il presente in chiave di reiterazione del passato, si ripeteva lo scenario della fine degli anni Trenta. Quando Secchia e Longo riportarono alla Direzione del Pci a Roma i termini dell’incontro, il 1° febbraio, la maggioranza appoggiò la proposta di Stalin, con il voto contrario dei soli Terracini, Di Vittorio e Noce e l’astensione di Longo e Pajetta. Inviati a Mosca, Secchia e Colombi trasmisero il 12 febbraio a Stalin una nota informativa sulla decisione favorevole della Direzione, che era sottoscritta anche da Togliatti e proponeva il suo rientro temporaneo in Italia per il Congresso del partito167. Sebbene messo in un angolo dal suo stesso gruppo dirigente, Togliatti rifiutò ostinatamente di cambiare idea. Stalin giocò la sua ultima carta nel febbraio 1951 in un ulteriore incontro con Togliatti e Secchia, invitando il leader italiano a lasciare da parte le motivazioni di carattere personale e ignorando quelle politiche che aveva messo sul tavolo. Togliatti ne uscí tramite un compromesso, l’impegno generico di aderire alla proposta soltanto dopo lo svolgimento del VII Congresso del Pci168.
Cosí per la prima volta nella sua vita Togliatti si dissociò apertamente da Stalin. Nello stesso tempo, dovette ingaggiare una lotta con i membri di maggior spicco del suo partito. Il sostegno fornito alla proposta di Stalin dal gruppo dirigente del Pci rivelava un riflesso di disciplina ma anche, molto probabilmente, il disegno di rimuovere Togliatti dalla guida del partito, dopo che questa opportunità era svanita nel 1947-48. Le confidenze fatte dieci anni dopo dallo stesso Togliatti a Luciano Barca avvalorano l’ipotesi di un autentico complotto facente capo a Secchia. Togliatti confidò a Barca di ritenere che prima ancora della sua partenza per Mosca, Secchia e D’Onofrio avessero concordato con Berija l’operazione di inviarlo a Praga e rimuoverlo dalla carica di segretario del Pci. A Stalin tale operazione sarebbe stata verosimilmente presentata come una proposta del partito italiano. Ciò spiegava, agli occhi di Togliatti, sia la visita inusuale fattagli da Stalin alla dacia poco dopo il suo arrivo, sia la «meraviglia» del dittatore per il suo rifiuto. Per convincere Longo sarebbe invece stato sufficiente dirgli che la direttiva veniva da Stalin. Togliatti ammetteva la propria sorpresa dinanzi al voto della maggioranza della Direzione contro la sua volontà. Ricordava di essere infine riuscito a convincere Stalin che «la questione era politica» e non aveva niente a che fare con la sua «sicurezza personale», smontando l’argomentazione di Berija169. Le rivelazioni retrospettive di Togliatti a Barca sono per parte essenziale corroborate da un appunto di Secchia conservato nelle sue carte, anch’esso chiaramente scritto ben dopo gli eventi. Questi negava di essere stato mosso da ambizione personale, ma riconosceva la propria responsabilità e coinvolgeva Longo, presentandolo anzi come il piú convinto della opportunità di fare a meno di Togliatti. Entrambi erano stati mossi, sosteneva, da «considerazioni politiche» e precisamente che il partito sotto Togliatti «si sarebbe andato sviluppando come un p[artito] socialdem[ocratico]». Tale opinione risaliva indietro fino al 1945. Portando un’argomentazione già prodotta in passato, ricordava un amaro colloquio con Longo del giugno 1945 sulla Resistenza «svalutata». Secchia faceva anche cenno al compromesso raggiunto a Mosca con Togliatti, addossandone la responsabilità a Colombi. I sovietici capirono subito che Togliatti non sarebbe mai andato a Praga. Stalin concluse la vicenda dichiarando che «la situazione è chiara. I comp[agni] italiani temono di offendere T[ogliatti] e T[ogliatti] teme di offendere noi»170.
L’episodio provocò una rottura irreparabile fra Togliatti e Secchia e una grave spaccatura nel gruppo dirigente del partito171. Sentitosi tradito, Togliatti ebbe l’accortezza di recuperare la generazione degli Amendola e dei Pajetta al proprio fianco. La questione però era «politica», come affermava Togliatti, in un senso profondo, perché chiamava in causa insieme la leadership e la cultura politica. Egli difese l’opzione anticatastrofista che aveva ispirato la sua azione politica dopo la guerra e la fece valere come un limite all’applicazione di una cieca disciplina internazionalista. L’episodio segnalava una divergenza tra Togliatti e Stalin nel giudizio sull’evoluzione della guerra fredda, oltre che nel modo di concepire il ruolo di un partito comunista di massa nell’Europa occidentale. Le visioni catastrofiste rilanciate da Stalin fecero invece facilmente breccia tra i massimi dirigenti del Pci, mettendo a nudo un dissidio a lungo covato nei confronti di Togliatti. All’apice della guerra fredda, Secchia e Longo rivelarono non soltanto un senso di appartenenza incondizionato all’Unione Sovietica, ma un legame con la tradizione prebellica dell’attesa della guerra. Secchia fu vicino a creare una nuova maggioranza pronta a irreggimentare il partito di massa in una piú robusta struttura di quadri e “rivoluzionari di professione”, che sarebbe equivalsa a una normalizzazione del Pci nel panorama del comunismo europeo. Il suo disegno non era rivolto a scatenare una rivoluzione, ma alla preparazione per uno scenario di guerra. Una simile mutazione del partito di massa in Italia sarebbe stata di per sé un fattore di militarizzazione e conflitto, con l’aggravante che il suo leader piú popolare avrebbe operato in semiclandestinità al di là della «cortina di ferro». Cosí il Pci sarebbe inevitabilmente entrato in rotta di collisione con il mutamento della strategia anticomunista americana in Italia e in Francia, fattasi piú aggressiva sin dall’inizio del 1950, con l’obiettivo non soltanto di tenere i comunisti fuori dal governo ma di realizzare misure di psychological warfare172. In altre parole, l’eventuale successo del disegno di Secchia avrebbe probabilmente avuto conseguenze gravi e irreparabili per la stessa democrazia repubblicana.
Con tutta la pedagogia e le energie impegnate nel ricostituire un nuovo gruppo dirigente dopo i conflitti e le rotture degli anni tra le due guerre, Togliatti si trovò quasi in solitudine al momento di mettere in discussione la totale lealtà a Mosca per salvaguardare il «partito nuovo». Soltanto figure di outsider mostrarono di aver appreso a fondo la lezione della guerra civile evitata nel dopoguerra. La chiave delle sue argomentazioni fu l’appello alla continuità di una visione che legava l’elemento nazionale con quello internazionale. Il riferimento alla «lotta per la pace» rimandava a una tradizione saldamente legata all’Unione Sovietica. Il nodo posto da Togliatti contrapponendo il movimento di massa dei «partigiani della pace» alle pratiche cospirative del Cominform rimase in sospeso e doveva essere sciolto soltanto dopo la morte di Stalin. Ma non è esagerato ritenere che il rifiuto di Togliatti contribuí al tramonto definitivo del Cominform, che non svolse alcun ruolo significativo negli ultimi due anni di Stalin. Cosí il progetto togliattiano del partito di massa rivelò un imprevedibile e cruciale riflesso internazionale, anche se esso non divenne di dominio pubblico.
Nell’aprile 1951, al VII Congresso del Pci, Togliatti rivendicò la scelta legalitaria e costituente fatta alla fine della guerra, malgrado la spirale della guerra fredda. Il suo discorso politico legò la dimensione di massa del «partito nuovo» alla lotta per la pace, alla fedeltà costituzionale e alla difesa del «parlamentarismo». Secchia espresse un punto di vista diverso, chiedendosi quale fosse il senso di avere un partito di massa se questo non contava a sufficienza nella vita politica del paese173. Ma la differenza tra i due non si limitava a questo punto, per quanto decisivo. La stessa idea togliattiana della guerra fredda non era quella di un conflitto fatalmente destinato a precipitare, bensí di una «guerra di posizione» a lungo termine. L’insediamento di massa del Pci nello spazio democratico della Repubblica italiana si basava sulla continuità di una simile visione dell’antagonismo bipolare e su una conseguente prassi politica, destinata a farsi strada in modo empirico e graduale. La scelta della legalità costituiva anche una forma di resistenza alle inclinazioni americane di puntare sulla messa al bando del Pci, che trovava una sponda nell’anticomunismo conservatore della Dc. Come Togliatti sapeva bene, dal punto di vista di De Gasperi ogni tentativo di sradicare il comunismo italiano costituiva un obiettivo non solo rischioso e difficile, ma controproducente, perché avrebbe prodotto un terremoto politico destinato a compromettere le basi stesse del sistema politico dominato dalla Dc. Il partito cattolico basava la propria funzione non soltanto sull’anticomunismo ma anche sul riconoscimento costituzionale del Pci nello spazio repubblicano174.
Dal punto di vista di Togliatti, il legame biografico con Stalin restava un punto fermo e indiscutibile. Fu questo il senso principale del suo discorso in morte di Stalin, il 6 marzo 1953. Tutti i comunisti senza eccezione, ricorda Hobsbawm, vedevano in Stalin il «comandante del disciplinato esercito del comunismo mondiale nella guerra fredda globale», lo ammiravano «come leader e personificazione della Causa», e provarono un «senso di dolore e di perdita personale», sentimenti condivisi «anche da leader temprati come Palmiro Togliatti, che conosceva da vicino il terribile dittatore»175. In due passaggi chiave questi definí Stalin, prima ancora che l’alfiere della pace e dell’antifascismo, «il fondatore e capo dello Stato socialista» e rivelò pubblicamente il momento piú significativo della loro lunga partnership, sostenendo che era stato Stalin «che nel terribile 1944 per primo tese al nostro popolo la mano» e ricordando «il colloquio con lui in quell’anno, prima del mio ritorno in Italia». Togliatti concluse dichiarando che l’eredità di Stalin era «troppo profonda perché da essa ci si possa dipartire»176. A queste parole egli doveva rimanere fedele nei termini fissati al momento del commiato, anche dopo la denuncia del dispotismo staliniano pronunciata da Chruščëv.
Ciò che Togliatti passò sotto silenzio era il carattere estremamente controverso dell’eredità di Stalin persino nel mondo comunista. La visione della guerra inevitabile tra i «due campi», la sovietizzazione violenta dell’Europa centro-orientale e la creazione di un organismo sovranazionale cospirativo e poliziesco come il Cominform costituivano altrettanti nodi problematici. Togliatti aveva costruito il progetto del partito di massa nell’Italia democratica in stretta connessione con le scelte geopolitiche fatte da Stalin alla fine della guerra. La sua strategia legalitaria e di self-containment aveva contribuito in modo decisivo a scongiurare una possibile catastrofe italiana, malgrado la pressione delle componenti intransigenti nel suo stesso partito. Ma in momenti diversi, soprattutto dopo la divisione dell’Europa, Togliatti si trovò anche a difendere la propria visione resistendo alle spinte innescate dalla guerra fredda sovietica, in un precario equilibrio di lealtà e dissidi che coinvolse il suo stesso gruppo dirigente. La scelta della legalità democratica si rivelò una conquista ottenuta ingaggiando una difficile partita con i propri partner internazionali, oltre che moderando le dinamiche piú pericolose attive nella società nazionale.
L’ordine bipolare mondiale consolidò cosí in Italia identità fondate sull’antagonismo tra due grandi aggregati politici, posizionati in modo permanente al governo e all’opposizione. Entrambi basavano parte essenziale della propria identità su immagini speculari del nemico. Il loro reciproco assedio innescò dinamiche di delegittimazione politica di lunga durata177. L’immagine del comunismo come totalitarismo, veicolata nella propaganda cattolica, si coniugava spesso con una visione prepolitica, volta a dipingerlo come una forma di barbarie e un’aggressione ai valori cristiani. Il paradosso dell’egemonia cattolica fu che costituiva l’architrave politico della ricostruzione italiana e della democrazia repubblicana, ma nello stesso tempo la sua componente clericale contribuiva a creare una nuova divisione della nazione. L’immagine dell’anticomunismo veicolata nella propaganda comunista era piú politica ma non meno antinomica, volta com’era a etichettarlo spesso come un nuovo fascismo e a denunciare l’adesione all’Alleanza atlantica come una cessione della sovranità nazionale. Le principali idee del mondo occidentale fatte proprie dai militanti comunisti replicavano i dogmi stalinisti circa l’inevitabilità del collasso economico, la povertà di massa e la guerra inevitabile, rimuovendo o negando la natura dittatoriale dei regimi comunisti nell’Europa centro-orientale. La sconfitta subita nel 1948 creò il mito di un tradimento dell’autentica volontà popolare imposto dall’esterno, che infondeva la promessa ambigua di una futura rivincita da prendere o di una resistenza da ricominciare.
Alla fine dell’epoca staliniana, si poteva affermare che il comunismo italiano costituisse tanto un fattore di frattura della nazione politica, anche se non l’unico, quanto una componente della Repubblica, anche se bandita dalla sfera di governo. Togliatti parlò entrambi i linguaggi, ma il suo ruolo fu decisivo per stabilizzare e dare un senso alla bipolarità italiana. Egli esercitò la propria leadership per costruire una visione politica dell’avversario, rivolta a mediare le antinomie dei blocchi nella vita nazionale e idonea alla prospettiva di una lunga «guerra di posizione» internazionale. La dimensione internazionale non implicava soltanto inconciliabilità valoriale, esistenziale e ideologica, ma cristallizzava la divisione nazionale creando una forma di stabilità, intesa come tregua permanente. I nessi stabiliti tra la politica nazionale e la politica internazionale costituirono, sotto questo profilo, tanto un veicolo di importazione della guerra fredda in Italia quanto un fattore di contenimento delle sue implicazioni peggiori, configurando un modello politico che doveva avere lunga vita. L’internazionalismo non era però un dato statico o una permanenza del passato. Costituiva un pilastro centrale di immaginari, pratiche e cultura politica che dopo la morte di Stalin dovevano conoscere serie trasformazioni, valicando i confini del legame organico con il mondo socialista.
Capitolo quarto
Policentrismo e decolonizzazione
1. Destalinizzazione e crisi in Europa.
Subito dopo la morte di Stalin, il mondo comunista riconobbe per la prima volta legittima l’idea di una riforma “dall’alto”. Sia pure nel contesto opaco e contorto delle lotte di successione, le prime misure intraprese dagli oligarchi sovietici delinearono un immediato distacco dal Terrore staliniano e allentarono le tensioni peggiori della guerra fredda, mettendo fine alla guerra in Corea. Nello stesso tempo, la protesta popolare repressa con la violenza a Berlino Est nel giugno 1953 disvelò il potenziale della rivolta sociale contro la sovietizzazione. Il distacco da Stalin si presentò subito come un fenomeno contraddittorio, una necessaria ricerca di stabilità e una fonte di destabilizzazione nel «campo socialista». L’allentamento della tensione internazionale costituiva comunque uno sviluppo favorevole per i comunisti occidentali. La destalinizzazione offriva loro la promessa di una sponda internazionale in sintonia con le scelte della legalità e della politica di massa, a differenza di quanto era accaduto negli anni precedenti. Il cambiamento transnazionale presentava implicazioni politiche e culturali, oltre che generazionali e organizzative. Togliatti stabilí una sintonia con gli orientamenti dei successori di Stalin, in particolare con Georgij Malenkov, in quel momento ritenuto il principale successore di Stalin, e il suo appello alla «coesistenza pacifica» contro la minaccia della guerra nucleare. Il 12 aprile 1954, Togliatti pronunciò un discorso sul pericolo costituito dalla bomba atomica per la distruzione del genere umano. Egli si rivolse al mondo cattolico indicando l’obiettivo della «salvezza della civiltà» e precisò che l’idea della «coesistenza pacifica» valeva tanto per i rapporti internazionali quanto per «i rapporti interni di un solo Stato»1. Le conseguenze furono ben colte da Secchia, che avrebbe commentato velenosamente: «Prima parlavamo di “classe”, poi di “patria”, adesso siamo arrivati a “umanità”… dove andremo a finire?»2.
In effetti, Togliatti rompeva il canone classista e poneva un nodo di cultura politica destinato a riformare e anche dividere le visioni dei comunisti sul piano globale. Come sempre nella sua condotta, una simile dichiarazione si legava a posizioni politiche. In una lettera alla segreteria, scritta al momento della scomparsa di De Gasperi, rilevò l’esigenza di inserire «in forme sempre piú efficaci il movimento per la distensione europea» nel «conflitto» tra le potenze occidentali emerso sulla questione della Comunità Europea di difesa3. Il commiato di Togliatti da De Gasperi fu particolarmente duro e si basò sul linguaggio della guerra fredda, probabilmente nell’intento di mandare un messaggio ai suoi successori e di compattare le file del proprio partito in un momento di passaggio decisivo4. Egli mancò di riconoscere al leader democristiano la capacità di ritagliare spazi di manovra nazionali nel contesto del nesso transatlantico, mentre egli stesso aveva seguito logiche di autodifesa dalle pressioni dei propri partner e vincoli internazionali. Tuttavia, la sua condotta rivelò una linea precisa. La disgrazia di Secchia, sostituito nell’ottobre 1954 nella carica di responsabile dell’organizzazione con un «comunista nazionale» come Amendola, mise alle spalle le suggestioni extralegalitarie, già indebolite dal fallimento del progetto degasperiano di democrazia protetta nelle elezioni dell’anno precedente5. Secchia restava vicesegretario ma perdeva definitivamente la propria influenza ed era consapevole di uscire sconfitto dal braccio di ferro con Togliatti6. Questi aveva di certo lungamente preparato una simile mossa, sfruttando infine l’opportunità offertagli dallo scandalo di Giulio Seniga, l’assistente di Secchia fuggito con fondi del partito nel mese di luglio. Vale però la pena rilevare come la scelta di Togliatti si collocasse in un preciso momento. Quando cioè, scomparso De Gasperi nell’agosto 1954, la pressione americana per la messa fuori legge del Pci raggiunse il suo culmine, inducendo Scelba a preparare e presentare, alla fine dell’anno, un pacchetto di provvedimenti che avrebbero potuto destabilizzare gli equilibri costituzionali dell’Italia7. La Dc non seguí alla lettera una simile logica anche perché la decisione di Togliatti di smantellare l’apparato secchiano gettò acqua sul fuoco della guerra fredda interna.
Togliatti si mosse nella prospettiva di una destalinizzazione graduale e silenziosa. Tuttavia, la caduta di Malenkov e l’ascesa di Nikita Chruščëv impressero una dinamica incontrollabile, che doveva generare un’onda d’urto transnazionale. Nel febbraio 1956 il XX Congresso del Pcus costituí l’occasione per il lancio della dottrina della «coesistenza pacifica», che consolidava il graduale allentamento delle tensioni peggiori e creava uno spazio di manovra decisamente piú largo per i comunisti occidentali. Dal punto di vista di Togliatti e del Pci, si chiudeva nel migliore dei modi il ciclo del doppio registro tra la «lotta per la pace» come mobilitazione di massa e l’attività cospirativa e poliziesca del Cominform che si era aperto nel 1949. Il leader italiano partecipò alla decisione di liquidare il Cominform presa proprio durante i lavori del Congresso8. Il gruppo dirigente sovietico sancí la fine dell’organizzazione poco dopo, il 13 aprile 1956, prevedendo di stabilire nuove forme di raccordo del movimento comunista, senza cenni critici all’epoca staliniana9. Tuttavia, il XX Congresso aprí anche un fronte imprevedibile e dirompente. L’impatto del «rapporto segreto» pronunciato a porte chiuse da Chruščëv cambiò le carte in tavola per tutti i comunisti. A Mosca, Togliatti venne messo a parte del documento come altri capi delle delegazioni, ma si guardò bene dal parlarne persino con il proprio gruppo dirigente, attenendosi in modo scrupoloso all’impegno di riservatezza preso con i sovietici. Retrospettivamente si giustificò dicendo di avere riferito alla segreteria «sulla base di appunti», ma di non essersi «ritenuto autorizzato a riferirne alla direzione»10. Le indiscrezioni circolanti sulla stampa occidentale circa il «rapporto segreto» provocarono però una crescente fibrillazione.
Fu Amendola a sollevare la questione il 5 aprile 1956 al Consiglio nazionale del Pci, invocando la necessità di fare chiarezza ma anche il carattere liberatorio delle rivelazioni di Chruščëv, che avrebbero sollevato il Pci «da ogni ipoteca». Barca annotò nel proprio diario che per la prima volta si creava una spaccatura palese nel gruppo dirigente11. Togliatti difese la scelta del silenzio e rivendicò il «legame di ferro» usando un’infiammata retorica autobiografica («questa era la nostra parte, questa era la nostra causa, la nostra bandiera, la nostra vita»)12. Consapevole del carattere esplosivo dell’attacco al mito di Stalin, e probabilmente in dissenso con la scelta chrusceviana, egli evitò fin quando possibile di prendere una posizione. La denuncia dei crimini di Stalin colpiva la credibilità del movimento comunista e parte essenziale della mitologia sovietica, compresa la «Grande guerra patriottica», offrendo in compenso un vago riscatto morale e la narrazione del “ritorno a Lenin”, utile a difendere la legittimità rivoluzionaria ma contraddittoria con l’idea di una continuità ininterrotta nella «costruzione del socialismo». Lo stesso Togliatti si era impegnato per difendere a spada tratta la figura storica di Stalin, non soltanto al momento della morte del dittatore. Le rivelazioni sul «rapporto segreto» di Chruščëv liquidarono tuttavia la prospettiva di voltare pagina con gradualità rispetto all’eredità staliniana.
Il 1° giugno 1956 Togliatti incontrò Tito ristabilendo le relazioni bruscamente interrotte otto anni prima e inaugurando un rapporto bilaterale destinato a rivestire un’importanza sempre maggiore per il Pci, anche rispetto ai partiti-Stato del blocco sovietico. Togliatti condivise con il leader iugoslavo il giudizio che Chruščëv non aveva «chiarito a fondo» come erano stati possibili «i gravissimi errori compiuti da Stalin». A suo giudizio, si doveva criticare Stalin «sulle questioni di importanza politica» evitando di «distruggere moralmente la sua figura e ignorare la parte positiva della sua attività». Tito pose piuttosto l’accento «sui processi di burocratizzazione». Togliatti stabilí quindi con Tito un’intesa di massima in favore della destalinizzazione ma rivolta a contenere le tendenze iconoclastiche13. Poco dopo rilasciò un’intervista alla rivista «Nuovi Argomenti», che vide la luce dopo la pubblicazione integrale del «rapporto segreto» sul «New York Times», il 4 giugno 195614. Togliatti sostenne che l’intervista era già pronta da prima ma il dato di fatto è che egli aveva temporeggiato e alimentato l’impressione di essere stato messo alle strette15. In tutti i casi, forní pubblicamente la propria versione. Criticò i limiti dell’impianto chrusceviano, esclusivamente incentrato sulla personalità di Stalin, e avanzò la tesi della «degenerazione burocratica» del sistema sovietico, evidentemente ispiratagli da Tito. Cosí intese porre rimedio alla fragilità concettuale delle tesi di Chruščëv e offrire una chiave di lettura piú coerente con la cultura marxista. In questa ottica l’intervista fu recepita dai dirigenti del Pci. Tutti riconobbero che Chruščëv poteva avere torto nel metodo ma ragione nella sostanza, persino Secchia e Scoccimarro. Soltanto pochi, in particolare due figure diverse come Amendola e Terracini, sottolinearono il carattere liberatorio della denuncia antistaliniana per la «via italiana» al socialismo16. La tesi della «degenerazione burocratica» provocò una replica dura e risentita dei sovietici. Inviati a Mosca, Pajetta e Negarville constatarono irritazione e refrattarietà ad ammettere una simile formula, che recuperava un’interpretazione dello stalinismo risalente a Trockij, anche se Chruščëv avrebbe sorvolato sulla questione17. Togliatti poteva comunque contare sul consenso del proprio gruppo dirigente, sebbene accordato con motivazioni molto diverse tra loro, che andavano dal senso di liberazione alla mera impossibilità di tacere dopo le rivelazioni chrusceviane18.
La questione piú significativa sollevata da Togliatti era però un’altra, che nella contingenza passò quasi sotto silenzio. Egli impiegò la formula del «policentrismo» per sostenere l’esigenza di una nuova articolazione del movimento comunista internazionale dopo la fine del Cominform. Tale nozione implicava la presa d’atto di una crescente complessità dell’ordine mondiale, non piú diviso in «due campi» ma in «tre gruppi» alla luce dei movimenti di liberazione coloniale, che riteneva avviati sulla strada del socialismo19. In questo modo, Togliatti alzava la posta in gioco circa le nuove forme dell’internazionalismo comunista. Chruščëv era pronto a riconoscere la pluralità delle vie nella «transizione» al socialismo, ma senza rinunciare al primato e alla centralità dell’Unione Sovietica. La formula togliattiana del «policentrismo» costituiva un’evidente alternativa, perché non rappresentava una semplice opzione regionalista e passava sotto silenzio il nuovo ruolo da assegnare a Mosca. Togliatti poneva in dubbio l’opportunità di una «guida unica» e sollecitava relazioni piú articolate nel «campo socialista» e nel movimento comunista internazionale. Il suo era anche un giudizio analitico sui cambiamenti generati dalla decolonizzazione. Egli vedeva bene l’emergere di una terza forza globale alla Conferenza afro-asiatica di Bandung, svoltasi l’anno precedente in Indonesia, che aveva registrato anche la partecipazione della Cina comunista e assunto l’aspetto di un momento simbolico dell’autodeterminazione e della sovranità antimperialistica20.
Al gruppo dirigente presentò gli interrogativi che sorgevano circa il rapporto tra il socialismo nel mondo e gli orientamenti anticoloniali di leader nazionali extraeuropei quali l’indiano Jawāharlāl Nehru, l’egiziano Nasser e l’indonesiano Akmed Sukarno21. Nel suo incontro con Tito, aveva manifestato la propria comprensione per la scelta iugoslava di evitare ogni partecipazione a nuovi centri organizzati del movimento comunista, che avrebbe diminuito il ruolo di Belgrado «nel movimento socialista e democratico internazionale»22. Egli adottò persino pubblicamente un lessico analogo a quello di Tito, usando la nozione di «coesistenza attiva» al Comitato centrale del 24 giugno e sostenendo come «le iniziative nuove atte a modificare il corso dei rapporti internazionali» e a «liquidare la guerra fredda» fossero interamente dovute «ai paesi socialisti o ai nuovi Stati usciti dal crollo del sistema coloniale»23. Paradossalmente, proprio la denuncia antistaliniana di Chruščëv, cosí lontana dalle sue corde, indusse Togliatti a recuperare il ruolo di stratega del comunismo internazionale, messo in ombra dal Cominform. Nella partita per la riorganizzazione del movimento comunista dopo Stalin, il leader italiano si proponeva come un protagonista, rivolto a interpretare l’ondata dei cambiamenti globali provocati dalla rivoluzione cinese e dal tramonto degli imperi europei, che rimandavano a un tempo storico piú lungo e profondo di quello della guerra fredda.
La drammatica crisi aperta dalle rivolte popolari in Polonia e in Ungheria modificò sensibilmente i termini della questione, cosí come Togliatti li aveva impostati nella sua intervista. La protesta operaia a Poznań nel giugno 1956 mostrò che le rivolte del 1953 non erano state un episodio legato alla morte di Stalin, ma l’annuncio di una frattura profonda. Il movimento popolare in Ungheria disvelò la dinamica transnazionale della destalinizzazione e il discredito degli establishment stalinisti dell’Europa orientale dopo la denuncia chrusceviana. Togliatti cambiò radicalmente di tono. Chiarí che la priorità era costituita dalla difesa senza riserve del «campo socialista», prima che dalla sua riforma, e impiegò un linguaggio riecheggiante i momenti piú oscuri della “guerra civile europea”. Qualunque orientamento politico, nella sua ottica, non poteva prescindere dalla stabilità dell’Europa centro-orientale, che vide minacciata dalla «presenza del nemico» dietro le proteste popolari. Seguendo questa logica, interpretò l’estremo tentativo riformatore di Imre Nagy, alla fine di ottobre, come un cedimento e un pericolo mortale. Il 30 ottobre 1956 inviò ai leader sovietici una durissima presa di posizione contro «l’orientamento reazionario» di Nagy, che avallava l’opportunità di intervenire con la forza in Ungheria, proprio mentre il gruppo dirigente sovietico era diviso e in bilico tra una scelta distensiva e una repressiva. Fece appello alla fermezza dinanzi al minaccioso evolvere degli eventi, che a suo giudizio mettevano a repentaglio l’unità della direzione del partito, sia in Italia, sia in Unione Sovietica. I sovietici risposero di condividere in pieno il giudizio pessimistico di Togliatti sulla situazione in Ungheria e lo rassicurarono circa l’unità della loro «direzione collegiale», tributandogli cosí un significativo riconoscimento24. In altre parole, Togliatti contribuí a marcare drasticamente i limiti della destalinizzazione. La sua cupa definizione di Nagy costituiva un eccesso di zelo e anche una implicita manifestazione di sfiducia verso la capacità della leadership di Chruščëv.
Togliatti usò l’espediente di schierarsi contro «due tendenze opposte», entrambe «errate», vale a dire i nostalgici dello stalinismo e la tesi che il Pci avrebbe dovuto sostenere l’insurrezione popolare. La sua frase chiave nella Direzione del 30 ottobre fu «si sta con la propria parte anche quando questa sbaglia» ma ammoní anche a «non mettersi sul terreno del liberalismo puro»25. Tra i dirigenti, soltanto Di Vittorio si espose, anche pubblicamente, rifiutando una simile logica e sostenendo che «non tutti i rivoltosi sono nemici del socialismo». Egli affermò che la democratizzazione era «una condizione di salvezza» del sistema socialista e vide nello scenario della repressione sovietica in Ungheria il capolinea della destalinizzazione come riforma politica26. La sua era una voce autorevole, come capo della Cgil e anche della Federazione sindacale mondiale, tanto da farlo apparire un’alternativa a Togliatti. Ma fu una voce isolata e destinata a rientrare nei ranghi sotto il ricatto della disciplina di partito. Gli altri dirigenti si allinearono alle posizioni di Togliatti, senza alcuna distinzione generazionale27. Molti si dissero sgomenti per la protesta popolare e per la mancanza di qualsiasi sostegno al primo intervento dell’Armata rossa, avvenuto pochi giorni prima. Mostrarono cosí come facesse loro velo un’idea mitologica delle «democrazie popolari» e quanto fosse profonda l’introiezione della guerra fredda. L’unità del gruppo dirigente fu cosí assicurata al momento dell’invasione e riuscí ad arginare il dissenso nel partito.
Tuttavia le defezioni furono notevoli, specie tra gli intellettuali, poco propensi a lasciarsi influenzare dal mito delle «democrazie popolari» e dai linguaggi manichei della «controrivoluzione» risalenti all’immaginario della “guerra civile europea”. Fu Antonio Giolitti a esprimere limpidamente il rigetto di quelle visioni nel discorso tenuto all’VIII Congresso del Pci, con l’autorevolezza che gli veniva dalla militanza antifascista nella Resistenza e dagli incarichi istituzionali e di partito ricoperti dopo la guerra. Egli pose in discussione la legittimità democratica e socialista del regime ungherese, mettendo a nudo la contraddizione vissuta dai comunisti italiani tra la rivendicazione del loro ruolo democratico in Italia e la difesa delle dittature comuniste nell’Europa centro-orientale28. Poco dopo abbandonò il partito tra molte polemiche. Anche Reale lasciò il Pci, dopo essersi defilato già da tempo a seguito della crisi di coscienza provocata in lui dalla violenza della sovietizzazione29. Togliatti ritenne che le defezioni fossero un prezzo da pagare dinanzi al pericolo di un effetto domino catastrofico sulle «democrazie popolari» e, di conseguenza, sui comunisti occidentali30. Come per gli altri dirigenti comunisti europei, la sua motivazione principale consisteva nello scongiurare la minaccia del collasso di un sistema di riferimento ritenuto necessario all’esistenza stessa del comunismo in Europa e nel mondo.
L’Europa centro-orientale socialista costituiva un simile fattore anche negli scenari del mondo policentrico. Togliatti lesse cosí la coincidenza tra la crisi di Suez e la crisi in Ungheria. Evocato da Chruščëv al momento della decisione fatale dell’invasione e impiegato strumentalmente nella polemica politica, quel nesso assunse poi un carattere simbolico e politico, perché collegava il tramonto degli imperi europei con la guerra fredda in Europa31. Nel suo rapporto all’VIII Congresso del Pci, l’8 dicembre 1956, Togliatti esordí denunciando l’intervento franco-britannico a Suez che a suo giudizio aveva portato il mondo «sull’orlo dell’abisso» di un «terzo conflitto mondiale». Collocò in tale contesto l’azione delle «forze controrivoluzionarie» in Ungheria, pur concedendo che i «sommovimenti di massa» avevano svelato una crisi del comunismo ungherese. Pose l’accento sugli «errati indirizzi politici» ma anche sulla «presenza del nemico», che senza l’intervento dell’Armata rossa avrebbe portato a un regime fascista. Mise al primo posto l’internazionalismo quale «dovere fondamentale» e presupposto di una «unità che si crei nella diversità e originalità delle singole esperienze […], prefigurazione della società internazionale per cui noi combattiamo»32. Queste parole non costituivano soltanto un esercizio retorico, ma la definizione di un principio irrinunciabile. La sua lettura era, come sempre, squisitamente politica. Egli non riteneva di rilevare mutamenti nel carattere aggressivo dell’imperialismo e anzi pensava che «si può mettergli una camicia di forza, cambiare questa sua natura non si può»33. La sua requisitoria contro le forze imperialiste, atlantiste e socialdemocratiche, che a suo giudizio cercavano soltanto di frenare i movimenti di liberazione e tornare alla guerra fredda, si svolse in questa ottica. Era un dato politico, cioè i rapporti di forza internazionali, che permetteva di immaginare il progresso socialista senza la guerra. Anche dopo la morte di Stalin, la visione togliattiana della «guerra di posizione» si fondava sull’idea che il capitalismo americano non costituisse un vettore di trasformazione globale, ma che gli Stati Uniti rappresentassero semmai l’erede ultimo di una civiltà in declino, seppure ancora capace di esprimere supremazia militare e geopolitica. Togliatti immaginava un futuro già incanalato su binari precisi, per quanto da conquistare, e non contemplava la possibilità della trasformazione realizzata dalle classi dirigenti, quella cioè che nel lessico gramsciano era la «rivoluzione passiva». Vale la pena di osservare che la sua lettura di Gramsci non dava conto delle riflessioni su «americanismo e fordismo», cruciali per la formazione di una simile categoria, e avrebbe continuato a non farlo anche negli anni a venire34.
Togliatti però non si muoveva esclusivamente nell’ottica dell’antagonismo bipolare. Affermò anzi che «il mondo è diventato policentrico», in quanto il crescente crollo del sistema coloniale offriva nuove possibilità di relazioni e creava una pluralità di soggetti. Egli indicò una volta di piú il «campo socialista» quale vettore del progresso umano, ma entro una visione che valorizzava il significato del mondo postcoloniale emergente e attraversava i confini del bipolarismo. In questo contesto, esplicitò un elemento preciso. Era stato «un limite», sostenne, presentare il modello della legalità, del «parlamentarismo» e del partito di massa come un fatto soltanto «nazionale» alla fine della Seconda guerra mondiale. Quel modello presentava sempre piú caratteri transnazionali, dato che l’affermazione stessa dei movimenti rivoluzionari e anticoloniali creava le condizioni per praticare una «via» democratica e pacifica35. In realtà, l’idea che il progetto del partito di massa non fosse circoscritto a una peculiarità nazionale era sempre stata sottesa al discorso di Togliatti dopo la fine della guerra. Il suo non si era mai configurato come un elogio dell’eccezionalità italiana, ma come un invito ad applicare coerentemente strategie e pratiche nate nel momento piú espansivo del movimento comunista, al fine di liquidarne il settarismo minoritario. Ora che la nascita di un «mondo policentrico» apriva scenari internazionalisti diversi, nel nuovo orizzonte di senso fornito dai movimenti di liberazione anticoloniale, egli rilanciò quella visione. Il suo obiettivo non era presentare l’Italia come un laboratorio politico, ma valorizzare l’esperienza dei comunisti italiani nella nuova prospettiva globale del comunismo internazionale.
Togliatti sapeva come lo spazio d’influenza di una simile visione fosse tutto da conquistare nelle relazioni con il «campo socialista» e nella sfera del comunismo occidentale. L’intesa con i comunisti francesi, potenzialmente strategica, era quasi inesistente, malgrado i tentativi di stabilire una collaborazione. Thorez rispedí al mittente la proposta di Togliatti di sottoscrivere una dichiarazione comune che, pur ribadendo l’appoggio all’intervento sovietico in Ungheria, riconoscesse il carattere popolare delle proteste, la mancata prevenzione della crisi da parte del partito ungherese e dei sovietici, l’esigenza di una lealtà non basata soltanto sulla solidarietà di classe ma sulla «coesistenza pacifica». Il capo della Sezione esteri del Pci, Spano, commentò dopo una missione a Parigi che «noi e i compagni francesi parliamo linguaggi diversi», ma avrebbe potuto estendere il giudizio a molti altri partiti comunisti a Est e a Ovest36. I francesi e i tedeschi orientali non risparmiarono critiche al gradualismo e al «pacifismo» degli italiani. L’episodio rivelava quanto fosse difficile fondare politicamente la nozione stessa di comunismo occidentale e distinguerla dai partiti-Stato dell’Est europeo. Tuttavia, la «via italiana» e le sue ambizioni piú generali furono saldamente stabilite. Togliatti completò i cambiamenti iniziati due anni prima emarginando esponenti della vecchia guardia quali Secchia e Scoccimarro, contrari alla destalinizzazione, e rimpiazzandola con una leva piú giovane che non era meno rappresentativa della Resistenza, specie nelle personalità di Amendola, Ingrao e Pajetta. In realtà, il cambiamento fu molto piú largo in tutti gli organismi dirigenti, tanto da segnare l’avvento di una «nuova generazione» che avrebbe governato il partito fino alla fine, in un difficile rapporto di continuità e discontinuità con l’eredità togliattiana37.
2. L’internazionalismo dopo Stalin.
Messi alle spalle gli shock dell’anno 1956, i dirigenti del Pci si rivolsero ai sovietici per definire un’agenda internazionale congrua con la «via italiana». Nel gennaio 1957, Longo e Spano incontrarono Chruščëv, Suslov e Boris Ponomarëv, capo del Dipartimento internazionale del Pcus, per discutere il progetto di instaurare «un sistema di incontri per lo scambio di opinioni ed esperienze» e di creare un «organo di stampa» internazionale dei partiti comunisti. Chruščëv li informò circa un possibile meeting dei paesi socialisti concordato con i cinesi e non escluse di organizzare in seguito un incontro dei partiti comunisti europei. Egli concordò sul fatto che non si trattava di riesumare il Comintern o il Cominform, ma occorreva ricordarsi che «i socialdemocratici hanno la loro Internazionale, le potenze occidentali hanno la Nato, la Seato, il Patto di Bagdad ecc.». Il leader sovietico e i comunisti italiani ritenevano che l’internazionalismo comunista avesse perso colpi rispetto al sistema internazionale occidentale e potesse recuperare soltanto creando nuove forme e regole del gioco. La richiesta degli italiani, fatta a nome di Togliatti, di discutere «le cause degli eventi ungheresi», e cioè «come questi siano stati possibili dopo dodici anni di esistenza del sistema di democrazia popolare», rimase però senza risposta. Chruščëv dichiarò che il gruppo dirigente sovietico non aveva «ancora affrontato il problema», ma si poteva dire che c’erano analogie tra Ungheria e Polonia, dove il partito «non aveva legami con le masse» e il suo gruppo dirigente «era composto in maggioranza da ebrei», un argomento antisemita già impiegato in passato da Gomułka. A una specifica domanda di Spano circa il ruolo degli iugoslavi nel suscitare la rivolta, il leader sovietico rispose affermativamente, mostrando la preoccupazione di Mosca per l’influenza di Belgrado sulle «democrazie popolari». Gli italiani ribadirono l’appoggio alla decisione di inviare l’Armata rossa a Budapest, ma non ebbero le risposte che avevano sollecitato38. Nel suo rapporto alla Direzione, Longo si limitò a riferire l’intenzione dei sovietici di «porre un freno alle forze centrifughe sollecitate dalla Iugoslavia»39.
L’obiettivo di contenere l’attività degli iugoslavi contro i blocchi della guerra fredda e di ricostruire un’architettura internazionale del movimento era condiviso tra Mosca e Pechino, sebbene con sfumature diverse. All’inizio del 1957, Zhou Enlai fece un lungo viaggio in Urss e nell’Europa orientale, durante il quale attaccò apertamente il «revisionismo» degli iugoslavi. Velatamente egli stigmatizzò anche l’incapacità mostrata dai sovietici di prevenire le crisi dei mesi precedenti. Mao fece trapelare il proprio giudizio prevalentemente negativo sulla destalinizzazione, che implicava una riserva sulla «coesistenza pacifica»40. I comunisti italiani condividevano le critiche alla mancata prevenzione della crisi ungherese, molto meno l’attacco al «revisionismo» che avrebbe potuto facilmente investirli, ancora meno le riserve sulla «coesistenza pacifica». Togliatti sapeva che la prima riunione del comunismo internazionale dopo la morte di Stalin doveva affrontare nodi intricati, a cominciare dal ruolo di «guida» piú o meno riconosciuto ai sovietici. Una riunione dei tredici partiti comunisti al potere si svolse a Mosca dal 14 al 16 novembre 1957, seguita da quella comprendente i delegati di circa sessanta partiti comunisti, compresi gli iugoslavi e gli italiani. La conferenza ristretta approvò una Dichiarazione che enunciava per la prima volta una dottrina del «campo socialista». Il documento si fondava sull’idea che l’espansione del socialismo e la decolonizzazione fossero processi convergenti nel provocare il declino dell’imperialismo. L’alternativa tra «guerra o coesistenza pacifica» costituiva il problema basilare della politica mondiale. Quanto alle relazioni nel «campo socialista», si seguiva la traccia della dichiarazione emanata a Mosca il 30 ottobre 1956, durante la crisi ungherese, circa i principî della sovranità e della non interferenza, che era stata subito dopo smentita dall’invasione sovietica. Ma si esaltava soprattutto il «fraterno aiuto reciproco» e la stretta unità degli Stati comunisti, che equivaleva a delineare una dottrina della sovranità limitata nel «campo socialista» europeo. Lo scenario di una «via pacifica» era bilanciato da quello della violenza rivoluzionaria, un punto sul quale si erano concentrate le proposte di redazione del testo avanzate da Mao41. La conferenza allargata emanò un «manifesto sulla pace» che conciliava retoricamente il principio della «coesistenza pacifica» con le multiformi prospettive del comunismo mondiale42.
Tutti i delegati riconobbero il «ruolo guida» dell’Unione Sovietica nel «campo socialista» e nel comunismo mondiale. Il piú esposto nell’appoggiare la formula fu Mao, i piú cauti Gomułka e Togliatti. Il 18 novembre, quest’ultimo dedicò gran parte del suo discorso a illustrare la «via italiana». Egli fece notare che dopo la fine del Comintern soltanto pochi partiti avevano saputo sfruttare la possibilità «di svilupparsi come grandi forze politiche di massa». Nell’Europa occidentale, in particolare, molti erano tornati «allo stato di piccole organizzazioni di propaganda». Togliatti ribadí cosí il progetto del partito di massa, che nell’esperienza italiana aveva mostrato le sue migliori potenzialità e che proponeva di riconoscere nelle sue implicazioni internazionali. Non esitò, tra l’altro, a predicare la possibilità di «riforme di struttura» del capitalismo, impiegando un linguaggio riformatore indigesto a buona parte dei delegati. In questo modo, forní una lezione valida per l’intero movimento43. La sua non era una proposta strategica che ambisse a elevare la «via italiana» a modello in un panorama estremamente differenziato, quanto una visione volta a consolidare le implicazioni della «coesistenza pacifica» in chiave internazionalista. Togliatti sapeva per esperienza che una forza come il comunismo italiano poteva esercitare la sua influenza a condizione di evitare contrapposizioni in termini di modelli. Nel suo resoconto a Roma, spiegò di aver inteso presentare «il profilo delle nostre posizioni politiche» e offrire «quel contributo che noi dovevamo dare al chiarimento dei problemi odierni del movimento»44. Togliatti non impiegò il termine di «policentrismo» coniato un anno prima. Alla luce delle fratture affiorate, egli aveva probabilmente accantonato gli scenari piú ambiziosi di un rapporto «flessibile» tra il centro moscovita e le sue periferie statuali e partitiche, che potevano persino mettere in questione la nozione di un «centro».
L’intervento di Mao delineò una visione largamente diversa da quella di Togliatti. Il leader cinese lanciò la celebre immagine di un mondo nel quale soffiavano «due venti», «il vento dell’Est», spinto dalle forze del socialismo e ormai piú forte del «vento dell’Ovest». Egli sostenne che la «controrivoluzione» in Ungheria era debellata, che l’Urss aveva impedito una «guerra di occupazione» a Suez, che il lancio dello Sputnik poneva l’intero Occidente in uno «stato di ansietà». Mao utilizzò i medesimi argomenti dei sovietici circa le prospettive dello sviluppo economico, che a suo dire avrebbero portato l’Urss a superare gli Stati Uniti e la Cina a raggiungere la Gran Bretagna in quindici anni. Tali considerazioni lo portarono a formulare la previsione che le potenze socialiste sarebbero state, dopo quel lasso di tempo, «invincibili» e a insistere sulla famosa metafora delle potenze imperialiste quali «tigri di carta», che non avrebbero piú potuto impedire l’avvento della «pace sulla terra». Tuttavia, richiamò anche l’attenzione dei presenti sullo «scenario peggiore», il rischio che una guerra termonucleare potesse ugualmente essere scatenata nel frattempo. In quel caso, dichiarò di essere meno pessimista di Nehru, rivelando di aver detto al leader indiano che non sarebbe stato annientato l’intero genere umano, ma soltanto un terzo o anche metà, e perciò l’imperialismo sarebbe stato «raso al suolo» e il «mondo intero» sarebbe divenuto socialista45. In sostanza, egli si presentò come il coerente interprete della dottrina leninista sulla guerra e dell’antimperialismo militante, usando toni molto diversi da quelli diplomatici che Zhou Enlai aveva presentato due anni prima a Bandung dinanzi ai rappresentanti dei paesi del Terzo Mondo. Pur sostenendo il ruolo guida di Mosca, contestò sottilmente la «coesistenza pacifica» quale piattaforma unitaria per il movimento comunista46. Il discorso di Mao fu particolarmente dissonante con gli interventi di alcuni leader comunisti europei, in particolare Togliatti. Questi aveva infatti dichiarato che una guerra termonucleare presentava il pericolo «della distruzione di tutti i valori della civiltà» ed esortato i comunisti a rilanciare il movimento per la pace, riconoscendo che esso si era indebolito, come si era visto «al tempo della guerra di Suez». La «coesistenza pacifica» e la decolonizzazione rischiavano cosí di dividere, invece che unificare, il comunismo internazionale. In altre parole, la polifonia immaginata da Togliatti si dimostrava impraticabile quanto piú le concezioni maoiste del nesso tra decolonizzazione e rivoluzione mondiale si fossero affermate.
Ciò nonostante, in apparenza il discorso di Mao non suscitò reazioni pubbliche o private, neppure da parte del leader italiano. Il prestigio del leader cinese era fuori discussione. Il suo discorso del 18 novembre occupò significativamente molto piú spazio di tutti gli altri negli appunti presi da Togliatti durante i lavori47. Ingrao ricorda che questi «fu avaro di commenti» ed evitò anche «qualche battuta di assenso formale»48. Nel suo resoconto al gruppo dirigente del Pci, Togliatti riferí di essersi incontrato due volte con Mao, «constatando il nostro accordo con tutte le questioni toccate»49. Anche nell’ipotesi che il leader italiano tenesse nascoste le proprie perplessità sugli accenti radicali di Mao, dobbiamo ritenere che le implicazioni del suo discorso non produssero strascichi significativi. Verosimilmente, Togliatti attribuiva quegli accenti alla divisione dei ruoli stabilitasi tra Urss e Cina in Europa e in Asia, ritenendo che comunque Mosca avrebbe esercitato un ruolo moderatore. Di certo, egli era pienamente consapevole della diversità di vedute con Mao. Prima dell’inizio della conferenza, durante le consultazioni sulla Dichiarazione, si era incontrato con il leader cinese e con Thorez, esprimendo la propria opzione per la via pacifica e dissentendo dall’enfasi sulla violenza rivoluzionaria50.
Le tensioni piú visibili alla conferenza furono provocate dall’attacco del delegato francese Jacques Duclos a Togliatti. Sentendosi bersaglio dell’emendamento degli italiani rivolto a denunciare il «settarismo» come un vizio che aveva impedito a molti partiti di acquisire basi di massa, i francesi dettero vita a un autentico incidente opponendosi all’idea di lasciare liberi i partiti circa le modalità di adesione al documento conclusivo della conferenza51. La questione venne appianata con l’intervento dei sovietici, che confessarono ai delegati italiani di non essere stati messi a conoscenza delle intenzioni dei francesi52. La questione del partito di massa che si celava dietro il codice cifrato del «settarismo» non era un aspetto marginale e risaliva ai primi anni del dopoguerra. Con le sue implicazioni in termini di alleanze sociali, ibridazione culturale, relativa tolleranza ideologica essa confermava una diversità di cultura politica tra i gruppi dirigenti italiani e francesi, che si riproponeva malgrado il comune sostegno all’intervento dell’Armata rossa in Ungheria. Ma le critiche dei francesi non erano affatto isolate. Stando al ricordo di Vidali, l’elogio del partito di massa fatto da Togliatti suscitò reazioni gelide, senza contare l’impressione diffusa che i comunisti italiani pretendessero di «dare lezioni a tutti»53.
Tuttavia il centro di gravità della Conferenza di Mosca non fu l’alternativa tra centralismo e policentrismo, ma quella tra «coesistenza pacifica» e rivoluzione mondiale. Sia i sovietici che i cinesi si mostravano indifferenti, se non anche ostili, a ogni idea di un’articolazione piú flessibile delle relazioni comuniste. Sotto questo profilo, essi condividevano la medesima cultura politica, modalità di comando, istituzioni e pratiche totalitarie. Ma le loro visioni e i loro linguaggi divergevano quanto al significato da attribuire al ruolo globale del comunismo. L’alternativa tra coesistenza e rivoluzione venne fermamente negata dai sovietici, che non vedevano opposizione tra i due termini, ma profilata dai cinesi, che invece alludevano al problema della contraddizione potenziale tra gli interessi dello Stato sovietico e il ruolo antimperialista del movimento. I due pilastri del comunismo mondiale si identificavano tendenzialmente in scenari divergenti della rivoluzione mondiale e tendevano a imporli generando nei fatti un dualismo. Togliatti si pronunciò senza riserve per la «coesistenza pacifica». Proprio l’esigenza di una scelta cosí netta e la percezione di una possibile linea di frattura del movimento generata dalla decolonizzazione, non meno che dalla destalinizzazione, costituí un motivo in piú per non insistere sul tema del policentrismo.
Le visioni dell’internazionalismo comunista che si confrontarono a Mosca nel novembre 1957 rimasero sostanzialmente inalterate, nei loro termini principali, nei tre anni successivi. I sovietici ritennero di aver fissato un punto di equilibrio, ma il consenso raggiunto sul piano formale era fragile e fittizio. Anche Togliatti pensava che il compromesso raggiunto alla conferenza fosse sufficiente a configurare una nuova stagione del comunismo internazionale, includendovi la legittimazione ottenuta dalla «via italiana». Egli archiviò il dissidio con Duclos in modo apparentemente agevole. In realtà, l’episodio lasciò uno strascico e venne usato come un appiglio dalla «vecchia guardia», messa in gran parte ai margini, per trovare una sponda a Mosca e rientrare in gioco. Nell’estate 1958, Robotti inoltrò al Dipartimento internazionale del Pcus un memorandum su incarico di D’Onofrio, che costituiva un atto di accusa contro la nuova generazione del Pci, sottoscritto da Secchia, Colombi e Vidali. L’accusa rivolta soprattutto ad Amendola e Pajetta, ma anche a Ingrao, Alicata, Bufalini e Berlinguer, era di sopravvalutare l’attività parlamentare a scapito dell’organizzazione dei quadri e di inoculare nel Pci una forma di «revisionismo» influenzato dalla Iugoslavia, che avrebbe portato al distacco dall’Unione Sovietica. La critica si indirizzava piú cautamente allo stesso Togliatti e all’intervista a «Nuovi Argomenti», che aveva provocato un raffreddamento delle relazioni con i sovietici non ancora recuperato. Gli autori non risparmiavano Nilde Iotti, giudicata responsabile di un’influenza negativa su Togliatti in quanto assicurava il legame con i «giovani». Ciò poteva aprire la strada, a loro dire, a una rimozione dello stesso Togliatti. Il partito sarebbe stato cosí formalmente guidato da una diarchia composta da Longo e Amendola, un espediente per far transitare la direzione effettiva nelle mani di quest’ultimo. Il tentativo dei firmatari di trovare udienza nel Pcus cadde evidentemente nel vuoto dopo i colloqui a Mosca di Longo e Amendola nel settembre 195854. Il documento costituisce perciò soprattutto testimonianza dell’ultimo rigurgito dei dirigenti di stretta osservanza stalinista nel partito italiano, ma le argomentazioni circa le ambizioni e la scarsa lealtà della nuova generazione lasciarono qualche traccia al Cremlino, dove diversi gradi di diffidenza rimasero in vita verso Amendola e persino verso Togliatti negli anni a venire. Il documento mostra anche come tra i comunisti italiani il tema del «revisionismo» iugoslavo oscurasse la percezione delle tensioni crescenti tra Unione Sovietica e Cina, nate sul terreno della destalinizzazione e della «coesistenza pacifica».
La gravità della disputa risultò evidente soltanto in una riunione riservata tenuta a Bucarest nel giugno 1960, alla quale era presente Colombi55. In quella data, durante un suo viaggio in Unione Sovietica, Togliatti redasse una nota che compendiava i principali punti di dissidio tra Mosca e Pechino, ormai affiorati sul tema della distensione con gli Stati Uniti e attorno alla scelta maoista di lanciare il «grande balzo in avanti», che aveva riesumato il teleologismo e la violenza di massa della “rivoluzione dall’alto” staliniana di trent’anni prima con risultati catastrofici. Riferendosi a dichiarazioni di leader cinesi, in particolare Liu Shaoqui e Deng Xiaoping, l’appunto menzionava la contrapposizione tra «coesistenza pacifica» e lotte di liberazione anticoloniale, la questione dell’inevitabilità o meno della guerra, le vie di transizione pacifica o violenta al socialismo56. La preparazione della seconda conferenza mondiale non serví a trovare un compromesso. In una riunione con i sovietici del settembre 1960, Berlinguer annotò che le divergenze con i cinesi sulla «via pacifica» erano nate «sin dall’inizio» ed erano quindi difficilmente negoziabili57. Cosí la Conferenza mondiale che riuní ottantuno partiti comunisti a Mosca nel novembre-dicembre 1960 registrò l’apogeo della diffusione dei partiti comunisti nel mondo, legato alla nascita dei nuovi Stati-nazione postcoloniali, ma anche una frattura del movimento destinata a rivelarsi fatale.
La delegazione italiana guidata da Longo si adoperò per impedire che si formassero due schieramenti contrapposti e dichiarò di opporsi ai tentativi di trasformare il dissenso politico o ideologico in uno scontro «riguardante le relazioni statali tra alcuni paesi socialisti». Il messaggio a entrambe le parti in conflitto era che non potesse piú esistere «un’unica leadership mondiale dell’intero movimento comunista». Questa scelta di metodo si legava, ancora una volta, a una presa di posizione sul tema della guerra e della pace. Seguendo l’ispirazione anticatastrofista di Togliatti, ribadita qualche mese prima a Mosca, Longo affermò che una guerra atomica avrebbe distrutto «le stesse basi materiali della civiltà moderna» e che la rivoluzione non aveva bisogno di aprirsi la strada «usando bombe termonucleari, macerie e lutti senza fine»58. Gli sforzi di mediazione in nome dell’unità, compiuti dai comunisti italiani, mostrarono subito di essere difficoltosi. I dissidi emersi tra Chruščëv e Deng Xiaoping rivelavano la competizione tra due leadership alternative. I delegati italiani presero posizione contro il dirigente cinese insistendo sulla «via pacifica» al socialismo59. La conferenza si concluse con la generica riaffermazione della «coesistenza pacifica» e il gruppo dirigente del Pci recepí questo elemento, passando sotto silenzio il fatto che lo scontro tra sovietici e cinesi paralizzava qualsiasi presa di posizione piú precisa60.
Per un anno circa, la crisi della distensione in Europa e il rilancio della destalinizzazione in Unione Sovietica costituirono due seri diversivi rispetto alla questione cinese. Nell’agosto 1961 i comunisti italiani si allinearono senza riserve alla decisione di costruire il muro di Berlino, anche in nome dell’immagine antifascista che assegnavano alla Rdt con un’enfasi specifica rispetto alle altre «democrazie popolari». Togliatti presentò il muro come una misura inevitabile provocata dalle politiche occidentali61. Egli operò una distinzione netta tra la conferma della «coesistenza pacifica» e il rilancio della denuncia contro Stalin, compiute da Chruščëv al XXII Congresso del Pcus. La sua reazione alla seconda denuncia antistaliniana di Chruščëv, questa volta pubblica, fu di estrema irritazione, come è documentato nel diario di Barca. Chiese persino spiegazioni a Suslov, esprimendo meraviglia per ciò che gli sembrava una specie di «processo giudiziario»62. Nella relazione al Comitato centrale del 10 novembre 1961 si limitò a rilevare che la rinnovata denuncia antistaliniana non aggiungeva molto al «rapporto segreto», ricordandone anche i limiti segnalati nell’intervista a «Nuovi Argomenti»63. A cinque anni dallo shock del 1956, Togliatti non aveva cambiato idea. La sua visione dell’Europa centro-orientale restava ancorata alla convinzione che la destalinizzazione chrusceviana presentasse rischi troppo alti di destabilizzazione e che non fosse un vettore di cambiamento positivo. Questa idea conservatrice lo aveva portato a sottoscrivere gli atti peggiori della normalizzazione in Ungheria, a cominciare dalla condanna a morte di Nagy, lasciando senza risposta la drammatica lettera che il leader riformatore ungherese aveva indirizzato a lui e ad altri leader come Tito e Gomułka64.
Togliatti però sottovalutava le conseguenze del suo atteggiamento nella generazione piú giovane. Vari esponenti del gruppo dirigente sollevarono perplessità e critiche nei suoi confronti. Ancora una volta, come nel 1956, Amendola ricoprí il ruolo di punta. Egli affermò il «valore liberatore» della denuncia di Chruščëv, il rischio di pagare un prezzo troppo alto al rituale della «fittizia unanimità» stabilita nelle due conferenze del 1957 e del 1960 e l’esigenza di dare vita a un internazionalismo «non di parata», liberandosi della «camicia di forza» costituita dal sistema di relazioni esistente nel mondo comunista. A suo giudizio, le questioni principali poste dal Pci nel 1956 erano state abbandonate o congelate («sono rimaste chiuse in frigidaire»), in particolare il tema del policentrismo, «il carattere delle vie nazionali» anche nei paesi dove «non c’è partito comunista», l’analisi delle trasformazioni del capitalismo mondiale. Il nervo piú sensibile toccato da Amendola fu quello dell’autocensura esercitata nei dibattiti internazionali come all’interno dei singoli partiti. Nel caso del Pci, puntò il dito sulla frattura tra il linguaggio nazionale, «un patrimonio di cultura politica italiana», e il linguaggio internazionalista, che si stentava a «tradurre in termini italiani»65. In sostanza, la figura piú rilevante del «comunismo nazionale» invocò una ridefinizione della condotta internazionale del partito, criticò Togliatti per aver mancato di sviluppare le premesse della sua stessa visione e sostenne che le implicazioni della destalinizzazione riguardavano anche il comunismo italiano e la sua capacità di modificarsi nel tempo. Considerazioni analoghe vennero presentate soprattutto da Alicata e, piú moderatamente, da Pajetta e Giorgio Napolitano.
Togliatti censurò con durezza le voci critiche. Fece ricorso all’arma della memoria per affermare la propria autorità e, insieme, il senso di un’epoca che riteneva non ancora esaurita. Rievocò le «riserve» che egli stesso si era trovato ad avanzare sulla concezione cominternista dell’unità come obbedienza, in particolare nel 1929, per richiamare tutti alla «sostanza delle cose», vale a dire «a quello che era la società socialista che si stava costruendo allora nel mondo». Una priorità che, a suo avviso, non aveva perso nulla della sua validità e restava alla base dell’identità di tutti i comunisti. Cosí egli ribadí una narrazione che rimuoveva la memoria dei crimini di Stalin e limitava la riflessione critica sulla sua eredità, destinata a gravare molto a lungo sul senso comune dei comunisti italiani ostacolando una presa di coscienza del ruolo della violenza nell’esperienza sovietica. Riconobbe invece legittimo il «malcontento» per la situazione del movimento internazionale, specie in Europa occidentale, ma si limitò a contrapporre l’«arretratezza» del movimento comunista del mondo capitalistico alla crescita del movimento fuori d’Europa. Professò fiducia per il futuro, dichiarando «esagerato» vedere la polemica cinese contro i sovietici e i comunisti europei come una «frattura». In sostanza, egli non si lasciò chiudere in un angolo e rammentò a tutti il carattere imprescindibile dell’appartenenza internazionale, mettendo in guardia contro il rischio di attribuire all’esperienza italiana un ruolo ipertrofico e velleitario66.
Sia Togliatti che Amendola si collocavano nella tradizione del comunismo italiano come componente attiva e pensante del comunismo internazionale, ma mostravano anche una seria divergenza attorno alla credibilità e al futuro del movimento. La contestazione di Amendola toccava infatti un nodo basilare di cultura politica. La rottura dell’unanimismo tra i partiti comunisti, e nei partiti stessi, implicava un cambiamento di pelle e una nuova visione critica che avrebbe potuto orientare l’internazionalismo dei comunisti, nella misura del possibile, verso la sinistra occidentale. Togliatti eluse i motivi sottostanti la divisione del gruppo dirigente. La sua reazione confermò una visione conservatrice della destalinizzazione, fondata sull’idea che i sistemi di tipo sovietico sarebbero stati in grado nel tempo di voltare pagina rispetto agli ordinamenti del passato staliniano, visti quali semplici «degenerazioni» di una mitica età dell’oro leninista. La bussola di Togliatti era il carattere irrinunciabile dell’«unità» del movimento comunista e il legame internazionale dei comunisti italiani. Insistere sulle proprie visioni aveva senso fin quando esse fossero state recepite a Mosca e altrove, molto meno qualora avesse soltanto portato a isolare il gruppo dirigente e indebolirlo senza alternative praticabili a portata di mano. Ma l’appello unitario rappresentava anche un modo per ignorare il tramonto della ragion d’essere della tradizione internazionalista che dirigenti piú giovani di lui cominciavano ad avvertire. Questo secondo dilemma non fu raccolto né elaborato. Il problema dei «linguaggi», indicato da Amendola alla luce della frattura tra gli idiomi nazionali e quelli internazionali, presentava una dimensione non soltanto italiana e rivelava già allora un principio di disgregazione dei tessuti connettivi del movimento comunista67.
A Longo toccò il compito ingrato di riferire ai sovietici la prima discussione critica nei loro confronti svoltasi in un organismo dirigente del Pci dagli anni Venti. Egli non riportò soltanto gli interrogativi di Amendola e di Alicata sulle denunce antistaliniane, ma presentò i due dirigenti come difensori del «policentrismo», diffidenti verso l’atteggiamento di Mosca sulle «vie nazionali». Dichiarò la propria adesione alle posizioni espresse da Togliatti, specie circa il giudizio positivo sulle conferenze mondiali del 1957 e del 1960. Longo intese le conclusioni di Togliatti come la riaffermazione di un principio di «unità nella diversità» distinto dalle idee ispirate al «policentrismo». Il suo approccio compiaceva i sovietici ma segnalava anche una vera e propria aporia nel gruppo dirigente italiano circa il significato dei due termini. Ciò non gli risparmiò il fuoco di fila di Suslov e Ponomarëv, che ritenevano le critiche all’Unione Sovietica un delitto di lesa maestà. Alludendo ai cinesi, Frol Kozlov, membro del Presidium, affermò che il «policentrismo» avrebbe favorito coloro che nel 1960 avevano difeso «l’attività frazionistica nel movimento comunista»68. In Direzione, Longo riportò il disappunto di Mosca per le posizioni «antisovietiche» di alcuni dirigenti del Pci e il sostegno a Togliatti, malgrado il dissenso sulla tesi della «degenerazione burocratica». Questi dichiarò che il dibattito aveva danneggiato il prestigio del partito nel movimento internazionale, basato «sul metodo di non ferire le sensibilità dei partiti fratelli» e in particolare quelle dei sovietici che stavano fronteggiando «il grande problema cinese»69.
Togliatti approfittò subito del sostegno sovietico per tentare di esercitare la propria influenza sulla questione cinese. Il 12 gennaio 1962 scrisse una lettera al Pcus per esprimere dubbi circa la proposta di richiamare Pechino all’ordine con un documento firmato dai partiti comunisti che avevano approvato la risoluzione del 1960, perché i cinesi lo avrebbero interpretato come «l’inizio di una lotta contro di loro». Egli espresse un giudizio negativo anche sulla proposta di convocare una nuova conferenza del comunismo mondiale, che avrebbe sortito l’effetto contrario alla composizione dei dissidi70. Il problema del senso da dare alla nozione dell’«unità» comunista restava però aperto. Pochi mesi dopo, Amendola rivendicò con l’ambasciatore sovietico la propria critica del «centralismo democratico» e dichiarò che era errato impiegare «i metodi diplomatici» nelle relazioni tra i partiti, quanto meno quelli che non erano al potere. Soltanto cosí si poteva sperare di risollevare il movimento comunista e operaio nell’Europa occidentale, che era privo d’influenza sulla realtà del Mercato comune. Invece i comunisti occidentali non avevano neppure un dialogo, a suo giudizio per colpa del Pcf. Pur dichiarandosi «un discepolo di Thorez» e ricordando gli stretti legami storici tra comunisti italiani e francesi, riteneva incomprensibile la scelta di questi ultimi di evitare contatti con il Pci71. L’imperativo dell’unità, il suo controverso rapporto con la nozione del policentrismo e l’inconsistenza del comunismo occidentale come attore in commedia dovevano occupare un posto centrale nell’attività di Togliatti negli ultimi due anni della sua vita.
3. La «coesistenza pacifica», l’interesse nazionale e la decolonizzazione.
Nel 1956 il Pci aveva mostrato un duplice volto nella politica nazionale. Da un lato, il partito della «coesistenza pacifica», che faceva da sponda alla politica estera sovietica come era sempre accaduto in passato, ma assecondava anche un cambiamento dell’ordine bipolare poststaliniano favorevole alla creazione di «vie nazionali» per i comunisti occidentali. Dall’altro, il partito della guerra fredda, che dopo la caduta del mito di Stalin e l’invasione sovietica dell’Ungheria mirava a cementare la propria trincea politica e sociale nella prospettiva dell’assedio reciproco tra i due blocchi italiani. I due elementi dovevano convivere e integrarsi. La perdita del monopolio del marxismo fu compensata dal monopolio sul fronte dell’opposizione al governo dopo la rottura con i socialisti, che nelle condizioni del bipolarismo antagonistico assicurava la difesa delle basi popolari del partito. Togliatti fece ricorso alla risorsa simbolica dell’antifascismo, senza mai presentare il Pci come una forza di opposizione sistemica. Egli impiegò un linguaggio rivolto molto piú alla nazione che non alla «comunità immaginata» dei comunisti, attingendo solo indirettamente al mito sovietico. Antepose il discorso sull’antifascismo come cultura politica alla mitologia della modernità economica socialista, evitando di farsi ingabbiare nella promessa chrusceviana del comunismo a portata di mano, che alla fine del decennio era divenuta il segno principale della propaganda sovietica insieme alla sfida tecnologica e alla conquista dello spazio72. La sua tesi che la «democrazia antifascista» fosse un progetto costruito sin dagli anni Trenta serviva a velare la realtà autoritaria delle «democrazie popolari», ma anche a presentare i comunisti come il nucleo essenziale di una classe dirigente di ricambio della Repubblica73. Il suo fondamento era una narrazione nazionale (la «necessità» storica del movimento operaio), vista nell’ottica gramsciana di «un movimento che esce dal profondo dell’attuale ordinamento della società», inserita in un vettore globale (il progresso inarrestabile del socialismo e del suo campo di forze su scala mondiale)74. Il canone gramsciano continuava cosí a intrecciarsi con la visione marxista-leninista del socialismo trionfante. La rivendicazione dei legami internazionali del comunismo italiano poteva avvalersi della constatazione che nel mondo contemporaneo ogni movimento politico presentava «una tendenza a stabilire contatti al di fuori del proprio paese»75.
La «coesistenza pacifica» definí la visione dell’internazionalismo e la nozione dell’interesse nazionale per i comunisti italiani. Togliatti scommise sul fatto che la distensione internazionale potesse bilanciare l’isolamento del Pci nella politica nazionale, accentuatosi dopo l’Ungheria. La politica estera dei successori di Stalin stabilizzava il bipolarismo e ne stemperava i tratti piú antinomici, presentando ai comunisti l’occasione per emanciparsi dal ruolo di un mero avamposto in campo avverso. Gli stessi legami internazionali che avevano fortemente contribuito a creare la guerra fredda interna e la spaccatura della società italiana in due blocchi sembravano ora poter fornire una risorsa politica. Il Pci si pronunciò contro i Trattati di Roma, tenendo fermo il giudizio negativo sul Mercato comune come dominio del capitalismo monopolistico e condividendo con Mosca la valutazione dell’integrazione europea quale appendice dell’Alleanza atlantica76. Invocò però concreti passi ispirati tanto alla «coesistenza pacifica» quanto alla «vocazione mediterranea» dell’Italia, che prestavano il fianco alla critica di riproporre un neutralismo irrealizzabile o dannoso, ma toccavano comunque un nodo politico dopo oltre un decennio di sterile propaganda contro l’atlantismo. Tra le eredità di De Gasperi figurava anche l’idea che l’Italia dovesse svolgere la funzione di un tramite tra l’Europa e il Mediterraneo, supportando la fine del potere imperiale nella regione, ma le coordinate e le modalità di una simile ispirazione restavano vaghe77. Dal 1956 in avanti, Togliatti incalzò le forze di governo sfidandole sul duplice terreno della distensione e della decolonizzazione. I comunisti italiani svilupparono l’idea di costruire un ponte tra le due Europe e tra l’Europa meridionale e l’Africa del Nord, partecipando dei nuovi legami tra il «campo socialista» e il mondo arabo. La primogenitura dell’attenzione verso la decolonizzazione era contesa loro da personalità e intellettuali in ambienti minoritari di matrice cattolica o socialista. Tra questi, in particolare, si distinsero Giorgio La Pira e Lelio Basso78. Nenni e il Psi operarono una distinzione tra Budapest e Suez, in polemica con le tendenze giustificatorie dei comunisti, e moderarono le proprie posizioni antimperialiste accostandosi alla sfera di governo79. I comunisti potevano contare sulla potenza dell’Unione Sovietica, che prometteva un disegno egemonico verso il mondo postcoloniale dopo la crisi di Suez e simboleggiava un modello di sviluppo alternativo al capitalismo occidentale80. Quel nesso internazionale li distinse dalle nascenti tendenze terzomondiste nell’opinione della sinistra e conferí loro un’influenza potenziale su alcune scelte di fondo della politica nazionale. Tra i partiti comunisti occidentali, soltanto il Pci era determinato a sfruttare le condizioni per esercitare una simile influenza.
Togliatti e il suo gruppo dirigente delinearono prospettive che facevano difetto alle forze di governo e alla diplomazia italiane. Queste si mostravano prevalentemente ostili alla distensione, malgrado vaghe professioni di dialogo tra i due blocchi, e ambigue su questioni cruciali quali la crisi di Suez, che si cercò soprattutto di sfruttare opportunisticamente in chiave antifrancese e antibritannica nelle relazioni con Washington. La Dc manteneva la priorità della guerra fredda interna e si limitò a ritagliare un ruolo marginale per l’Italia nella politica occidentale, volto a sostenere accordi economici bilaterali e ad assecondare l’iniziativa delle classi dirigenti economiche, anzitutto la diplomazia personale di Enrico Mattei81. Togliatti legò l’idea della «coesistenza pacifica» all’evoluzione dell’ordine mondiale in una dimensione non piú meramente bipolare. A suo giudizio, l’emergere di «un sistema di Stati nuovi» a Bandung non configurava semplicemente nuove potenze ma «nuove civiltà» caratterizzate dalla «difesa dell’indipendenza contro l’imperialismo» e dalla ricerca di proprie strade sociali. In una implicita rivendicazione dei tratti cosmopoliti della propria biografia, che ben poche personalità potevano vantare nel Parlamento italiano, menzionò il leader indiano Nehru quale figura emblematica del cambiamento epocale in atto, ricordando di averlo incontrato a Barcellona nel 1938, nel pieno della guerra civile spagnola. Alluse cosí a intersezioni che congiungevano l’internazionalismo comunista e l’antifascismo europeo con le traiettorie delle lotte anticoloniali, citando il ricordo fissato da Nehru nella sua autobiografia, di aver visitato un luogo dove si percepiva «la luce del coraggio», la determinazione «nel fare qualcosa che ne valesse la pena»82.
Togliatti formulò una linea fondata su due elementi: la tesi che le concezioni legate alla «contrapposizione dei blocchi» non fossero piú corrispondenti «alla realtà odierna delle cose» e l’obiettivo di fare del Mediterraneo «una zona di pace»83. Cosí stabilí un nesso tra gli interessi nazionali, le possibilità di un nuovo rapporto tra Est e Ovest e gli scenari postcoloniali. In particolare, invocò «una svolta radicale e chiara» della politica italiana su quella che definiva «una guerra di sterminio» francese in Algeria84. Il suo discorso pubblico cadde efficacemente sui limiti della tradizionale visione anticomunista dinanzi alla portata dei cambiamenti in Asia e in Africa, che registravano la nascita di attori difficilmente riducibili alla contrapposizione tra «mondo libero» e totalitarismo. Ciò consentiva di mettere in questione gli orientamenti della politica estera italiana. «Rinascita» commentò la Conferenza afro-asiatica svoltasi al Cairo alla fine del 1957 facendo notare la partecipazione dei paesi socialisti e stigmatizzò la «cortina del silenzio» calata sulla politica dell’Italia nel Mediterraneo85. Secondo Togliatti, la solidarietà del mondo socialista verso i movimenti d’indipendenza anticoloniale era «un processo che non si arresta» perché basato su «una coincidenza degli obiettivi» di liberazione86.
L’amministrazione Eisenhower si mostrava ossessionata dalla presenza sovietica in Medio Oriente e oscillante tra l’eredità della militarizzazione bipolare e le sfide dell’indipendenza nazionale e dello sviluppo nel Terzo Mondo. Ciò forní rinnovati motivi all’antiamericanismo comunista, combinati con la denuncia del razzismo e della negazione dei diritti civili negli Stati Uniti87. Nella politica europea stentava a emergere una chiara visione anticoloniale e una riflessione sugli scenari postcoloniali del sottosviluppo, non soltanto tra i democristiani ma anche tra i socialisti. Questi ultimi, soprattutto i laburisti, avevano elaborato progetti di «sviluppo coloniale» con l’obiettivo di ridurre povertà e ineguaglianze, ma respingevano l’idea che le indipendenze nazionali costituissero la priorità ovunque. La determinazione dei socialisti francesi a conservare il legame nazionale e coloniale con l’Algeria costituiva un problema irrisolvibile nell’Internazionale socialista, malgrado le crescenti prese di posizione contrarie alla politica di Guy Mollet88. Il collasso della Quarta Repubblica in Francia e l’avvento del generale De Gaulle furono per il Pci l’occasione per riproporre su scala europea il tema del «crepuscolo del colonialismo» e l’idea della convergenza tra socialismo e decolonizzazione89.
Togliatti ebbe buon gioco nel ribadire le ragioni della distensione e i suoi intrecci con la decolonizzazione, anzitutto nell’Africa del Nord e in Medio Oriente, dinanzi agli opportunismi delle classi dirigenti italiane e alla sordità del papato, che cercava di ritagliarsi un ruolo di mediazione nei conflitti coloniali90. Un simile approccio metteva a nudo le contraddizioni del «neoatlantismo» di Amintore Fanfani, rivolto a rivendicare un vago ruolo italiano di mediazione nel Mediterraneo, d’intesa con Washington, che aveva soprattutto obiettivi di politica interna e creava divisioni all’interno della stessa Dc91. Togliatti invitò i governanti italiani a comprendere meglio «il processo multiforme e complesso» della formazione di nuovi Stati in Asia e in Africa e definí la distensione una «nuova struttura del mondo»92. Fece cosí leva sulla contraddizione della classe dirigente cattolica tra la propensione a pensare il ruolo italiano nella politica internazionale in una chiave autonoma e la subordinazione ai vincoli della guerra fredda occidentale93. Nello stesso tempo, l’Italia occupava una posizione privilegiata nella prospettiva di una distensione tra Est e Ovest, anche perché Mosca mostrava attenzione al ruolo del Vaticano e al suo rilievo per alcuni paesi del blocco sovietico, in particolare la Polonia, e all’interno dell’Unione Sovietica, come in Lituania94.
La visita del presidente Gronchi a Mosca nel 1960, decisa nel pieno di aspre polemiche circa il ruolo dell’Italia nella distensione e risoltasi in un modo a dir poco contraddittorio, portò acqua al mulino del Pci. In una nota del suo diario, all’inizio di gennaio, l’ambasciatore Luca Pietromarchi scriveva: «Non v’è dubbio che Togliatti abbia saputo accortamente approfittare degli errori del governo», che invece di lanciare una «politica di avvicinamento» all’Unione Sovietica dava mostra di subirla, lasciando ai comunisti «il vanto di averla imposta a un governo riluttante»95. In effetti, nella relazione tenuta al IX Congresso del Pci, Togliatti aveva enfatizzato le novità generate dalla distensione nei rapporti bipolari, compiacendosi per l’annunciato viaggio di Gronchi, e dichiarato che i comunisti avevano il dovere di contribuire alla formazione di una politica dell’Italia diversa da quella della Germania federale di Adenauer in Europa e dal «militarismo francese» nel Mediterraneo96. Pur nella retorica sulla «superiorità» del sistema socialista e nella durezza dei giudizi su De Gaulle, la sua linea di argomentazione sollevava questioni politiche nazionali e corrispondeva a sviluppi concreti nell’attività e nelle pratiche transnazionali del Pci. Per contro, la visita di Gronchi mostrò tutte le incongruenze degli orientamenti di Roma ed ebbe un apprezzamento molto tiepido a Mosca, dove si rilevò il maldestro tentativo del presidente italiano di definire la presenza dei partiti comunisti in Europa come un ostacolo alla distensione97. Anche Fanfani tenne la medesima linea nei suoi incontri con i sovietici del luglio 1961, proponendo uno scambio tra lo sviluppo delle relazioni diplomatiche e la cessazione dell’aiuto sovietico al Pci, che era chiaramente inaccettabile per Mosca98. Ciò nonostante, in sede riservata Togliatti giudicò positivamente il viaggio di Fanfani. A suo parere, il Pci non aveva interesse alla propaganda ma a fare in modo che «se verrà ottenuto un minimo per la salvezza della pace, questo minimo non vada disperso, non sia distrutto dalla mobilitazione della canea atlantico-americana»99. Le aperture dell’amministrazione Kennedy, la nascita del centro-sinistra e gli auspici universalisti del tardo pontificato di Giovanni XXIII non dovevano tuttavia indurre una chiara revisione della politica estera dell’Italia.
Togliatti costruí la propria linea verso il centro-sinistra soprattutto sul terreno internazionale, nel tentativo di sottrarre il Pci al ruolo di mera opposizione frontale100. Tale approccio si legò alla parola d’ordine delle «riforme di struttura» del capitalismo, che aveva la funzione di confrontarsi con i progetti riformatori dei socialisti senza cedimenti identitari. La promessa di riforme strutturali teneva opportunamente separati il livello della cultura politica, inserita nella tradizione rivoluzionaria e antisocialdemocratica, dalle pratiche riformatrici locali, diffuse ed efficaci nelle «regioni rosse» del paese. L’impostazione togliattiana serviva anche a contenere le divisioni culturali nel partito tra letture diverse dei processi di modernizzazione nel paese e dei loro nessi con le interdipendenze occidentali. La lettura del «miracolo economico» italiano creava divisioni serie tra chi, come Amendola, riteneva che non alterasse la tradizionale categoria dell’arretratezza del capitalismo italiano e chi, come Bruno Trentin e Lucio Magri, avanzava la nozione di «neocapitalismo» e lo scenario della società dei consumi101. Tali interrogativi rimandavano anche alla capacità o meno di leggere le trasformazioni dell’Occidente europeo sotto il segno dell’americanizzazione, che investiva le basi popolari del partito, e l’esercizio dell’egemonia statunitense, sempre piú incomprensibile con le categorie catastrofiste del bagaglio ideologico formatosi nell’epoca staliniana102. Nella pubblicistica non erano mancate aperture verso l’amministrazione Kennedy. Le corrispondenze di Gianfranco Corsini da New York, in particolare, presentavano un’analisi sufficientemente libera da condizionamenti ideologici, accreditando soprattutto le innovazioni introdotte dagli intellettuali della «nuova frontiera» come Arthur Schlesinger, accogliendo il termine di paragone costituito dal New Deal di Roosevelt e rilevando le chance di una diversa competizione con l’Unione Sovietica103. Non è però chiaro quanto simili approcci fossero condivisi nel gruppo dirigente.
Il comunismo italiano sopravviveva alla modernizzazione, a dispetto delle profezie americane basate sulle teorie dello sviluppo e sull’equazione positivista tra prosperità e democrazia liberale come antidoto sicuro a un consenso che si riteneva fondato sulla povertà104. Ma il suo adeguamento all’epoca del boom economico sollecitava anche difficili revisioni culturali, mettendo a dura prova le idee di “modernità alternativa” formatesi tra le due guerre. La visione togliattiana della «guerra di posizione» presentava evidenti caratteri di schematicità. Si fondava, in particolare, sulla convinzione che il socialismo avrebbe costituito il vettore principale dell’unificazione progressiva del mondo e svuotato di senso la guerra fredda quale progetto occidentale, acquistando nuove forme e significati tramite la decolonizzazione e la sua onda di ritorno nell’Occidente postimperiale. Si sarebbe cosí aperta la strada per cambiamenti strutturali, consentendo nuovi modi di coniugare le nozioni di socialismo e democrazia e di rivendicare un ruolo del comunismo occidentale ben distinto dal riformismo socialdemocratico. In questa prospettiva, il capitalismo riformato welfarista si riduceva a un aspetto secondario e subordinato del capitalismo globale postbellico. In altre parole, lo schema togliattiano non prevedeva che l’egemonia degli Stati Uniti nell’Occidente capitalistico potesse generare alcuna “rivoluzione senza rivoluzione”, malgrado la sua azione trasformativa nelle politiche della produttività e, in modo crescente, tramite la diffusione dei consumi.
E tuttavia, le visioni internazionali del Pci non si ridussero a una mera variante dell’antiamericanismo e all’organizzazione delle campagne pacifiste periodicamente promosse da Mosca o dalla Germania orientale tramite il Congresso mondiale della Pace, decisamente in ribasso dopo il 1956. I comunisti italiani restavano legati alla “guerra fredda culturale” e ai suoi canoni manichei ma, nello stesso tempo, si accostarono alle visioni della fine della guerra fredda che emanavano soprattutto dagli attori esterni allo schema bipolare105. Essi assecondavano gli interessi dell’Unione Sovietica ma potevano stabilire influenza e credibilità soprattutto in un paese come l’Italia, malgrado le tentazioni neutraliste. Tale ricaduta delle visioni comuniste sulla scena nazionale non dovrebbe essere sottovalutata. La sinistra italiana aveva subito le scelte costitutive della collocazione internazionale del paese dopo la guerra, il duplice nesso transatlantico ed europeo. Dieci anni dopo, furono i comunisti a fornire l’impulso politico primario per indicare e influenzare l’interesse nazionale dell’Italia congiuntamente alla distensione Est-Ovest e alla realtà del Mediterraneo e del Medio Oriente postcoloniali. Ignorato o sottovalutato dalla maggior parte degli storici, tale impulso contribuí a formare parte essenziale dell’identità italiana nella politica internazionale, il recupero cioè di una visione e di una presenza nel Mediterraneo e nel Medio Oriente depurate dall’eredità del nazionalismo, che con alti e bassi doveva a lungo restare una costante delle classi dirigenti del paese.
4. La “riscoperta” del Terzo Mondo.
Dopo la morte di Stalin, i comunisti sovietici ed europei avevano letteralmente «riscoperto» il mondo extraeuropeo, recuperando e riformulando visioni risalenti agli anni Venti alla luce dei processi di decolonizzazione, che sembravano offrire formidabili prospettive di espansione al socialismo nel mondo106. L’alleanza tra l’Unione Sovietica e la Cina si presentava come un vettore delle nuove forze di movimento generate dall’incontro tra le esperienze socialiste e la nascita di nuovi soggetti e sovranità antimperialistiche. I comunisti stabilirono la visione di una necessaria convergenza tra progresso sociale, espansione del «campo socialista» e lotte di liberazione anticoloniali, che avrebbe messo alle corde l’Occidente capitalistico. Negli scenari aperti dall’interazione tra «campo socialista», movimenti di liberazione e Stati-nazione postcoloniali, i comunisti occidentali furono per lo piú considerati un attore marginale, con la parziale eccezione dei francesi che si trovarono a fronteggiare la fine dell’impero. Ciò nonostante, essi si confrontarono con le ripercussioni del fenomeno e riorientarono parte considerevole delle loro energie e reti di collegamento transnazionali, quando non cercarono di adeguare anche i propri strumenti concettuali. La nozione di policentrismo coniata da Togliatti rivelava il parziale ripensamento della visione strettamente eurocentrica che era stata propria dei comunisti italiani sin dagli anni Venti e che si era incrementata nell’epoca staliniana. La tesi cominformista dei «due campi» aveva collocato il vecchio continente al centro della nuova sfida bipolare per forgiare l’ordine mondiale. Anche Togliatti adottò una visione gerarchica, indicando i movimenti di liberazione coloniale come una forza di ausilio al «campo socialista» e i grandi paesi del Terzo Mondo come nuovi soggetti avviati verso il socialismo. La visione policentrica sembrava però implicare una versione meno rigida della tradizione eurocentrica e riflettere una crescente consapevolezza della portata globale della decolonizzazione. Pur appartenendo a un paese marginale nella tradizione colonialista europea e ancor piú secondario nelle dinamiche postcoloniali del dopoguerra, i comunisti italiani si sentivano investiti di un ruolo nel Mediterraneo, che rientrava nell’archetipo della «svolta di Salerno». Come era nella loro mentalità, si rivolsero ai sovietici per coordinare gli orientamenti dopo la crisi di Suez, ma fornirono le proprie risposte proponendosi come un anello di collegamento tra il «campo socialista» e i movimenti di ispirazione nazionalista, socialista e antimperialista anzitutto nell’Africa del Nord.
Era centrale la percezione di una situazione di relativo movimento che, pur senza mettere in discussione l’ordine bipolare europeo, apriva nuove possibilità in termini di relazioni e strategie. Le aperture dell’Unione Sovietica al mondo, simboleggiate dai viaggi all’estero dei suoi leader, specie nei paesi di nuova indipendenza, consentivano di allargare le pratiche internazionaliste e di pensarle in uno scenario di interazioni molteplici. Sotto questo profilo, l’internazionalismo poststaliniano si poteva configurare come un complesso di idee e pratiche politiche e culturali rivolte a integrarsi e competere sul piano globale, molto piú di quanto non fosse accaduto negli anni del Cominform107. La tenue ma crescente permeabilità della «cortina di ferro», che si manifestò nella seconda metà del decennio, investí anche le pratiche relazionali dei comunisti occidentali, in buona parte affioranti dal sottosuolo della guerra fredda staliniana. I rapporti tra partiti conservarono carattere strettamente bilaterale, salvo gli incontri destinati a preparare conferenze regionali o mondiali. La formazione dei quadri continuò a rivestire un carattere privilegiato108. Prese però corpo un sistema di relazioni a molteplici livelli, che intensificava gli scambi, specie a carattere culturale, giovanile e sindacale. Una simile moltiplicazione degli scambi appare evidente non soltanto nei rapporti con l’Unione Sovietica, ma anche, ad esempio, nel caso della Rdt, che pure giocava il ruolo di un guardiano ideologico rivolto a contenere le influenze del Pci al di là della sua dimensione nazionale109. Lo snodo piú visibile sul piano transnazionale fu la rivista «Problemi della pace e del socialismo», creata nel 1958 a Praga dopo i contatti seguiti allo scioglimento del Cominform e dopo la prima conferenza mondiale dei partiti comunisti. La sua redazione costituiva un network dislocato tra Praga e svariati paesi europei e del Terzo Mondo. Era anche un esempio delle incongruenze del movimento comunista. Il modus operandi strettamente centralizzato nelle mani della direzione sovietica e l’adozione del russo come lingua franca secondo il modello cominformista non impedirono una certa circolazione di persone e idee, anche se i meccanismi della censura restavano invasivi110. A Praga e a Varsavia si stabilirono connessioni, in particolare, tra le idee di riforma delle economie pianificate e le prospettive dello sviluppo a direzione statale nel Terzo Mondo, che configuravano un’agenda strategica rivolta ai soggetti postcoloniali e prescindevano da rigide definizioni del modello socialista111.
Il dato che balza in evidenza, tuttavia, non è l’interazione tra i comunisti europei attorno ai temi e alle pratiche internazionaliste sollecitate dalla decolonizzazione, ma al contrario l’assenza di un autentico coordinamento politico. Gli interventi economici concertati nel Comecon tra gli Stati del blocco sovietico esprimevano un discorso ideologico sullo sviluppo non capitalistico ma furono scarsamente integrati da forme di sinergia politica112. I comunisti europei si presentarono sulla scena della decolonizzazione in ordine sparso, anche se tutti parlavano il linguaggio modernizzatore e progressista dello «Stato di democrazia nazionale» per connotare la sovranità postcoloniale, definitivamente varato dai sovietici alla Conferenza mondiale del 1960 e inviso ai cinesi perché alludeva a un percorso di trasformazione non violento113. La “riscoperta” del Terzo Mondo aprí tra i comunisti occidentali e nei partiti-Stato dell’Est europeo processi di apprendimento e scenari di intervento largamente paralleli e comunicanti in modo episodico. Ciò fu probabilmente conseguenza di un’ottica che restava per tutti incentrata sulle categorie e le priorità della guerra fredda eurocentrica, ma significava comunque un grado di disciplinamento molto inferiore al passato e un margine di manovra largo per iniziative autonome.
Gli scenari della decolonizzazione consentivano di pensare un mutamento della situazione di minorità ed emarginazione subita dai comunisti in Europa dopo la divisione geopolitica del continente, la fine dell’onda alta della mobilitazione pacifista e lo spostamento dell’asse del movimento verso l’Asia determinato dalla rivoluzione cinese. Nel già citato incontro del febbraio 1957, Longo e Spano sollevarono con Chruščëv la questione del ruolo dei comunisti italiani nel processo di decolonizzazione. Longo dichiarò che «per il nostro partito presenta un importante significato la situazione nel mondo arabo e nell’Africa del Nord» e che i comunisti di questi paesi, specie gli egiziani, si rivolgevano al Pci per avere consigli. «Che dobbiamo fare?» chiedeva il leader italiano, «chi si deve occupare di loro, noi o i francesi? È possibile riunirsi e discutere le loro questioni in accordo con i compagni francesi?» Oltre agli egiziani, egli menzionò anche i comunisti marocchini e tunisini ma evitò un diretto riferimento all’Algeria, probabilmente perché il tema era sin troppo delicato nei rapporti con i francesi. In sostanza, i delegati italiani posero ai sovietici concreti problemi che emergevano dalla decolonizzazione nel Mediterraneo, investendo il ruolo dei comunisti europei. Essi fecero riferimento anche all’America Latina, sebbene in modo piú generico. I loro interrogativi rimasero però in sospeso. Chruščëv si limitò a osservare che nell’anno passato dal XX Congresso non si era fatto niente, malgrado l’intesa raggiunta allora per un coordinamento tra Pci e Pcf114. Ciò nonostante, la Sezione esteri del Pci stabilí un’agenda di lavoro nel Mediterraneo e in Africa, sotto l’impulso di dirigenti quali Spano, Giuliano Pajetta, Maurizio Valenzi. L’attenzione si rivolse prevalentemente all’Egitto e alla figura di Nasser, che aveva acquisito un notevole prestigio con la crisi di Suez ed era un interlocutore privilegiato dei sovietici115. La questione principale era però rappresentata dalla guerra di liberazione in Algeria. Il Fronte di liberazione nazionale algerino occupava un posto centrale nella costellazione dei soggetti antimperialisti e postcoloniali, rivolti a formare la nozione stessa di Terzo Mondo come progetto politico. Alla Conferenza mondiale di Mosca, nel novembre 1957, le voci del Terzo Mondo furono soprattutto quelle dei delegati asiatici, in particolare gli indiani e gli indonesiani, ma la questione dell’Algeria emerse e si rivelò anche problematica. I comunisti francesi rappresentati da Duclos difesero infatti il legame tra Algeria e Francia, sia pure nella prospettiva socialista, suscitando il dissenso del leader marocchino Ali Yata, che invocò una maggiore solidarietà internazionale per la lotta antimperialista algerina, alludendo allo scarso impegno del Pcf116. Togliatti si propose di evitare una rotta di collisione con il Pcf anche sul tema dell’Algeria, ma alludendo all’epoca del Fronte popolare ne rilevò l’incapacità di portare avanti «la sua grande politica del 1934», aggravata dall’avvento di De Gaulle. Le ambiguità nazionaliste dei comunisti francesi non erano difendibili, ancora meno nella prospettiva di una nuova ondata di decolonizzazione del continente africano117.
Alla fine del decennio, la rivoluzione cubana forní a tutti i comunisti la conferma di una stagione rivoluzionaria e antimperialista su scala mondiale, che avrebbe potuto influenzare l’intero subcontinente latinoamericano e indebolire il potere degli Stati Uniti nel mondo. I comunisti italiani costruirono il proprio ruolo senza un autentico coordinamento delle iniziative con il «campo socialista», malgrado che fossero essi stessi a sollecitarlo. Nel gennaio 1960 Longo informò Suslov che il Pci aveva legami diretti con i comunisti in Egitto e con «democratici di sinistra» in Somalia, Camerun, Ghana, Nigeria e altri paesi africani e pose la questione del ruolo da svolgere in termini di aiuti e sostegno. La risposta del leader sovietico fu quanto mai generica. Egli riteneva «positivo» che il Pci coltivasse tali legami e offrí la disponibilità di Mosca nella formazione dei quadri118. La relazione internazionalista tra Mosca e Roma su una questione cruciale come la decolonizzazione in Africa appariva quanto mai vaga, mentre il Pci intesseva le proprie connessioni transnazionali. Senza contare che lo sguardo e i legami dei comunisti italiani non si rivolgevano soltanto all’Africa del Nord, ma anche ad altre realtà coloniali e postcoloniali del continente africano, come risulta dalle parole di Longo. L’attenzione all’Africa subsahariana occidentale si era sviluppata da circa un anno, dopo che l’indipendenza della Guinea aveva dato impulso alla decolonizzazione nel continente. A maggior ragione risulta singolare la risposta evasiva di Suslov. Ci si può chiedere se essa non dipendesse dalla diffidenza nutrita per le tesi dei comunisti italiani sul rapporto tra democrazia, nazione e socialismo, che i sovietici giudicavano troppo inclusivo e poco ortodosso. In ogni caso, l’episodio appare particolarmente eloquente di quanto il coordinamento del comunismo internazionale fosse labile sin dalla prima fase della decolonizzazione.
I comunisti italiani adottarono una pedagogia sincretica volta a conciliare nazionalismo e socialismo tanto nel mondo arabo africano quanto nell’Africa subsahariana occidentale, sull’ispirazione della “nazionalizzazione” risalente alla Seconda guerra mondiale. Fu questo l’approccio alla Repubblica di Guinea guidata da Sékou Touré, vista da alcuni come l’equivalente rivoluzionario di Cuba nel continente africano, con la differenza che seguiva una «via pacifica» e rappresentava perciò un esempio consonante con l’ispirazione italiana119. Nel caso dell’Egitto, il Pci esprimeva un giudizio sul regime di Nasser in chiave di progresso sociale malgrado la dura repressione praticata contro i comunisti. Nello stesso tempo, cercava di aiutare un movimento comunista debole e frammentato a sviluppare il proprio profilo «nazionale». La possibilità di esercitare un’influenza nel paese era limitata. Tuttavia, l’Egitto costituiva un crocevia di passaggi e connessioni utili a giocare un ruolo nei movimenti antimperialisti nell’Africa del Nord e persino nelle profondità del continente120. Tra il 1960 e il 1961 la tragedia del Congo e l’assassinio del leader indipendentista Patrice Lumumba furono interpretati come un segno dell’aggressività dell’Occidente, ma anche una rivelazione della vulnerabilità del suo potere e una conferma della necessità di consolidare lo sviluppo autonomo dei nuovi Stati-nazione121.
I comunisti italiani erano consapevoli che i modelli di state-building piú influenti in Africa, quali l’autoritarismo di tipo socialista nasseriano o la «democrazia di massa» di Touré, presentavano seri problemi di coerenza con il loro discorso politico orientato dall’idea della democrazia socialista. Tale contraddizione si poteva riverberare soprattutto sulla loro credibilità di forza nazionale122. Sotto questo profilo, l’incontro con la decolonizzazione acuiva un’aporia costitutiva e introiettata, vale a dire l’identificazione con un sistema di Stati a partito unico in Europa, che aveva mostrato il suo volto oppressivo anche dopo la morte di Stalin. La principale controargomentazione era che proprio le convergenze di molti modelli statuali postcoloniali con il modello socialista, nelle sue linee essenziali, ne rivalutavano la funzione modernizzatrice e potevano caratterizzare una fase di transizione. Le incongruenze tra le idee di una «via democratica» al socialismo e la realtà dei regimi autoritari in gran parte dei paesi postcoloniali furono messe in disparte in nome dell’internazionalismo. L’interpretazione di questa nozione prese ad assumere, piú ancora che in passato, connotazioni peculiari.
Il posizionamento dei comunisti italiani emerse chiaramente quando salutarono con favore la prima Conferenza dei paesi non allineati svoltasi a Belgrado nel settembre 1961. La visione di Togliatti restava incentrata sulla distensione bipolare e sull’idea di un percorso socialista dei paesi emergenti, ma egli riconobbe la legittimità della politica di Tito e delle scelte di collocazione al di fuori dei blocchi123. Soprattutto da questo momento in avanti, le nozioni di Terzo Mondo e di «neocolonialismo» dell’Occidente, inteso come dominio economico mantenuto anche dopo la fine degli imperi, entrarono stabilmente nel lessico dei comunisti italiani. La visione del Terzo Mondo come soggetto antimperialista venne però adottata con parsimonia e subordinata ai linguaggi della modernizzazione graduale, incentrata su riforme agrarie, industrializzazione a guida statale, democrazia di massa. In questa chiave, i comunisti italiani videro con favore iniziative quali la Conferenza del Cairo nel luglio 1962, che pose in contatto i non allineati con i leader africani piú radicali e registrò anche la presenza dell’America Latina, promuovendo il tema delle alternative alla dipendenza dai mercati capitalistici e contestando la Comunità economica europea124. Essi non si fecero ambasciatori del modello di sviluppo sovietico, anche se credevano nelle sue potenzialità, e mostrarono maggiore comprensione di altri per le soluzioni ibride adottate dalle classi dirigenti postcoloniali, che miscelavano approcci statalisti e accesso ai mercati mondiali.
Contemporaneamente, i comunisti italiani traevano vantaggio dalla loro identità nazionale. Rappresentavano un paese che dopo la guerra si era affrancato dal passato coloniale e si stava modernizzando impetuosamente, presentando cosí opportunità e risorse indisponibili o mancanti, per motivi diversi, ad altri paesi dell’Europa meridionale, compresa la Iugoslavia. Potevano a ragione rivendicare una duratura coerenza nelle lotte anticoloniali, risalente sino al tempo della denuncia contro l’imperialismo di Mussolini in Etiopia. La lotta contro il colonialismo fascista e la sua analisi come tratto essenziale del regime faceva parte della stessa identità antifascista italiana. Tale eredità era internazionalmente riconosciuta, soprattutto in Africa, e agevolata dalla «decolonizzazione senza decolonizzazione» avvenuta in Italia dopo la Seconda guerra mondiale, la fine cioè del dominio coloniale senza i traumi e i conflitti che segnarono gli imperi francese e britannico125. L’incapacità dei comunisti francesi di assumere posizioni coerenti sull’Algeria creò un vuoto che gli italiani occuparono, stabilendo un rapporto con il Fronte di liberazione nazionale e con i comunisti algerini che riconnetteva l’antifascismo europeo con l’anticolonialismo126. I comunisti italiani sapevano che l’identità nazionale dei comunisti francesi produceva una posizione ambigua sull’indipendenza algerina, riconosciuta sul piano dei principî ma rimandata a un vago futuro sul piano politico. Ritenevano anche che i francesi giocassero un’influenza negativa sui comunisti algerini, spingendoli a privilegiare nelle alleanze sociali il fragile proletariato urbano, secondo lo schema strettamente eurocentrico risalente all’epoca staliniana127. Al momento dell’indipendenza, i comunisti italiani erano percepiti negli ambienti del Fronte di liberazione nazionale come un interlocutore importante e autonomo, protagonista di un’autentica «via nazionale» rispetto ai vincoli della guerra fredda128. Tutto ciò rendeva il loro ruolo transnazionale piuttosto rilevante anche nella competizione tra i sovietici e i cinesi, perché in una certa misura bilanciava la tendenza dei rivoluzionari algerini a vedere Pechino piú che Mosca come un riferimento alla luce dei problemi dell’arretratezza e della costruzione nazionale, oltre che sul piano dei linguaggi terzomondisti129. Togliatti salutò la fine della guerra d’Algeria rivendicando di rappresentare una delle forze piú coerenti nella difesa della causa dell’indipendenza dal colonialismo francese, che aveva toccato la sensibilità di vasti settori dell’opinione pubblica e della cultura in Europa130.
La coincidenza tra la crisi dei missili a Cuba e la nascita dell’Algeria indipendente creò i presupposti per un salto di qualità. In entrambi i casi, la guerra fredda si intrecciava ancora piú strettamente di prima con la decolonizzazione. Nella crisi dei missili, i comunisti italiani si allinearono alle posizioni sovietiche, con un accento particolare sulla necessità della distensione che stonava con l’internazionalismo antimperialista dei cubani. Il rilancio delle avanguardie rivoluzionarie rappresentato da figure come Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara, ma anche Ahmed Ben Bella, esercitava la sua attrazione simbolica e coincideva con la perdita di slancio del movimento pacifista europeo. L’approccio prevalente nel Pci fu di difendere la connessione tra i nuovi soggetti del Terzo Mondo e gli scenari della «coesistenza pacifica», recepirne l’impatto simbolico senza cedere alla tentazione di contrapporre la «via pacifica» alle varianti piú militanti dell’antimperialismo. Tuttavia, il Pci si trovò a competere con le prime espressioni intellettuali e politiche di una «nuova sinistra», portatrice di una spiccata critica terzomondista e antieurocentrica che lanciava una sfida sul nuovo spazio globale apertosi dopo il 1956131. La visione comunista, fondata sulla nazione politica europea, fu contestata come una forma di conservatorismo culturale, impiegando argomenti di matrice cosmopolita che non erano estranei alla tradizione degli stessi comunisti e che intervenivano sulla costruzione del mito resistenziale respingendo la narrazione del «secondo Risorgimento» per enfatizzare quella della rivoluzione incompiuta132. Il terzomondismo riproponeva la legittimità della violenza contro l’oppressione coloniale, apertamente invocata dal celebre libro di Frantz Fanon, I dannati della terra, che ridefiniva discorsi e pratiche della decolonizzazione alla luce della guerra d’Algeria, trovando ampi consensi intellettuali anche in Occidente. Gli stessi linguaggi della sinistra occidentale si pluralizzavano ed esprimevano significati diversi con la nascita di una critica «di sinistra» dell’Unione Sovietica133.
Sotto questa pressione, la pubblicistica e le strategie del gruppo dirigente del Pci mostrarono un doppio registro. «Rinascita» ospitò voci autorevoli del terzomondismo marxista, come Jean-Paul Sartre, che invitava a vedere l’impatto dirompente del Terzo Mondo come soggetto134. Piú in generale, si manifestò una netta tendenza ad allargare la visuale del proprio pubblico sulla pluralità dei soggetti antimperialistici, dalla nascita del nuovo Stato postcoloniale in Algeria alle lotte di liberazione in Africa legate a figure come Kwame Nkrumah e Nelson Mandela135. Sul piano delle strategie e delle pratiche, appare però molto piú evidente l’attenzione mirata ai temi dello sviluppo e alla pacificazione geopolitica, un’impostazione diversa dalle suggestioni terzomondiste. Il Pci mirava a inserire la questione del Mediterraneo e dell’Africa nell’agenda politica italiana ed europea, sostenendo il «blocco di Casablanca» costituito dai paesi che operavano rotture nette con il passato coloniale136. Non si trattava soltanto di approcci diversificati tra sedi pubbliche e riservate. L’impatto del Terzo Mondo rivoluzionario delineò anche una divergenza nel partito. La visione della «coesistenza pacifica» si rivelò infatti molto meno consensuale rispetto a qualche anno prima. Nella Direzione dell’ottobre 1962, subito dopo la conclusione della crisi dei missili a Cuba, Togliatti esplicitò il problema: «Tra i compagni due posizioni contrastanti e paralizzanti: non si farà nulla, l’Urss non rischierà la guerra. D’altra parte: l’Urss farà vedere agli americani quello che non s’aspettano. Non si comprende che si arriverà alla coesistenza pacifica con lotte anche aspre per singoli concreti obiettivi»137. Il gruppo dirigente si divideva tra una tendenza moderata, prevalentemente rappresentata da Amendola e Pajetta, rivolta alla funzione nazionale del partito e alla consonanza con l’Unione Sovietica, e una tendenza radicale rappresentata da Ingrao, piú sensibile al revival antimperialista e al suo apparente dinamismo culturale. È possibile che le implicazioni di una simile spaccatura, operante lungo linee tanto nazionali quanto internazionali, abbiano indotto Togliatti a promuovere una nuova generazione di dirigenti, in particolare Enrico Berlinguer e Alessandro Natta, che modificavano gli equilibri nella segreteria e nella Direzione138.
Togliatti non si assegnò il ruolo di un mediatore ma rilanciò la propria visione della «coesistenza pacifica», l’autentico centro di gravità della sua politica dopo la morte di Stalin. Nella sua relazione al X Congresso del partito, il 2 dicembre 1962, affermò che la «coesistenza pacifica» non era un’opzione tra le altre ma una necessità per tutti e non esclusivamente per il «campo socialista». «L’alternativa è questa», dichiarò, «o la pacifica coesistenza o la distruzione atomica e la fine, quindi, della nostra civiltà o della maggior parte di essa». Egli prevedeva una nuova fase di distensione dei rapporti internazionali dopo la crisi di Cuba e dopo la fine delle ostilità di confine tra Cina e India139. La posizione presa dal Pci sulla crisi dei missili generò un attacco pubblico dei comunisti cinesi, che colsero l’occasione per denunciare la linea della «coesistenza pacifica» come un tradimento delle lotte antimperialiste simboleggiate in quella circostanza dai rivoluzionari cubani. I cinesi si autorappresentavano ormai come una leadership alternativa del comunismo internazionale, avversa a qualsiasi compromesso con il «neocolonialismo» occidentale e sempre piú incline a estromettere l’Unione Sovietica dalle forze della rivoluzione mondiale. Nel gennaio 1963, Pechino attaccò Togliatti accusandolo di «revisionismo» per aver sostituito la lotta di classe con la «collaborazione di classe» su scala mondiale. La sua risposta fu pacata nei toni ma ferma nella sostanza e indicò l’obiettivo di «evitare la guerra instaurando un regime di coesistenza pacifica», anche come condizione per attuare trasformazioni socialiste non violente140. Togliatti vide nella nuova congiuntura della distensione internazionale, seguita alla crisi dei missili, l’occasione per un rilancio strategico, che doveva avere la funzione di contenere le critiche cinesi ma non si limitava a questo.
Il segnale piú intenso di questa visione fu la sua conferenza sul «destino dell’uomo» nel marzo 1963. Egli inserí i problemi che affliggevano il comunismo internazionale in uno sguardo molto piú largo. Ancora piú che in passato, sottolineò la multiformità degli sviluppi mondiali, definita sobriamente come «una nuova articolazione e differenziazione del sistema degli Stati» che registrava il posto legittimo dei paesi socialisti, malgrado i «problemi» e gli «errori» commessi, e rendeva obsoleta la guerra fredda. Tale analisi si inseriva in una versione particolarmente esplicita dell’anticatastrofismo togliattiano, rielaborato alla luce dell’epoca atomica. Riannodando le fila del discorso già intrapreso da circa un decennio, Togliatti sostenne che nel mondo contemporaneo «la guerra diventa cosa diversa da ciò che sia mai stata», cioè «il possibile suicidio di tutti», e la pace «una necessità, se l’uomo non vuole annientare se stesso»141. Simili parole, rivolte come un appello al mondo cattolico alla luce del Concilio Vaticano II e delle aperture di Giovanni XXIII alla distensione tra i blocchi, mostravano una convinzione profondamente maturata, che relegava nel passato la dottrina dell’inevitabilità della guerra. Togliatti sapeva bene che tale convinzione non era consensuale nel mondo comunista. Mao aveva radicalizzato la propria avversione alla «coesistenza pacifica», ma anche i sovietici professavano rigidamente la visione dei «due campi», ignorando il tema delle interdipendenze mondiali e mantenendo forti ambiguità sul concetto stesso dell’unità del genere umano. Ciò nonostante, Togliatti sembrava convinto che la fine della fase acuta della guerra fredda avrebbe offerto nuove prospettive di espansione al «campo socialista» e al comunismo su scala mondiale, una volta appianata la controversia tra Mosca e Pechino. Il Pci approvò il trattato di non proliferazione nucleare concluso tra le grandi potenze nel luglio 1963, che sancí la fine della crisi internazionale e fuori d’Europa fu letto da molti, a cominciare dai cinesi e dai vietnamiti, come la rinuncia di Mosca a sostenere il fronte antimperialistico142. Togliatti criticò pubblicamente i cinesi per la loro opposizione e commentò le rivelazioni circa il rifiuto sovietico di fornire la bomba atomica a Pechino nel 1959 affermando che cosí Mosca aveva saggiamente «servito la causa della pace, della distensione internazionale e del disarmo»143.
La polemica tra Mosca e Pechino conobbe allora una escalation che lasciava poco spazio a mediazioni. Le crescenti divergenze tra sovietici e cinesi misero a nudo molteplici aporie nella struttura e nel governo del «campo socialista», nelle visioni dell’antimperialismo, nelle strategie della guerra fredda. Ma soprattutto mostrarono come l’incontro tra comunismo e decolonizzazione potesse configurare tanto un vettore della politica mondiale quanto uno spazio di nuovi conflitti e antinomie, che non si risolvevano nella dicotomia tra socialismo e capitalismo. Togliatti confermò in Direzione la linea sino allora seguita, cioè che una conferenza mondiale del comunismo avrebbe solo finito per «approfondire la rottura», con gravi conseguenze per tutti. Egli si disse «poco entusiasta» per la condotta dei sovietici, sin troppo cauti anche su Cuba per poi mostrarsi «esasperati». Il Pci era uno dei partiti «piú forti» ma se lo scontro fosse andato avanti avrebbe avuto le sue difficoltà144. La previsione di Togliatti si rivelò corretta. Il presupposto per esercitare il ruolo di mediazione del Pci era che venisse in una certa misura accettato tra gli altri partiti comunisti. Ma soltanto i polacchi e i rumeni si trovavano vicini alle posizioni italiane. In particolare, la posizione supinamente filosovietica dei comunisti francesi aggravava le cose. Il Pcf affondò l’iniziativa di una conferenza dei partiti comunisti dell’Europa capitalistica, che nei disegni italiani avrebbe dovuto indicare un’alternativa alla conferenza mondiale. La preoccupazione di Togliatti era che la politica del muro contro muro alimentata da entrambe le parti avrebbe compromesso le basi del comunismo internazionale. A suo giudizio, la polemica in favore o contro la distensione non andava infatti al cuore del problema politico, che era invece «come dobbiamo sviluppare la politica di distensione»145.
Egli definí allora i contorni di una visione che legava piú precisamente il ruolo dei comunisti in Occidente al mondo postcoloniale. La sua idea era che l’epoca postimperiale registrasse la crisi di tutte le classi dirigenti europee, prima di tutto quelle socialdemocratiche, e che ciò potesse aprire la strada a un disegno socialista e antiatlantico. L’influenza dei comunisti gli sembrava praticabile a condizione che essi non si limitassero alla «semplice e non sempre feconda attesa di un diverso avvenire». Togliatti cercava di indicare una prospettiva politica, come altre volte in momenti cruciali del passato. La sua ottica presentava svariate approssimazioni e schematismi, soprattutto quando poneva il «potere autoritario» di De Gaulle e la Westpolitik di Adenauer sullo stesso piano della Spagna di Franco, senza neppure menzionare il tema dell’integrazione europea. La mentalità della guerra fredda faceva velo all’analisi differenziata dell’Europa capitalistica che Togliatti aveva molte volte invocato in anni lontani e che ora praticava in relazione al Terzo Mondo. Il punto qualificante della visione togliattiana era il nesso implicito tra il ruolo dei comunisti occidentali e le diversità del mondo postcoloniale, che avrebbero finito per modificare la nozione stessa di socialismo. Forse non per caso, il medesimo fascicolo di «Rinascita» che pubblicò il suo editoriale sul «socialismo in Occidente» ospitava anche il rapporto sulla questione coloniale risalente al VI Congresso del Comintern nel 1928146. Togliatti sembrava riallacciare i fili di una visione che si era sostanzialmente inabissata nell’epoca di Stalin.
Difficilmente una simile visione poteva trovare ascolto a Mosca o anche a Parigi. Il principale spettro dei sovietici, in quel momento, era il tentativo dei cinesi di conquistare influenza e controllo sui partiti comunisti in Asia e in Africa. La competizione senza esclusione di colpi tra sovietici e cinesi nel Terzo Mondo costituiva ormai un dato di fatto e stava compromettendo l’unità del movimento comunista. In un Comitato centrale dell’ottobre 1963, Berlinguer rilevò l’espansione dell’influenza cinese tra partiti e gruppi comunisti in Asia e anche in Africa. La sua preoccupazione non era però soltanto il contenimento dei cinesi, ma il fatto che il conflitto tra Mosca e Pechino impedisse di affrontare «nella loro effettiva portata» i problemi del Terzo Mondo. Egli fece un elogio della «coesistenza pacifica», respingendo la sua contrapposizione alle lotte antimperialistiche, ma usò parole insolitamente critiche verso le risposte «del tutto inadeguate» dei sovietici a tali problemi, che non furono rese pubbliche147. In altre parole, i dirigenti italiani non si limitavano a dissentire contro l’opzione di una scomunica dei cinesi, ma muovevano a Mosca obiezioni di carattere politico circa la concezione stessa dell’internazionalismo nel Sud globale. Non è chiaro se tutto il gruppo dirigente fosse allineato sulle posizioni di Berlinguer. Fu però in una simile ottica che i comunisti italiani intensificarono le proprie iniziative nel Mediterraneo e in America Latina, parallelamente al lungo viaggio diplomatico di Zhou Enlai in Africa tra la fine del 1963 e l’inizio del 1964, che sancí l’ingresso della Cina nella competizione per il Terzo Mondo non soltanto in chiave ideologica ma sul piano degli aiuti allo sviluppo148.
Incontrando Tito nel gennaio 1964, Togliatti consolidò il ruolo del Pci come un attore in grado di interloquire piú e meglio degli altri comunisti europei, e anche dei sovietici, con soggetti e movimenti terzi, rappresentati anzitutto dai non allineati. Egli si presentava non solo come un leader del comunismo internazionale ma come un mediatore tra esperienze e mondi rivoluzionari in modo crescente incomunicanti e disconnessi tra loro, a dispetto della loro presenza globale. Le sue conversazioni del 16 e 17 gennaio con Tito si basarono sulla comune convinzione che «la fisionomia del mondo contemporaneo» si fosse largamente modificata e che una politica di «coesistenza pacifica attiva» costituisse ormai una necessità. In questo contesto, il socialismo rappresentava «un processo sociale ed economico unitario» ma destinato a svilupparsi «in forme assai varie»149. I due leader convergevano sulla visione che Asia e America Latina rappresentassero i due epicentri di un’accelerazione di mutamenti globali che vedevano protagonisti una pluralità di soggetti diversi. L’obiettivo comune era incoraggiare le propensioni socialiste delle élite locali ed evitare che la fine del colonialismo potesse alimentare conflitti regionali e nazionali. Reduce da un viaggio nel continente americano, Tito espose in dettaglio la situazione di vari paesi dell’America Latina, passando sotto silenzio il ruolo di Cuba, forse perché rappresentava un tema troppo sensibile dato il difficile rapporto tra Belgrado e l’Avana, in lotta per la leadership nel Sud antimperialistico. Il terreno di confronto principale tra le due parti era però costituito dai paesi arabi dell’Africa del Nord. I due leader condivisero l’apertura di credito verso Ben Bella e Nasser, incluse le loro vaghe idee socialiste.
Tito e Togliatti furono parimenti accomunati dal giudizio molto critico sulle politiche della Cina, sebbene con sfumature diverse. Tito riteneva che il conflitto tra Mosca e Pechino fosse «essenzialmente di Stato» e prevedeva che i cinesi non sarebbero tornati indietro. Con la Iugoslavia il conflitto nasceva, a suo giudizio, dalla reazione cinese ai successi di Belgrado nelle alleanze con i paesi del Terzo Mondo. Gli iugoslavi non vedevano soluzioni a breve termine e indicavano come unica strada il coinvolgimento della Cina nelle politiche di sviluppo del Terzo Mondo, perché l’integrazione nel «campo socialista» non era sufficiente ad assicurare la crescita dell’economia cinese. Questa ultima notazione gettava un’ombra considerevole sulle effettive capacità dell’Unione Sovietica di sostenere una sfida globale e fondare la propria egemonia su concrete strategie di sviluppo. Togliatti rilevò, con una notazione piú consona alla cultura politica degli italiani, come nei paesi socialisti la pressione cinese rendesse «piú difficile il processo di democratizzazione». Prospettò lo scenario di un’intesa «tra i partiti comunisti dell’Ovest e i movimenti di liberazione dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina» e di un incontro dei partiti e movimenti progressisti del Mediterraneo, come un modo per sfidare le posizioni cinesi sul piano politico. Queste parole riflettevano l’idea togliattiana di creare una sfera di relazioni intermedia tra l’Unione Sovietica e il non allineamento rappresentato dalla Iugoslavia, aprendo una prospettiva ai comunisti dell’«Occidente capitalistico»150.
La consonanza tra Togliatti e Tito delineò un cambiamento non indifferente nel sistema di relazioni del comunismo italiano, pur nella fedeltà al «campo socialista». L’intesa sulla nozione di «coesistenza attiva», in particolare, consentiva di svincolare il tema dalla mera identificazione con la politica sovietica e lo trasferiva al livello delle Nazioni Unite. Non meno importante, si apriva per i comunisti italiani la possibilità di acquisire giudizi e informazioni sulla politica internazionale tramite il gruppo dirigente di uno Stato influente, che rappresentava una campana diversa da Mosca e dagli altri paesi socialisti. Gli iugoslavi condivisero, tra l’altro, le idee di cambiamento dei «rapporti economici mondiali» elaborate a Belgrado dai non allineati e le loro critiche al Comecon, inadeguato ad affrontare questo genere di problemi e persino a integrare i paesi socialisti. In piú, Tito forní a Togliatti anche un resoconto del proprio incontro con Kennedy, poco prima del suo assassinio. Per sua parte, Togliatti parve delineare una strategia inclusiva e non solo bilaterale, puntando alla missione di formulare un’idea di comunità socialista e di «mondo socialista» molto piú sfumata e allargata di quella concepita dai sovietici. L’azione del Pci non si presentava cosí soltanto come un sostegno alle politiche di contenimento della Cina attuate nel «campo socialista» leale a Mosca, ma come il tentativo di costruire alleanze politiche. Piú ancora di altre volte in passato, Togliatti formulava una visione dell’internazionalismo aperta alla convergenza con culture politiche diverse.
La parallela visita di Longo ad Algeri fu strettamente collegata alla strategia togliattiana che vedeva la ricerca di intese politiche come l’unica modalità sensata di contenimento dei cinesi, non compresa dai sovietici. L’Algeria rivoluzionaria si trovava all’apice del suo profilo internazionale, che affiancava quelli della Iugoslavia e di Cuba nel mondo dei non allineati. Le si attagliava bene la definizione di «mecca della rivoluzione», coniata qualche anno dopo dal leader guineano Amílcar Cabral. Algeri rappresentava un crocevia di leader e militanti antimperialisti da tutto il mondo e vi si erano recati, tra gli altri, figure come Che Guevara, Mandela e Yāsser ʿArafāt. L’ambizione dichiarata dei dirigenti algerini non era la fondazione di un socialismo nazionalista arabo, ma il progetto di una rivoluzione africana151. Il Pci aveva espresso il suo pieno appoggio al regime di Ben Bella dopo il varo della Costituzione del settembre 1963, che sembrava preludere a riforme di carattere socialista e alla creazione di un partito unico rivoluzionario che includesse i comunisti152. Ben Bella riconobbe ai comunisti italiani il rango di un interlocutore privilegiato, che non era possibile vedere nel Pcf, sotto un duplice profilo: la costruzione di una rete internazionalista e antimperialista nel Mediterraneo e l’influenza nazionale volta a rilanciare i rapporti economici con l’Italia, interrotti dopo la morte di Mattei153. La missione dei comunisti italiani precedette la visita di Ben Bella a Mosca del maggio 1964, che stabilí relazioni significative tra Algeria e Unione Sovietica154.
La missione di Ingrao a Cuba completò il quadro dell’intensa attività internazionale dei comunisti italiani all’inizio del 1964. L’attenzione verso la rivoluzione cubana e i suoi rapporti con l’America Latina aveva conosciuto un avvio lento fino alla tentata invasione americana alla Baia dei Porci. La presenza del Pci era stata affidata a vecchie figure dell’internazionalismo cominternista come Vidali e all’invio di quadri residenti in Cecoslovacchia, con scarso successo. La crisi dei missili aveva segnato un netto cambiamento. Alla fine di luglio 1963, dopo la ricucitura dei rapporti tra Mosca e l’Avana sancita dal viaggio di Castro a Mosca nel mese di aprile, il Pci aveva fatto un passo impegnativo inviando a Cuba una delegazione guidata da un membro della Direzione, Ugo Pecchioli. Questi aveva preso atto che Castro era tornato sui suoi passi accettando l’alleanza con l’Unione Sovietica, gli assunti fondamentali della «coesistenza pacifica» e persino l’inapplicabilità di un modello rivoluzionario unico alle specificità nazionali nel continente latinoamericano. Ma non aveva potuto fare a meno di osservare che il tema di una «via democratica» al socialismo suonava ancora come «un’idea politica estranea ai leader cubani»155. Il viaggio di Ingrao, che incontrò Che Guevara, confermò soprattutto i significati simbolici attribuiti all’esperienza cubana e la funzione di contrasto all’influenza cinese. Il dirigente italiano insistette sulla rilevanza dell’antimperialismo anche fuori dai confini del movimento comunista156.
Tuttavia, Cuba restava una realtà distante dal comunismo italiano e rappresentava una tendenza diversa nel movimento comunista internazionale. Le relazioni piú incisive del Pci in America Latina riguardavano altre realtà, in particolar modo il Cile, come appare evidente dalle missioni di Alfredo Reichlin nel 1962 e di Renato Sandri, uno dei dirigenti della Sezione esteri, del giugno-luglio 1964. Quest’ultimo riportava le critiche di gran parte dei comunisti del subcontinente non soltanto ai cinesi ma anche ai cubani per le loro «avventure» destinate ad accrescere la repressione sotto l’egida degli Stati Uniti e sottolineava di aver riscontrato in vari ambienti il prestigio dei comunisti italiani157. Nei primi mesi del 1964 emerse perciò visibilmente l’influenza del Pci in una rete di relazioni mondiali che nessun altro partito comunista occidentale poteva vantare. Il nuovo rapporto tra il Pci e la Iugoslavia rappresentava l’anello fondamentale di congiunzione tra «campo socialista» e non allineamento, che consentiva al comunismo italiano di consolidare le proprie connessioni e intermediazioni dal Mediterraneo all’Africa e all’America Latina.
5. Il «memoriale» di Jalta.
Nel resoconto pubblico del viaggio in Iugoslavia, Togliatti affermò che «non si può ridurre tutto il mondo socialista a un solo blocco, militare o politico che esso sia». Egli raccolse l’argomento di Tito che la polemica cinese contro gli iugoslavi si era intensificata quando questi ultimi avevano conquistato «simpatia e adesione tra i paesi nuovamente liberati»158. Togliatti riteneva che il socialismo nel mondo fosse una realtà troppo diversificata e pluralizzata per poter essere ricompresa in una concezione comunitaria gerarchica. Nel febbraio 1964, il Pcus inviò però a tutti i partiti una lettera che parlava un linguaggio diverso e denunciava il tentativo cinese di creare un «blocco frazionista» nel movimento comunista internazionale159. Di ritorno da colloqui con Chruščëv, Suslov e Ponomarëv a Mosca, Longo riferí che i sovietici non celavano la propria irritazione per gli argomenti che tendevano a distinguere la nozione di socialismo nel mondo dalla realtà del «campo socialista», vedendo riaffiorare la tesi del policentrismo nel momento meno appropriato. Longo sembrava condividere questa ottica e dichiarò che «vi è un conflitto di egemonia tra Pcus e Pcc. I cinesi vogliono la “leadership” anche a costo di buttare per aria la direzione del Pcus. Non possiamo restare indifferenti e salvarci l’animo». Togliatti però non intendeva chiudersi nella tenaglia dei sovietici e nel suo intervento ribadí che potevano esserci esperienze socialiste senza entrare nel «campo socialista». Fece notare che gli iugoslavi avevano costruito cosí la propria e non erano equidistanti tra i due «campi» ma anzi si ponevano l’obiettivo di espandere la «coesistenza» al Terzo Mondo160. Ancora una volta, i significati molteplici del policentrismo si presentavano come una questione controversa e irrisolta nel comunismo internazionale.
Nell’aprile 1964 la presa di posizione pubblica dei comunisti francesi, in favore di una conferenza mondiale del comunismo, indusse Togliatti e Longo a scrivere una lettera ai sovietici, nel tentativo di bloccare un invito formale che sarebbe stato impossibile rifiutare161. L’argomento principale era che una simile iniziativa avrebbe sancito lo «scisma» del movimento e creato «due centri organizzativi» in lotta l’uno contro l’altro, compromettendo l’autonomia degli altri partiti. I due dirigenti italiani precisavano che non avrebbero sottoscritto alcuna formula rivolta a mettere in dubbio le «vie nazionali»162. Tuttavia, la posizione del Pcf provocò il fallimento dell’opera diplomatica del Pci. Togliatti confidò all’ambasciatore sovietico Semën Kozyrev di ritenere che probabilmente non vi fosse un’alternativa alla convocazione della conferenza, anche se continuava a dubitare della sua convenienza163. Il gruppo dirigente giunse alla conclusione di mantenere le proprie riserve, presentandole però come un modo per combattere meglio le posizioni cinesi e accettando di prendere parte alla preparazione di una conferenza164. La relazione presentata subito dopo da Togliatti al Comitato centrale costituí un accorato appello all’unità. Egli ribadí la condanna del «metodo della solenne scomunica», che avrebbe presentato «il pericolo di un risorgere di sistemi autoritari e settari», e non rinunciò a una visione incentrata sulla diversità dei soggetti antimperialisti e delle possibili forme di socialismo. In questo contesto, rifiutò di «porre all’avanguardia» del movimento mondiale «le masse contadine dei paesi sottosviluppati», come facevano i cinesi, ma lamentò anche che il movimento operaio occidentale non fosse all’altezza del compito di mettere insieme «i diversi settori del grande fronte contro l’imperialismo»165.
Dopo che una delegazione composta da Ingrao, Berlinguer e Colombi inviata a Mosca ebbe constatato la determinazione dei sovietici, Togliatti richiamò il gruppo dirigente al senso di appartenenza e al principio di lealtà. La sua bussola restava l’idea che la funzione internazionale dei comunisti italiani potesse essere concepita soltanto nella sua interazione con il «campo socialista», malgrado il riconoscimento che questo costituisse una camicia troppo stretta per definire il profilo globale del socialismo. «Nel mondo c’è il campo dei partiti comunisti, solo questo», dichiarò a scanso di equivoci, «non possiamo immaginare che il nostro partito non ne faccia parte»166. Togliatti e Longo scrissero ai sovietici riconoscendo i pericoli dell’influenza cinese ma anche paventando una rottura che avrebbe prodotto conseguenze negative sui movimenti di liberazione nell’Asia sudorientale167. Il 20 giugno Togliatti comunicò a Kozyrev che non vedeva piú ostacoli alla convocazione della conferenza, limitandosi a chiedere un significativo lavoro preparatorio, e minimizzò le divergenze con i comunisti francesi, pur facendo notare che Thorez si era rifiutato di incontrarlo168. Il momento della decisione giunse all’inizio di luglio. Togliatti si rivolse al proprio gruppo dirigente invitando a «non dare l’impressione che non comprendiamo i bisogni generali del movimento. C’è un processo centrifugo che deve essere posto sotto controllo. Non è nel nostro interesse che il prestigio della leadership sovietica sia scosso nel movimento internazionale». La sua insistenza su questa ottica nasceva anche dalla presenza di posizioni insofferenti e meno flessibili verso le richieste di Mosca, sostenute in particolare da Ingrao e Berlinguer169. Il Pci mantenne le proprie convinzioni sull’inopportunità della conferenza, ribadite in una lettera al Pcus del 7 luglio, ma accettò di prendere parte ai lavori preparatori170. Il 30 luglio 1964 i sovietici avviarono il percorso verso la conferenza, convocando i rappresentanti dei partiti a Mosca per la fine dell’anno171. Le tensioni tra sovietici e italiani non erano per questo appianate. Secondo l’opinione espressa all’ambasciatore sovietico in Francia dal leader comunista spagnolo Santiago Carrillo, sarebbe stato importante appoggiarsi a Togliatti, fino a che era ancora in vita, per evitare la deriva del Pci rappresentata da Amendola e Berlinguer, che non guardavano piú all’esistenza del movimento comunista internazionale ma a una forma di «comunismo nazionale»172.
Nel mese di agosto 1964 Togliatti decise di recarsi in Unione Sovietica. I motivi della sua visita sono stati oggetto delle piú diverse speculazioni, alla luce del mancato incontro con Chruščëv, sostituito da Ponomarëv e da Leonid Brežnev, il futuro successore del primo segretario. Gli indizi circa la presunta partecipazione del leader italiano a un complotto contro Chruščëv, sboccato pochi mesi dopo nella sua destituzione, appaiono tuttavia inconsistenti173. L’urgenza della missione di Togliatti si spiega con il fatto che i nodi della questione cinese erano ormai venuti al pettine e il Pci non poteva piú limitarsi a esercitare un veto. Egli si proponeva di stemperare le tensioni emerse con Mosca nei mesi passati, accettando il compromesso di partecipare ai lavori preparatori della conferenza e facendo pesare il ruolo del Pci nella discussione su come combattere le posizioni maoiste. Possiamo immaginare che Chruščëv fosse meno incline degli altri dirigenti sovietici a una mediazione sulla questione cinese e per questo motivo evitasse di incontrare il leader italiano. In ogni caso, il prestigio personale di Togliatti e l’influenza del Pci nel comunismo internazionale e oltre i suoi confini portano a escludere l’ipotesi che i sovietici avrebbero facilmente rinunciato a trovare un’intesa o intendessero addirittura mettere gli italiani sotto tutela. La soluzione prospettata da Togliatti dovette apparire soddisfacente a Brežnev e Ponomarëv, come appare evidente anche alla luce del fatto che dopo la destituzione di Chruščëv la nuova leadership avrebbe cercato di ristabilire un rapporto con Pechino. Molto meno soddisfatti essi furono delle critiche a largo spettro formulate da Togliatti nel promemoria che redasse a Jalta in attesa di un nuovo incontro. Proprio i toni critici usati senza giri di parole mostrano come egli si sentisse nella posizione di far valere appieno il proprio ruolo di leader internazionale del movimento.
Il «memoriale» di Togliatti si apriva con il chiarimento che i comunisti italiani avrebbero risposto positivamente alla convocazione a Mosca per i lavori preparatori, pur mantenendo le proprie perplessità su un’iniziativa che avrebbe registrato l’assenza di numerosi partiti comunisti asiatici. Ma lo scritto spaziava subito sull’analisi di «tutta una serie di problemi» del comunismo internazionale174. Togliatti criticava i sovietici per la loro «polemica ideologica e propagandistica» che li aveva posti sullo stesso piano dei cinesi, invece di sviluppare un’azione politica, come da lui stesso suggerito, rivolta a definire compiti e ruoli «nei diversi settori del nostro movimento» isolando le posizioni maoiste. Il suo appello a salvaguardare l’unità del mondo socialista e a evitare che maturasse una «generale e consolidata scissione» non era soltanto una questione di principio. Togliatti collocava il cuore della sfida in Europa e in Occidente, dove era vitale opporsi alla «programmazione capitalistica» e alle sue tendenze «antidemocratiche e autoritarie», sviluppando le idee di una «via pacifica di accesso al socialismo». Egli aveva ormai messo alle spalle l’epoca del «movimento per la pace», che non menzionava, e poneva invece la questione di «un piano generale di sviluppo economico» e di una «progressiva trasformazione» della «natura» dello Stato nell’Occidente capitalistico. In questa prospettiva, esprimeva un impietoso giudizio circa l’inadeguatezza di gran parte dei partiti comunisti sul piano della politica di massa, un motivo ormai ricorrente. Condizione essenziale di un’azione politica gli sembrava il riconoscimento della diversità nel movimento comunista e nelle sue relazioni mondiali, che alludeva al tema del policentrismo. Il documento conteneva pochi ma importanti cenni ai rapporti tra i partiti comunisti occidentali e i movimenti di liberazione anticoloniale. Togliatti scrisse che sarebbe stata preferibile una conferenza convocata dai partiti occidentali con rappresentanti «dei paesi democratici del “terzo mondo” e dei loro movimenti progressivi», dedicata «esclusivamente» al problema delle «vie di sviluppo dei paesi ex coloniali» per capire «che cosa significhi per essi l’obiettivo del socialismo». Cosí si sarebbero combattuti i cinesi «con i fatti» e non solo con le parole. Il riferimento alla lotta anticinese costituiva un argomento persuasivo portato ai sovietici, ma gli interrogativi di Togliatti erano piú generali e investivano il significato stesso della nozione di socialismo nel mondo. C’è da chiedersi se questo passaggio del «memoriale» rimandasse non soltanto a un campo di possibilità ma anche al senso di un riflusso della prima ondata rivoluzionaria associata, a torto o a ragione, alla decolonizzazione.
Gli interrogativi investivano anche il mondo socialista e l’Unione Sovietica. Togliatti insisteva sul «superamento del regime di limitazione e soppressione delle libertà democratiche e personali che era stato instaurato da Stalin», lamentando la «lentezza e resistenza a ritornare alle norme leniniste», che equiparava alle libertà democratiche. «Questa lentezza e resistenza è per noi difficilmente spiegabile», scriveva, soprattutto in quanto «non esiste piú accerchiamento capitalistico e la costruzione economica ha raggiunto successi grandiosi». Togliatti sosteneva che la destalinizzazione fosse un processo ancora da sviluppare per liberare, a suo modo di vedere, le potenzialità delle società socialiste. La sua esortazione ai sovietici rivelava una coscienza del problema diversa da tre anni prima, quando lo aveva liquidato con fastidio suscitando la reazione di Amendola. Verosimilmente l’intolleranza ideologica sovietica nel gestire il conflitto con i cinesi lo aveva indotto a riconsiderare i limiti della destalinizzazione. Egli aderiva alla narrazione neoleninista e all’idea di una contraddizione da risolvere tra l’espansione produttiva e sociale del socialismo sovietico, da una parte, e i suoi assetti politici e istituzionali, dall’altra.
Togliatti applicava invece al capitalismo un linguaggio semplificato, evocando una «crisi del mondo economico borghese». Non spendeva una parola sulla dinamicità mostrata da circa un decennio dal capitalismo postbellico né sulle sue tangibili conseguenze in termini di sviluppo industriale, prosperità e consumo, che pure aveva riconosciuto negli anni piú recenti a proposito dell’Italia. Pesava il suo giudizio negativo sulla stessa situazione italiana, espresso a piú riprese prima della sua partenza per Mosca, che puntava il dito sull’involuzione conservatrice del centro-sinistra e lo portava a dubitare circa la possibilità di un «riformismo borghese». Il problema di fondo era la contraddizione tra l’idea delle «riforme di struttura», che presupponeva una visione anticatastrofista, e il rifiuto di ammettere la possibilità di un capitalismo “progressivo” alla luce della persistenza dell’imperialismo175. La peculiarità italiana, letta da Togliatti come il prodotto di un denso peso specifico di forze inerziali e resistenze culturali e strutturali al cambiamento, rimandava cosí anche al contesto internazionale.
Egli sosteneva che l’Occidente fosse in balia di pericolosi «gruppi reazionari» dopo l’assassinio di Kennedy. Il suo giudizio sul Mercato comune europeo come volano della concentrazione monopolistica del capitale svalutava le posizioni realistiche prese dal Pci sin dalla fine degli anni Cinquanta, volte ad ammettere certi benefici delle interdipendenze economiche e a compiere una distinzione tra la Comunità Europea e la Nato, vanamente proposte agli altri comunisti europei 176. In altre parole, Togliatti non sembrava pensare l’Europa comunitaria come una possibile articolazione dell’ordine mondiale policentrico, neppure nella chiave di sfruttare i margini di manovra per una separazione dagli Stati Uniti. L’attacco americano contro il Vietnam del Nord, avvenuto pochi giorni prima, ne accentuava forse il pessimismo. Probabilmente egli impiegava a ragion veduta un vocabolario schematico, adatto alla comunicazione con i sovietici. Ma il dato di fatto è che il suo promemoria rivelava un impianto pressoché immutato dal 1956, che recava il segno della Grande Depressione e la refrattarietà a riconoscere il dinamismo del capitalismo malgrado la sua trasformazione postbellica. Togliatti non concedeva alcun credito alla sfida modernizzatrice del capitalismo liberale che rappresentava l’eredità di Kennedy. Ciò restituiva un’idea salvifica della modernità socialista, secondo la visione di un finalismo storico unilineare che non aveva mai abbandonato. Proprio una simile idea drammatizzava lo scenario della rottura ma faceva anche velo alla comprensione di cause profonde del conflitto tra Unione Sovietica e Cina, quali l’entità del deficit di egemonia sovietico, la diversità fra le due rivoluzioni e le contraddizioni emerse nella cultura politica comunista al momento dell’espansione nel Sud globale.
Togliatti intuiva come il conflitto avesse a che fare con il tema della sovranità socialista, che non era risolto da una «forzata unanimità esteriore», e con una forma di «nazionalismo rinascente» dei cinesi, che non doveva suscitare troppa sorpresa in quanto «costante del movimento operaio e socialista, per un lungo periodo anche dopo la presa del potere». Riconosceva però che «non sappiamo spiegarci pienamente» il manifestarsi tra i paesi socialisti di «una tendenza centrifuga». E invitava i dirigenti sovietici a farsi carico di questo «evidente e grave pericolo». Anche se «l’autorità e il prestigio» dell’Unione Sovietica restavano «enormi», il conflitto fra le due potenze socialiste, a suo giudizio, suscitava una preoccupazione tra le masse in quanto poneva in questione «i principî stessi del socialismo». Tale conflitto avrebbe richiesto «un grande sforzo per spiegare quali sono le condizioni storiche, politiche, di partito e personali che hanno contribuito a creare l’odierno contrasto e conflitto»177. La frattura del «campo socialista» comprometteva la visione di un’ascesa irresistibile del socialismo come vettore dell’unificazione del mondo. Togliatti si assumeva cosí il compito di esprimere una coscienza critica che mancava ai leader sovietici e cinesi. Non soltanto lanciava un allarme per l’unità del «campo socialista» ma indicava il pericolo che la fine dell’unità potesse compromettere le sorti del movimento. Sotto questo profilo, il «memoriale» assumeva l’aspetto di una profezia, destinata a restare inascoltata.
Togliatti riproponeva di fatto la visione del policentrismo, come rappresentazione di un ordine mondiale sempre meno bipolare, senza però impiegare la nozione, divenuta scomoda alla luce del conflitto tra Mosca e Pechino. La formula dell’«unità nella diversità» presentava un profilo decisamente minore, perché costituiva un imperativo politico, assai piú che un concetto analitico e strategico. Non è senza ironia che il drammatico appello di Togliatti al principio dell’unità riecheggiasse quello fatto da Gramsci quasi quarant’anni prima, nella lettera dell’ottobre 1926, pubblicata per la prima volta sulla stampa comunista nel maggio 1964178. Allora quel principio riguardava il gruppo dirigente bolscevico, ora le leadership delle due grandi potenze del «campo socialista». Ancora una volta, erano in gioco la nozione stessa di internazionalismo, la legittimazione di massa su scala mondiale e il futuro del soggetto comunista. Allora Togliatti aveva respinto l’appello gramsciano all’etica della responsabilità in nome del realismo politico, convinto che una nuova unità si sarebbe ricostituita attorno a Stalin, sia pure con metodi coercitivi. Ora egli stesso sollevava drammaticamente un problema di responsabilità della leadership sovietica, mentre sembrava fargli difetto proprio l’ingrediente del realismo. La condotta e la mentalità dei sovietici e dei cinesi non mostravano infatti alcuna autentica propensione per il riconoscimento delle diversità politiche e culturali, in grado di ricostituire tessuti connettivi e canali comunicativi che si erano strappati e interrotti proprio all’apice del progetto globale comunista. Privo di una prospettiva politica percorribile, l’ultimo messaggio di Togliatti lasciava uno sguardo fondamentalmente pessimistico sul futuro del comunismo internazionale.
Il «memoriale» di Jalta venne pubblicato nel settembre 1964, per decisione di Longo, sebbene esso non fosse concepito per essere divulgato e malgrado la richiesta dei sovietici di tenerlo riservato179. Longo spiegò all’ambasciatore sovietico che si era cosí deciso perché indiscrezioni sul «memoriale» erano trapelate sulla stampa, ma anche al fine di evitare l’opposizione di «molti membri del partito» a partecipare alla preparazione della conferenza mondiale180. Simili argomentazioni riflettevano solo parzialmente il pensiero dei dirigenti del Pci, che videro nella pubblicazione del documento una certificazione della propria autonomia. Da quel momento in avanti, il «memoriale» fu recepito come il testamento politico di Togliatti. I suoi partner a Mosca lo accolsero con malcelata perplessità181. I suoi avversari marxisti-leninisti, come il dittatore filocinese dell’Albania Enver Hoxha, lo giudicarono un documento «revisionista» che impiegava a questo fine la nozione del policentrismo182. I suoi successori lo interpretarono come un compendio delle principali coordinate del partito, che annunciava la fine del «legame di ferro» con l’Unione Sovietica183. In questo senso, il «memoriale» acquisí una sacralità nella cultura politica dei comunisti italiani.
Retrospettivamente, non è difficile vedere come il «testamento» togliattiano fosse qualcosa di piú e di diverso. Il momento della sua scrittura rappresentava per molti aspetti il tramonto di un’epoca, che l’autore sembrava in una certa misura presagire. L’ingegno politico di Togliatti lasciava ai suoi successori una visione basata sul policentrismo invece che sul monolitismo, sulla democrazia di massa invece che sul partito-Stato, sull’inclusione delle diversità invece che sull’esclusione ideologica. Ma tale visione non prometteva di farsi patrimonio comune del comunismo internazionale. Il mondo di Togliatti stava mutando volto molto rapidamente. Il conflitto tra Mosca e Pechino mostrava l’aspetto di una frattura tra il Nord socialista e il Sud antimperialista del mondo. L’autorità e la legittimazione dell’Unione Sovietica apparivano contestabili anche in questa luce, oltre che nella scia del 1956 in Europa. Le relazioni tra il «campo socialista» e il Terzo Mondo presentavano difficilmente i significati di un vettore plurale e convergente verso il socialismo. I nessi reali o immaginati tra le idee di una riforma strutturale del capitalismo in Europa, la modernizzazione poststaliniana nell’Europa centro-orientale e i soggetti postcoloniali non decollavano. La narrazione neoleninista non era in grado di spiegare la natura autoritaria degli Stati socialisti e il loro legame con la guerra fredda. Il testamento politico di Togliatti, in realtà, chiudeva un’intera epoca del comunismo, riconoscendo la crisi dell’interdipendenza stabilita sino allora tra la grande potenza dell’Unione Sovietica, la «superiorità» del suo sistema sociale, l’espansione politica e statuale del «campo socialista» e l’emergere del mondo postcoloniale.
PARTE TERZA
Trasformazioni: il tramonto dell’internazionalismo
(1964-1984)
Capitolo quinto
Socialismo umanistico e «lungo Sessantotto»
1. Dopo Togliatti.
La scomparsa di Togliatti coincise con una congiuntura internazionale destinata a scomporre lo scenario disegnato nel «memoriale» di Jalta. Nell’arco di poco tempo, le speranze di scongiurare la rottura tra Mosca e Pechino, gli orientamenti socialisti tra i nuovi soggetti statuali del Terzo Mondo, le prospettive di una destalinizzazione piú credibile e incisiva si persero o si annebbiarono sensibilmente. La destituzione di Chruščëv costituí un evento inaspettato e sconcertante, che non pose rimedio alla disputa con Pechino e invertí la rotta della liberalizzazione politica in favore di riforme tecnocratiche dell’economia pianificata. Un colpo di Stato depose Ben Bella nel giugno 1965 ridimensionando il progetto di un’Algeria rivoluzionaria nel Mediterraneo. Pochi mesi dopo uscí di scena una figura altamente simbolica del Terzo Mondo come Sukarno e il Partito comunista indonesiano fu distrutto da una feroce repressione militare. All’inizio del 1966 cadde anche Nkrumah in Ghana. L’internazionalismo terzomondista cubano manteneva la sua vitalità ma sfidava anche il non allineamento legato alla Iugoslavia e la «via pacifica» degli italiani. La mobilitazione globale provocata dall’intervento americano in Vietnam si verificò nel contesto di fratture profonde del «fronte antimperialista» e del Terzo Mondo come soggetto immaginato1.
La perdita dell’autorità e della mente politica di Togliatti generò un inevitabile senso di smarrimento, che la fine dell’unità comunista poteva solo aggravare2. La caduta di Chruščëv fu un motivo in piú per rivendicare il «memoriale» togliattiano come carta d’identità. Inviato a Mosca alla fine di ottobre 1964, insieme a Bufalini e Sereni, Berlinguer manifestò riserve e interrogativi circa il rispetto delle «norme leniniste», usando il lessico togliattiano e fronteggiando le rimostranze di Ponomarëv per la decisione di rendere pubblico il «memoriale»3. Lo stesso Berlinguer incassò poco dopo un successo postumo della linea togliattiana sulla conferenza mondiale, che i partiti comunisti riunitisi a Mosca nel marzo 1965 decisero di rimandare per farne maturare i tempi, forse nella speranza di una ricucitura con Pechino consentita dai comuni aiuti al Vietnam del Nord dopo l’inizio dei bombardamenti americani. I comunisti italiani lessero la guerra americana e la frattura del «campo socialista» come due aspetti complementari di una vera e propria crisi della «coesistenza pacifica». Berlinguer sostenne allora l’esigenza di non affidarsi alla «illusione che la distensione passi solo attraverso Mosca e Washington», un’intuizione che non presentava però per il momento risvolti concreti4. I comunisti italiani si impegnarono non meno degli altri nel rilancio del motivo antimperialistico incentrato sulla guerra in Vietnam. In realtà, esso forniva un punto di aggregazione piú sul piano propagandistico che su quello politico. Fu questo il terreno e la nota principale della ripresa dei rapporti con i comunisti francesi, registrata nell’incontro tra Longo e Waldeck Rochet a Ginevra del maggio 1965, che dette anche il tono alla Conferenza dei partiti comunisti occidentali tenutasi a Bruxelles5. Il medesimo accento connotò le contemporanee missioni in Vietnam e a Cuba, rispettivamente guidate da Pajetta e da Alicata. La solidarietà internazionalista e il discorso antimperialista costituivano elementi simbolici importanti, ma non sempre presentavano implicazioni politiche concrete6. Anzi celavano serie divergenze nel caso dei cubani. Il loro allineamento filosovietico nel conflitto con i cinesi, recentemente riaffermato da Fidel Castro, non implicava infatti migliori rapporti con Tito, che invece restava un punto di riferimento per il Pci. Alicata fu anche colpito negativamente dalle «tendenze autoritarie e coercitive» del regime cubano7.
Risultati e prospettive dei primi contatti internazionali intrapresi nel dopo Togliatti lasciarono a dir poco insoddisfatti gli stessi dirigenti del Pci. Il primo a esprimere apertamente disagio fu Ingrao, che nel giugno 1965 denunciò che «ognuno la pensa come vuole e non c’è piú scambio di giudizi sulla situazione reale […]. La cosa si pone anche per il terzo mondo […]. Il fatto grave è non solo che l’Urss sta zitta, ma anche non stimola». Pajetta ribatté che tra i giovani c’erano tendenze alla «revisione» della politica di coesistenza8. E coglieva nel segno. La sinistra del partito che faceva riferimento a Ingrao, soprattutto figure come Rossanda, Magri e Reichlin, ma anche Achille Occhetto alla guida dell’organizzazione giovanile, già da tempo aveva manifestato insofferenza circa l’adeguatezza della «coesistenza pacifica» a sostenere le forze antimperialiste nel mondo, accogliendo di fatto elementi della critica di matrice maoista. Nell’ottobre 1965, Longo confidò a Barca la propria preoccupazione per le posizioni ingraiane sulla «coesistenza pacifica», che avrebbero implicato un cambiamento complessivo di strategia e una divisione nel partito. Subito dopo, il segretario persuase Ingrao a rinunciare a sollevare la questione in sede congressuale, richiamandolo all’eredità togliattiana9.
Tuttavia, il problema non era soltanto di linea politica. Lo stesso Longo riconobbe il disorientamento del gruppo dirigente alla fine dell’anno, quando in Direzione parlò di un «vuoto» nei rapporti internazionali del Pci e riferendosi agli altri partiti italiani affermò addirittura che tutti avevano collegamenti internazionali, ma «noi non piú». L’affermazione poteva apparire paradossale, dato il peso avuto dal Pci nell’internazionalizzazione della Repubblica e i suoi legami ideologici e pratici di lunga data con l’Unione Sovietica e il «campo socialista», ma rivelava un lucido sconforto legato alla scissione cinese. Berlinguer rincarò la dose, chiedendosi se «i presupposti» del «memoriale» di Jalta esistessero ancora10. Queste parole inducono a ritenere che alcuni dirigenti si interrogassero attorno al «memoriale» alla luce dei sensibili cambiamenti di scenario intercorsi in poco piú di un anno. Una simile riflessione tuttavia non ebbe luogo. È evidente che Longo e Berlinguer non si riferivano tanto alla tela delle relazioni transnazionali intessute negli anni passati, quanto alla crisi di senso della tradizione internazionalista dopo la fine dell’unità comunista. L’appello unitario del «memoriale» e l’esortazione rivolta alla leadership sovietica di assumere un’iniziativa all’altezza delle questioni globali erano caduti nel vuoto. Contrariamente alla tradizionale visione anticomunista, il problema del Pci, già evidente da tempo, non era il controllo esercitato da Mosca, ma l’assenza di un autentico scambio e la conseguente inefficacia della partnership. La stessa ritualità degli incontri tra partiti comunisti, soprattutto bilaterali, era avvertita come una camicia troppo stretta, ma l’allargamento di relazioni ad altre forze progressiste in Europa e fuori d’Europa non poteva nascere soltanto da iniziative unilaterali. Il dibattito nel gruppo dirigente si concluse, in mancanza di altre prospettive, con la decisione di migliorare i rapporti con Mosca.
Longo paventava un riflesso negativo anche nella politica nazionale. Il relativo vantaggio assicurato al Pci dopo il 1956 dall’incrocio tra «coesistenza pacifica», influenze nel Mediterraneo e interessi nazionali si stava consumando. Si profilava anzi una sconnessione tra legami internazionali e contesto domestico. L’opposizione togliattiana al centro-sinistra aveva registrato come principale successo la forte tenuta del partito, dimostrata dall’avanzamento elettorale del maggio 1963, particolarmente importante nelle «regioni rosse». C’era però un rovescio della medaglia. Il Pci restava emarginato dal gioco politico, mentre la stagione riformatrice conosciuta dal paese, con tutti i suoi limiti, aveva creato anche divisioni tra i suoi dirigenti. La presa dei miti sovietici sembrava per la prima volta declinante nelle nuove generazioni, che subivano piuttosto il fascino del terzomondismo. Nel ventennio passato il legame con il «campo socialista» aveva prodotto effetti positivi o negativi, dal punto di vista dei comunisti italiani, ma sempre in uno stretto rapporto tra le dimensioni nazionale e internazionale. Ora quel circuito sembrava incepparsi. Per il gruppo dirigente italiano, che aveva concepito il proprio ruolo postulando un’interazione dinamica tra le due dimensioni, ciò era fonte di serie incertezze. La mobilitazione per il Vietnam acquisí centralità anche per questo motivo. Essa associava il Pci a un variegato fronte di opposizione alla guerra che presentava connotazioni transnazionali in Europa, negli Stati Uniti e altrove. Lo spazio simbolico rappresentato dal Vietnam e dalla promozione di un “antiamericanismo globale” occultava, anche se non sanava, il senso di un declino dell’internazionalismo comunista. Esso costituiva una risorsa aggregante nella politica nazionale, volta a difendere il ruolo del partito di massa come polo antagonista e a trovare punti di contatto con settori influenti del mondo cattolico, contrari all’escalation della guerra11.
Il conflitto tra le principali componenti del partito rappresentate da Amendola e da Ingrao rifletté insieme le tensioni nazionali e internazionali. Amendola concentrò le proprie visioni su scelte di politica nazionale, quali il rapporto unitario con il Psi, e sulle prime aperture alla Comunità Europea, mentre Ingrao impegnò la propria voce prevalentemente sulla mobilitazione sociale e il nuovo impulso popolare e operaio emerso all’inizio del decennio. Centrale era la questione del «modello di sviluppo» e l’interpretazione del boom economico, che già da alcuni anni alimentava i dibattiti circa la persistente arretratezza del capitalismo italiano o la sua trasformazione «neocapitalistica»12. La divisione tra i due dirigenti, non piú mediata dalla personalità di Togliatti, fu un riflesso della tensione tra il partito «di governo» e il partito «di lotta» che rispecchiava la dinamica fisiologica di una forza di opposizione, accentuata dalla realtà della «democrazia bloccata». Tuttavia, le figure di Amendola e Ingrao rappresentavano anche visioni internazionali diverse e tendenzialmente inconciliabili. Amendola riteneva che il movimento comunista occidentale si trovasse in un vicolo cieco e che per questo fosse necessario il progetto di un nuovo partito del movimento operaio in chiave europea. Egli aveva però appreso la lezione di Togliatti contro il rischio di sopravvalutare l’esperienza italiana e manteneva fermo il legame con l’Unione Sovietica, limitandosi ad accentuare il giudizio sulla fine del suo modello universale13. Ingrao e la sinistra marcavano una maggiore discontinuità da Togliatti distaccandosi di fatto dall’imperativo della «coesistenza pacifica» e dalle sue implicazioni moderate, malgrado i compromessi congressuali. La conseguenza era di accentuare la critica dello stalinismo e delle socialdemocrazie, tematizzare la rivoluzione nei paesi a capitalismo avanzato e pensare l’Italia come un laboratorio politico14.
L’autentica questione che affiorava nel principale partito di massa occidentale non era tanto la spaccatura tra ortodossia sovietica ed eresia maoista, che oltretutto non aveva generato alcuna seria minaccia di scissione filocinese, quanto la divergenza tra visioni e linguaggi che gravitavano in modi diversi attorno alle nozioni di «coesistenza pacifica» e di antimperialismo senza appiattirsi su modelli precostituiti. Entrambe le nozioni presentavano declinazioni sfaccettate. La realistica presa d’atto della crescita economica favorita dall’Europa comunitaria e delle sue sensibili ricadute sull’Italia si legava alla prospettiva della distensione bipolare. Le letture dei rapporti internazionali nella chiave del «neocolonialismo» e il bagaglio stesso dell’antiamericanismo si riproducevano ma conoscevano anche mutazioni. Le risposte globali alla guerra in Vietnam e la loro molteplicità culturale, inclusa la protesta di massa negli Stati Uniti, dovevano costituire il principale catalizzatore per molti anni15. In altre parole, la cultura politica dei comunisti italiani presentava una pluralità di visioni e forme di contaminazione che non potevano ricondursi allo schema dicotomico indotto dalle due potenze comuniste. I nessi internazionalisti tradizionali si stemperavano e si rivelavano privi di autentici risvolti operativi, pur nell’appartenenza al «campo socialista». Vista dalla prospettiva italiana, la rottura tra Mosca e Pechino appariva parte di un fenomeno multiforme, il mutamento molecolare e generazionale di visioni, culture e identità che stava facendo massa prima dell’esplosione del «Sessantotto globale».
Il disorientamento per l’eclisse dell’internazionalismo comunista generò una crescita di iniziative e contatti non sempre chiaramente regolati da una bussola politica. Longo seguí le principali coordinate impostate da Togliatti e sviluppò le reti di relazioni del Pci, ma nella sua azione è difficile vedere le tessere di un progetto ispirato al policentrismo, che del resto non gli era stato congeniale neppure negli anni precedenti. L’effetto immediato, come appare anche dalle memorie di Carlo Galluzzi, successore di Giuliano Pajetta quale responsabile della Sezione esteri, fu quello di un riavvicinamento ai sovietici, che tendeva a ricomporre il relativo distanziamento creato dal «memoriale» di Togliatti. A questo fine Longo incontrò Brežnev nel marzo 1966 al XXIII Congresso del Pcus, mentre i rapporti con il Pcf restavano su un piano assai generico16. L’iniziativa piú impegnativa presa dal Pci riguardò però il possibile negoziato sulla guerra in Vietnam. La questione aveva acquisito ormai una rilevanza sul teatro diplomatico e collegava direttamente la politica interna con l’internazionalismo. La posizione del governo guidato da Aldo Moro in Italia, che espresse «comprensione» verso il massiccio intervento militare deciso dall’amministrazione Johnson, apriva uno spazio ai comunisti, che sostennero una missione volontaristica di La Pira, in contrasto con la linea ufficiale del governo. La missione fu un fallimento e provocò anzi una reazione negativa di Washington, ma i comunisti si inserirono nel gioco politico e nelle contraddizioni dei governi di centro-sinistra, trovando intese con Fanfani nella veste di ministro degli Esteri e incontrando la sensibilità di Nenni17. Dopo una serie di contatti con i sovietici e i polacchi, il gruppo dirigente italiano preparò una missione a Hanoi. L’incontro di Longo con Brežnev dell’agosto 1966 fu dedicato a questo obiettivo e alla mobilitazione per il Vietnam. La delegazione italiana chiese e ottenne anche sostegno finanziario per la propria stampa18. Tre mesi dopo si svolse il viaggio di Berlinguer in Vietnam, preceduto da una sosta a Mosca dove i delegati italiani constatarono una volta di piú la gravità del conflitto con Pechino e la crescente tensione tra le due potenze comuniste per esercitare un’influenza su Hanoi. Le conversazioni con i dirigenti vietnamiti confermavano invece il loro pragmatismo e il rifiuto di scegliere tra Mosca e Pechino19.
L’iniziativa del Pci affiancò la cosiddetta «operazione Marigold», concertata tra l’Italia e la Polonia e rivolta a esplorare le condizioni di una soluzione pacifica in Vietnam, in una combinazione di diplomazie parallele che coinvolse anche il Vaticano20. In realtà, i dirigenti vietnamiti si mostrarono poco propensi all’apertura di trattative e determinati a seguire fino in fondo l’obiettivo dell’unificazione del paese. I tentativi diplomatici del Pci sarebbero proseguiti senza successo nei mesi successivi21. L’iniziativa sul Vietnam mostrò maggiore successo nel teatro nazionale, dove il Pci riuscí a incalzare il governo di centro-sinistra collegandosi a cospicui settori del nascente dissenso cattolico e dei socialisti. La mobilitazione per la pace fu rafforzata dalle posizioni, pur minoritarie, di esponenti della Chiesa cattolica. Il significato del Vietnam era di inserire i comunisti in un fronte simbolico che confortava l’idea di una graduale fuoriuscita dagli schemi binari della guerra fredda22.
Nello stesso tempo, la mobilitazione antimperialista ebbe l’effetto di portare il Pci su posizioni piú vicine a Mosca. Era ormai emersa una precisa linea dei successori di Chruščëv. I nuovi leader sovietici tenevano ferma l’idea della distensione bipolare ma accantonavano la competizione ideologica e modernizzatrice con l’Occidente e ridimensionavano persino le alleanze con le élite nazionaliste nel Terzo Mondo. Puntavano invece a legittimare la propria sfera d’influenza in Europa, ad accrescere la presenza geopolitica nel Mediterraneo e a mantenere la fedeltà dei principali partiti comunisti in funzione anticinese, specie nel Terzo Mondo. La loro linea generò un gelo nelle relazioni con Tito, che si rifletteva sul Pci e danneggiava una delle piú importanti connessioni stabilite da Togliatti. Nel gennaio 1967 Longo tentò inutilmente di convincere Tito a partecipare a una conferenza dei comunisti europei, invocata da Mosca come il primo passo verso una conferenza internazionale sul tema della «sicurezza europea». Gli iugoslavi dissentivano dall’idea di una conferenza di soli partiti comunisti e criticarono il mancato invito di movimenti progressisti, ritenendo che anche una conferenza mondiale avrebbe avuto il medesimo problema23. In sostanza, le prospettive evocate nell’incontro fra Togliatti e Tito di tre anni prima sembravano sfumare. Il gruppo dirigente italiano ne era consapevole, ma ciò che contava era la rendita di posizione ereditata da Togliatti e la vicinanza ristabilita con Mosca e Parigi. Berlinguer sostenne che si dovevano condividere le preoccupazioni di Mosca per le spinte centrifughe generate dalla Cina, mentre le posizioni del Pci non avevano nulla a che fare con quelle autonomiste rumene ed erano anche distanti da quelle iugoslave. A suo giudizio, il Pci avrebbe comunque dovuto prendere parte alle conferenze, senza «precipitarsi troppo dato il peso della nostra posizione». «Il nostro prestigio internazionale», affermò, «è molto legato a una posizione del genere, anche se è un po’ scomoda e non bisogna tirare troppo la corda»24. Longo prese le distanze dalle posizioni iugoslave in un colloquio con Nikolaj Podgornyj, che insieme a Brežnev e Aleksej Kosygin formava la trojka dei successori di Chruščëv, pur riconoscendo che esse avevano «qualche fondamento»25. Egli ottenne da Brežnev un rinvio della conferenza mondiale, ma non l’allargamento oltre i confini del movimento comunista26.
Sul piano pubblico, Berlinguer pose l’accento una volta di piú sulla mobilitazione per il Vietnam nella prospettiva di coinvolgere movimenti di liberazione del Terzo Mondo, mentre l’idea di recuperare i cinesi era ormai sepolta27. La Conferenza dei partiti comunisti europei dell’Est e dell’Ovest svoltasi a Karlovy Vary, in Cecoslovacchia, nell’aprile 1967, mostrò le spinte centripete generate in Europa dalla mobilitazione antimperialista e dal rigetto della rivoluzione culturale cinese. Il Pci finí per compiere un passo in piú nel suo riaccostamento al «campo socialista» e condivise l’impostazione paneuropea, che ostacolava ogni possibile apertura all’integrazione europea occidentale28. L’idea di includere nelle conferenze comuniste «forze progressive» socialiste, cattoliche e di varia ispirazione, in Europa come nel Terzo Mondo, rimase sulla carta anche per l’opposizione dei francesi. Secondo Galluzzi l’unico risultato della conferenza fu una cauta apertura verso la Germania occidentale, sollecitata dagli italiani29.
Questo spiraglio consentí ai comunisti italiani di proporsi come mediatori tra Spd e Sed. Il loro tramite fu Leo Bauer, ex comunista e combattente in Spagna, che aveva un rapporto diretto con Willy Brandt, segretario della Spd e ministro degli Esteri nel governo di coalizione di Bonn. Un incontro informale ebbe luogo a Roma il 29 e il 30 novembre 1967 tra delegazioni guidate da Egon Franke e da Berlinguer30. Il terreno comune era rappresentato dalla distensione. Un secondo incontro svoltosi a Monaco nel gennaio 1968 tra Galluzzi, Sergio Segre, Leo Bauer ed Egon Bahr, figura di spicco della Spd, consolidò il reciproco scambio e questa volta i comunisti italiani ottennero un’apertura della Sed31. Gli incontri tra Pci e Spd non erano privi di un significato politico, perché mostravano come in Europa occidentale i comunisti italiani fossero l’unico interlocutore apprezzabile per le socialdemocrazie. Tuttavia, essi rimasero relegati a una contingenza. L’interesse della Spd per il Pci era limitato da considerazioni di politica interna, ma anche strumentale all’obiettivo mirato di allacciare rapporti con la Sed, poi superato dalla formazione di un governo socialdemocratico e dal lancio della Ostpolitik alla fine del 1969. I comunisti italiani nutrivano un ottimismo irrealistico circa la possibilità di allacciare rapporti con le socialdemocrazie a fini di politica interna e persino di poter considerare l’esperienza della Grosse Koalition in Germania occidentale come un precedente possibile per l’Italia. Cosí la mediazione tra Sed e Spd doveva restare un episodio nella loro fitta attività internazionale e non aprí la strada a nuovi rapporti con le socialdemocrazie. Tuttavia, proprio il lancio della Ostpolitik doveva mettere in moto una dinamica destinata a influire sulle loro scelte.
Il Pci poteva comunque vantare una rete di relazioni invidiabile per un partito non governativo, oltre i confini del proprio mondo di appartenenza e prevalentemente fuori dal continente europeo. Oltre che con Tito, i dirigenti italiani dialogarono, tra l’altro, con personalità come Nasser, Le Duan e Fidel Castro, stabilirono rapporti con il governo di Houari Boumedienne in Algeria e con il partito ispirato al socialismo nazionale Baath in Siria, incontrarono delegati dei movimenti di liberazione palestinesi, estesero i propri collegamenti in Etiopia e Somalia, nell’Africa coloniale portoghese e nell’Africa postcoloniale francofona, mantennero rapporti in America Latina. Il problema era però il senso di una crisi della decolonizzazione in Africa e nel Mediterraneo, comprese le speranze di nuove «vie al socialismo» nutrite nella prima metà del decennio. Romano Ledda pose la questione anche in relazione alle aspettative dei comunisti europei, osservando che le indipendenze nazionali non avevano risolto i problemi di costruzione dello Stato e di emancipazione economica dagli ex imperi, con il risultato che si assisteva a una «balcanizzazione» dell’intero continente. La questione posta da Ledda rimandava anche agli effettivi risultati della presenza sovietica in Africa, sebbene egli evitasse di menzionare la questione pubblicamente. Sembrava cosí emergere una consapevolezza dei limiti del «modello di sviluppo» sovietico proposto nel continente, in particolare a proposito degli squilibri tra industrializzazione e agricoltura32. Non era però chiaro il posizionamento dei comunisti italiani circa i mutamenti strategici introdotti dai successori di Chruščëv nel rapporto con il Terzo Mondo, che tendevano a una crescente militarizzazione della presenza sovietica.
Gli scenari immaginati nel Mediterraneo cambiarono radicalmente con il colpo di Stato militare in Grecia e soprattutto con lo scoppio della Guerra dei sei giorni in Medio Oriente, nel giugno 1967. La presenza della potenza sovietica in opposizione al «neocolonialismo» americano e al «sionismo» israeliano si sovrappose alle realtà «progressiste» di Egitto, Siria e Algeria, ma in realtà tramontava la visione del Mediterraneo «mare di pace». I comunisti italiani assunsero posizioni filoarabe e antisraeliane, sebbene affermando il riconoscimento dell’esistenza dello Stato d’Israele. Napolitano criticò con moderazione le posizioni prese da Moro all’Onu per un’attenzione inadeguata alla questione palestinese33. Si fece però strada una visione del sionismo volta a denunciarne il carattere di «nazionalismo aggressivo»34. Il Pci continuò a privilegiare le relazioni con l’Algeria e con Egitto e Siria, che costituivano la Repubblica araba unita, oscillando tra il sostegno alla presenza sovietica nel Mediterraneo, vista come un contrappeso all’imperialismo americano, e il tentativo di mantenere il filo del dialogo con i non allineati35. In questo contesto, il partito costituiva un agente transnazionale che contribuí alla circolazione delle idee contro il «neocolonialismo», miranti a mettere in discussione l’ideologia dello sviluppo come processo universale e a promuovere la redistribuzione delle risorse in favore degli Stati postcoloniali nell’economia globale36. Un momento significativo fu la Conferenza sul Mediterraneo svoltasi a Roma nell’aprile 1968, con la partecipazione di partiti comunisti e socialisti, dell’Fln algerino, del Baath siriano, che consolidò l’autorità internazionale del Pci e la sua diplomazia parallela alla politica estera dell’Italia nel Mediterraneo, rivolta a fare pressione sulle forze governative per un maggiore impegno sul problema dello sviluppo37.
Tuttavia, il senso di un disegno piú complessivo si era chiaramente indebolito rispetto all’inizio del decennio. La rappresentazione dei «tre fronti» della lotta antimperialista fatta propria da Longo (Medio Oriente, Vietnam, America Latina) costituiva un’ammissione di fatto che l’idea di una soggettività emergente dal Terzo Mondo si stava perdendo38. L’equilibrio immaginato nel paradigma del policentrismo tra le grandi diversità culturali, economiche, geopolitiche dell’universo postcoloniale e il denominatore comune dell’antimperialismo politico appariva sempre piú difficile da trovare. Le idee di unità terzomondista si dividevano tra la versione guevarista, che negava qualsiasi ruolo di rilievo al comunismo occidentale, e la ricerca di una piattaforma unificante sul tema del sottosviluppo, propria piú dei non allineati che dei comunisti39. La distensione aveva perduto il significato di una sfida alle classi dirigenti occidentali e subiva invece una contestazione persino tra i dirigenti italiani. Il potenziale della “riscoperta” del Terzo Mondo si era esaurito, mentre l’influenza degli interessi geopolitici sovietici si faceva molto piú sensibile nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. La fine dell’unità del comunismo internazionale, come Togliatti aveva profetizzato, riduceva lo spazio della politica e alimentava forme di intransigenza ideologica. L’attacco maoista al comunismo sovietico si rivelava inefficace come progetto di un movimento alternativo ma molto incisivo come linguaggio critico delle «nuove sinistre» ispirate dalla nozione del conflitto tra Nord e Sud del mondo. In Europa, il ruolo del comunismo come alternativa alla socialdemocrazia era da costruire. La mobilitazione antimperialista finiva per costituire un fattore di politica interna piú che favorire la funzione di ponte tra le due Europe e nel Mediterraneo. La costruzione di reti transnazionali rappresentava una risorsa relazionale e una diplomazia parallela influente nelle dinamiche nazionali, piú che l’intelaiatura di un progetto politico. Il «Sessantotto globale» doveva mettere a nudo le cospicue difficoltà del Pci a riorganizzare una propria visione strategica dopo la scomparsa di Togliatti, ma fu anche l’occasione per una risposta destinata a modificare sensibilmente i termini stessi del problema.
2. La «primavera di Praga».
Per i comunisti italiani, l’epicentro del «Sessantotto globale» si collocò nell’Europa centro-orientale. Tra il marzo e il maggio 1968, le riforme messe in atto dalla nuova leadership cecoslovacca guidata da Alexander Dubček si imposero all’attenzione internazionale e dettero vita a un’esperienza destinata a segnare speranze e disincanto dei comunisti in Europa e in Russia. Il gruppo dirigente insediato alla fine del 1967 riportò in auge a Praga la nozione della riforma politica che era stata rimossa dopo la repressione a Budapest dodici anni prima. Le riforme “dall’alto” ruppero gli argini delle innovazioni tecnocratiche ed economiche e suscitarono un risveglio sociale rivolto a istanze di libertà che erano sembrate inabissarsi. Le differenze con il 1956 erano rilevanti. La «primavera di Praga» si svolgeva in un contesto pacifico e sotto l’impulso dei comunisti, facendo emergere correnti sotterranee rimaste silenti. Protagonisti quali Zdeněk Mlynář, il principale portavoce dell’idea di una democrazia socialista basata sul riequilibrio dei rapporti tra società e Stato, rappresentavano la generazione che si era formata negli anni della destalinizzazione. Fu subito evidente che le ambizioni dei riformatori cecoslovacchi non si limitavano ad aggiungere una variante di «comunismo nazionale» a quelle ungherese o polacca. Il loro socialismo umanistico non era confinato al contesto geopolitico dell’«impero esterno» sovietico. Esso segnava l’apice della destalinizzazione all’Est, ma presentava anche una dimensione transnazionale caratterizzata dalla crescente permeabilità della «cortina di ferro» e dall’intersezione con le mobilitazioni spontanee del Sessantotto.
La «primavera di Praga» restituí ai comunisti italiani il senso di una missione, offuscato nei primi anni dopo la morte di Togliatti. Il loro giudizio sul corso riformatore di Dubček, a cominciare dalle misure che abolivano la censura di Stato e aprivano la strada a una liberalizzazione, fu volto a stabilire una consonanza di visioni e aspettative. Longo dichiarò pubblicamente il sostegno alla creazione di una «democrazia socialista progressiva» e inserí fra i tratti costitutivi di tale obiettivo non soltanto la libertà e la democrazia ma anche «l’umanità»40. Egli fu il primo leader comunista occidentale a visitare Praga dopo l’inizio delle riforme. Il suo incontro con Dubček si svolse all’insegna della democrazia socialista. Il leader italiano dichiarò che il suo partito non cercava modelli, ma riconobbe il significato dell’esperienza cecoslovacca per il socialismo mondiale, dandone «un apprezzamento molto alto»41. Il giorno dopo, in una riunione a porte chiuse dei «cinque» del Patto di Varsavia, senza i cecoslovacchi, Brežnev paventò che le affermazioni di Longo fossero sfruttate dalle «forze insane» in Cecoslovacchia, dato il loro accento sulla «liberalizzazione» e sul «nuovo modello»42. Anche i comunisti francesi, rumeni e iugoslavi sostenevano Dubček, ma i dirigenti italiani si distinsero per la propria empatia, che accomunava tendenze diverse nel partito, dai moderati ai movimentisti43.
Il consenso di alcuni attori importanti del mondo comunista non fu però sufficiente a salvaguardare i riformatori praghesi. I sovietici e i principali leader dell’Europa orientale lessero le riforme come una perdita di controllo e un pericolo di contagio. Tra la fine di giugno e la fine di luglio, quando i dirigenti italiani si incontrarono piú di una volta con esponenti del Pcus, divenne concreto il sentore che le intimidazioni potessero tradursi in fatti. I sovietici respinsero o ignorarono l’argomento di Longo che l’esperienza dei riformatori praghesi avrebbe rafforzato il socialismo, temendo la congiunzione con le posizioni critiche di parte iugoslava. Gli italiani furono prudenti ma fermi nel respingere l’uso della forza. Pajetta riconobbe la legittimità delle preoccupazioni di Mosca dichiarando però che il Pci non avrebbe accettato un intervento militare44.
L’invasione della Cecoslovacchia da parte del Patto di Varsavia nella notte del 20-21 agosto non colse i comunisti italiani di sorpresa, sebbene essi avessero sperato nel compromesso che era sembrato delinearsi all’inizio del mese a Bratislava. La decisione di Longo, che si trovava a Mosca, di esprimere «dissenso» dopo convulse telefonate con Roma fu immediata e segnò la prima aperta dissociazione dei comunisti italiani dall’Unione Sovietica45. Alla presenza di Longo, la Direzione tenutasi il 23 agosto articolò un ventaglio di posizioni destinate a permanere nel tempo, a cominciare dall’idea che l’intervento militare avesse inferto un duro colpo alla credibilità dell’intero movimento comunista. In particolare, Bufalini affermò l’esigenza di «una egemonia anche ideale dei partiti dell’Europa occidentale», che implicava sfiducia verso un futuro impulso positivo proveniente dal «campo socialista» perché «in quei paesi il socialismo si è realizzato in certe condizioni, autoritarie»46. I comunisti italiani non erano isolati, dal momento che anche i francesi, i britannici e i norvegesi presero le distanze dall’invasione della Cecoslovacchia. Ma furono i piú coerenti nel difendere le proprie posizioni.
Il punto che accomunava i dirigenti italiani era esercitare una critica della scelta di Mosca non soltanto sotto il profilo dell’autonomia e della sovranità nazionale, ma anche a proposito della nozione di internazionalismo, messa a dura prova dall’uso della forza imperiale nell’Europa centro-orientale. Nel Comitato centrale che si svolse mentre Dubček e i suoi collaboratori erano detenuti a Mosca, alla fine di agosto, Longo ribadí la prossimità delle idee dei comunisti italiani a quelle dei riformatori praghesi, accomunandole nella visione universalista volta ad «arricchire di nuovi valori e di nuovi contenuti di libertà tutta l’esperienza socialista», per creare «un socialismo moderno, aperto, profondamente umano»47. Cosí il vecchio combattente della guerra di Spagna consegnò ai propri compagni un lemma nuovo, che ereditava il codice principale della «primavera». La sua implicazione era che il socialismo di tipo sovietico non corrispondesse affatto a quella immagine e che i carri armati a Praga fossero triste testimonianza di una logica e una realtà diverse. Il fatto era che sino ad allora il gruppo dirigente comunista non aveva mai fatta propria una simile implicazione. I quadri e i militanti si erano formati nella convinzione che la logica dei blocchi fosse stata imposta dall’Occidente ma rappresentasse anche una bussola da seguire per motivi di solidarietà internazionale e di classe, come era accaduto al tempo della tragedia ungherese. L’idea che l’ordine bipolare fosse sempre meno adeguato a riflettere i mutamenti globali, affermata dal «memoriale» di Jalta, non aveva modificato in profondità una simile visione. Per la prima volta dalla nascita del «partito nuovo», il gruppo dirigente si trovò dinanzi a scelte che costituivano una logica evoluzione ma implicavano una possibile frattura di componenti del proprio corpo politico e sociale, tuttora sotto l’influenza di pedagogie e narrazioni ortodosse dell’internazionalismo48.
I dirigenti italiani si posero il compito di restituire senso a tale nozione. Essi dovevano evitare che le posizioni assunte contro la repressione in Cecoslovacchia suonassero come una sconfessione di quelle fatte da Togliatti nel 1956. Il rifiuto dello «Stato guida» non era però piú sufficiente. Occorreva trovare un punto di equilibrio che consentisse, come voleva Longo, di esprimere dissenso senza arrivare a una rottura con Mosca. È indicativo che i comunisti italiani non si limitarono a tenere ferme le loro posizioni nelle feroci polemiche suscitate dall’invasione della Cecoslovacchia nell’opinione pubblica nazionale, fronteggiando sia le critiche del fronte anticomunista tradizionale sia gli attacchi della «nuova sinistra». Essi promossero un’iniziativa diplomatica tra i partiti comunisti europei. Pajetta, Galluzzi, Berlinguer e Pecchioli svolsero consultazioni a Parigi, Londra, Budapest, Belgrado, Bucarest, Varsavia e Berlino, tessendo una rete consensuale con i comunisti francesi, britannici, rumeni e iugoslavi. Questi ultimi invitarono gli italiani a prendere atto che l’Unione Sovietica stava tornando a una politica di «grande potenza», volta a compattare il «campo socialista» con l’obiettivo di dividere il mondo in sfere d’influenza con gli Stati Uniti, e si dissero preoccupati per una possibile invasione militare del Patto di Varsavia. A Mosca fu inviato Cossutta, coordinatore della segreteria e incaricato dei rapporti finanziari. Egli riferí che Suslov giudicava «ingiustificata» la posizione del Pci sul piano internazionale, chiedeva conto della missione di Pajetta a Bucarest, dato che il leader rumeno Nicolae Ceauşescu si era astenuto dall’intervento a Praga, e drammatizzava il rischio di una lacerazione prodotta dalla eventuale aggregazione di un polo europeo49. La reazione piú dura all’intransigenza sovietica, che come sempre equiparava il dissenso all’insubordinazione, fu quella di Berlinguer. Egli si disse non «del tutto» convinto dall’analisi iugoslava, ma parlò di una «fase nuova» che riguardava anche «la nostra collocazione nel movimento comunista» e non escluse la possibilità di una «lotta politica con i compagni sovietici». Una simile lotta evidentemente implicava proprio la possibilità di costruire un polo comunista occidentale50.
Gli interventi pubblici di dirigenti quali Amendola e Ingrao mostrarono che il tema dell’internazionalismo poteva però anche dividere il comunismo italiano, non semplicemente lungo le linee dell’ortodossia e dell’autonomia. Le diverse calibrature dei rispettivi interventi tracciavano il perimetro delle possibilità ma anche lo scenario di una frattura. Amendola ribadí il concetto togliattiano delle diversità del socialismo nel mondo, con un forte accento sulla «crisi generale del capitalismo» evidenziata dal Vietnam. La sua proposta politica si fissava sul tema della «coesistenza pacifica» non come «divisione del mondo in sfere d’influenza» ma come una forma di internazionalismo fondata sul «non intervento»51. Ingrao ignorò invece la nozione di «coesistenza pacifica» e incentrò il proprio intervento sul rilancio del nesso tra «democrazia di massa» e sviluppo «di tutto il fronte antimperialista», oltre i confini del «campo socialista»52. La due posizioni non rivelavano soltanto una divergenza già consolidata da tempo ma anche visioni diverse del «Sessantotto globale», che si manifestavano nei giudizi opposti sul movimento studentesco, rispettivamente di diffidenza e di apertura. La gestione della crisi seguita all’invasione della Cecoslovacchia chiedeva perciò di comporre traiettorie divergenti.
Alla fine di settembre, l’enunciazione ufficiale della dottrina della sovranità limitata nella «comunità socialista», da allora nota come «dottrina Brežnev», consolidò di riflesso il dissenso dei comunisti italiani. Tra ottobre e novembre la tensione tra le due parti raggiunse punte senza precedenti, malgrado la reciproca volontà di evitare rotture. Le pressioni di Mosca ebbero l’effetto opposto a quello ottenuto sui comunisti francesi, che tornarono sui propri passi. Dopo un incontro a Budapest, Berlinguer informò la Direzione che i sovietici presentavano il Pci come il soggetto «piú pericoloso» e tendente a «un modello astratto di socialismo». Suggerí di intensificare l’attività internazionale in Europa occidentale, incluse «altre forze di sinistra», ma anche in Africa e in Medio Oriente, pensando a una conferenza sul Vietnam53. Una seconda missione a Mosca di Cossutta non modificò lo stato delle cose. Soltanto Pajetta invocò «un accordo di non belligeranza». Ingrao gli obiettò che «la via della ricerca del compromesso si è rivelata impraticabile per come sono andate le cose». Bufalini invitò a rifiutare «ogni ricatto» e a considerare la possibilità di un mutamento radicale dei rapporti con Mosca, compresa la fine dei finanziamenti. Berlinguer avvertí che «il nostro rapporto con il Pcus non potrà piú essere quello di prima» e si preoccupò della «preparazione psicologica dei compagni», riconoscendo che «siamo in ritardo da questo punto di vista»54.
Con simili premesse, colpito Longo da una seria infermità, Berlinguer si recò a Mosca tra l’11 e il 13 novembre 1968. Egli tenne fermo il mandato del gruppo dirigente, che era di riconoscere le rispettive posizioni e divergenze. Ribadí il «dissenso», criticò l’«ingerenza» del Patto di Varsavia e mise in dubbio la «normalizzazione» in Cecoslovacchia, senza lasciarsi impressionare dalle filippiche paternaliste dei sovietici sulla solidarietà internazionalista. La loro visione era che i partiti comunisti critici dell’intervento fossero soggetti a «tendenze nazionaliste», come in Romania e in Iugoslavia, e che le attività «controrivoluzionarie» in Cecoslovacchia fossero da porre in rapporto alla guerra americana in Vietnam. Mosca applicava meccanicamente a Praga e al Vietnam il nesso stabilito nel 1956 tra Budapest e Suez. Tuttavia, questo argomento non fu sufficiente a irretire e persuadere i comunisti italiani a compiere una marcia indietro55. Tornato a Roma, Berlinguer riferí di aver fronteggiato pressioni pesanti, ma non fino a un punto di rottura, e anche che «privatamente alcuni compagni della Sezione esteri ci invitavano a tenere duro»: un dettaglio tutt’altro che trascurabile nella prospettiva di esercitare influenza senza fare concessioni di principio56. L’incontro tra Berlinguer e Suslov nel gennaio 1969 non spostò di una virgola i termini della questione. Anzi, l’ideologo numero uno di Mosca minacciò di disertare l’imminente XII Congresso del Pci, un atto dirompente nelle liturgie comuniste. Berlinguer riferí a Roma che l’incontro aveva soltanto mostrato l’incomprensione sovietica per le posizioni italiane57.
La scelta di assegnare a Berlinguer la gestione dei rapporti con Mosca dopo l’agosto 1968, fatta da Longo, equivaleva a una vera e propria investitura per la successione. Il cambio di generazione, che escluse dalla leadership Amendola e Ingrao, fu una soluzione adottata per impedire la cristallizzazione di un dualismo emerso da tempo e incrementato dagli eventi del 1968. Ma Berlinguer poteva anche vantare un’esperienza internazionalista piú solida di Amendola, che non aveva mai davvero praticato quel terreno, e piú recente e intensa di Ingrao, che aveva fatto in tempo a praticare gli ambienti del Cominform ma diradato le proprie frequentazioni dopo la Conferenza di Mosca del 1957. Leader della gioventú mondiale comunista tra il 1950 e il 1953, Berlinguer aveva partecipato alla conferenza del 1960 e svolto un cospicuo numero di missioni a Mosca, nell’Est europeo e altrove. In altre parole, l’emergere della sua autorità nel 1968 fu strettamente legato all’eredità internazionalista del comunismo italiano58.
Longo e Berlinguer confermarono in sede congressuale la posizione critica del Pci su Praga. Longo rispose all’invito del segretario socialista Francesco De Martino, che auspicava la definizione di una linea politica adeguata «alla configurazione di un socialismo dal volto umano», dichiarando che era appunto quello «il nostro sforzo e il nostro obiettivo»59. Ciò rafforzava i comunisti italiani nel teatro nazionale, dove i loro avversari potevano denunciare le cautele eccessive del lessico critico all’indirizzo di Mosca ma non ignorare la novità rispetto al 1956. Era però evidente il loro isolamento internazionale. Il «socialismo dal volto umano» non aveva fatto breccia nel mondo comunista e la sua repressione fu assorbita come un atto giustificato dalla guerra fredda globale. In Europa occidentale i comunisti dissidenti erano pochi e insignificanti, mentre i francesi avevano gettato la spugna60. Fuori d’Europa, nessun partito comunista si era espresso contro Mosca, salvo i cinesi per motivi meramente strumentali alla denuncia dell’imperialismo sovietico. Gli unici interlocutori forti, gli iugoslavi, costituivano un partner ostinatamente estraneo al «campo socialista». I propositi di rilanciare un’iniziativa internazionalista si scontravano con questa realtà, che malgrado gli sforzi diplomatici e le connessioni intessute non aveva fatto sostanziali progressi dall’epoca della morte di Togliatti.
Ciò nonostante, i comunisti italiani tennero duro, nella persuasione che il loro dissenso costituisse un modo per modificare e riformare le relazioni nel mondo comunista. Si ritagliarono cosí una funzione speciale, che ne esaltava il ruolo di coscienza critica. Dovettero prendere atto che Mosca identificava il socialismo nel mondo con il «campo socialista» e che i loro tentativi di differenziare le due nozioni erano sinora falliti. Non per questo vi rinunciarono. La «primavera di Praga» aveva fatto intravedere un campo di possibilità che si era subito richiuso, ma poteva essere intesa come un fenomeno destinato a ripetersi. La loro missione divenne tenere aperta quella possibilità. Ciò implicava ora compiere una netta distinzione tra il riconoscimento della funzione antimperialista dell’Unione Sovietica, nel contesto dei movimenti postcoloniali globali, e il distacco dalle vecchie gerarchie di senso circa la «superiorità» del socialismo sovietico, improponibili non soltanto in Occidente ma anche nel Sud globale. Su questa base, i comunisti italiani si proposero di esercitare influenza nel movimento internazionale evitando di esserne messi ai margini. L’esercizio di una simile funzione era soggetto per definizione a un negoziato permanente e rischiava di farsi un dialogo tra sordi. Ma costituiva una forma di realismo politico riconosciuto persino da esponenti della sinistra socialdemocratica europea. Nella primavera 1969 si verificò un nuovo incontro al massimo livello tra Pci e Spd, che confermò il reciproco interesse per la distensione, malgrado la repressione sovietica in Cecoslovacchia, e il riconoscimento da parte di Brandt che gli italiani portavano avanti un «comunismo riformatore»61.
Quel posizionamento comportava però un prezzo da pagare. In nome del principio dell’«unità nella diversità», il Pci digerí la «normalizzazione» autoritaria in Cecoslovacchia, che rimosse definitivamente Dubček dopo averlo umiliato e trasformò in dissidenti perseguitati molti dirigenti riformatori e innumerevoli militanti. La decisione di prendere parte alla Conferenza mondiale del comunismo riunita a Mosca nel giugno 1969, rinviata molte volte per circa sette anni, anche per l’opposizione dei comunisti italiani, si configurò come una scelta precisa. Il piú deciso nel sostenere la necessità di evitare rotture fu Amendola, tra i dirigenti italiani il meno coinvolto nelle pratiche internazionaliste, ma anche per questo poco propenso a coltivare ambiziosi disegni di influenza transnazionale62. Proprio la sua critica di alcuni anni prima all’unanimismo costituí però una bussola di comportamento. Berlinguer si presentò alla conferenza con l’obiettivo di difendere il criterio che concezioni diverse potevano convivere all’interno del movimento comunista. Nel suo intervento, parlò di «una crisi dell’internazionalismo», criticò i cinesi sostenendo la distensione internazionale e toccò il tema sensibile della Cecoslovacchia, ribadendo il «grave dissenso» verso l’invasione63. La delegazione italiana rifiutò di sottoscrivere per intero la dichiarazione conclusiva comune, infrangendo le regole non scritte del movimento. La dissociazione degli italiani venne formalizzata a dispetto dell’unanimismo proprio della ritualità comunista. Su questo punto Berlinguer fu irremovibile e apparve allora ai massimi dirigenti sovietici come un osso duro e una personalità scomoda per la leadership di Mosca64. Riferendo alla Direzione del Pci, Berlinguer dichiarò che la manifestazione di divergenze era stata «uno shock», sebbene egli avesse preventivamente avvertito Brežnev precisando che il Pci non avrebbe posto il problema del ritiro dell’Armata rossa. Secondo informazioni in suo possesso, il gruppo dirigente sovietico aveva discusso sulle posizioni italiane e si era diviso tra i giudizi negativi di Brežnev, Suslov e Ponomarëv, da una parte, e quelli piú aperti di Kosygin, Podgornyj e Andrej Kirilenko. Era un risultato ai suoi occhi rilevante, anche se non induceva per il momento a ottimismo. «È difficile pensare», affermò, «che oggi, di colpo, la Direzione del Pcus passi ad ammettere la legittimità del dissenso e l’accettazione del principio dell’unità nella diversità». E aggiunse di non ritenere «che questo passaggio possa avvenire tranquillamente», perché «si pone poi il problema del dissenso anche all’interno, se si ammette sul piano internazionale»65.
In altre parole, i dirigenti italiani erano consapevoli dell’inconciliabilità tra il riconoscimento aperto delle diversità sul piano internazionale e la stabilità autoritaria dei regimi comunisti, che rendeva la loro strada particolarmente impervia. Scelsero di seguire una deliberata ambivalenza, affermando la continuità di rapporti tradizionalmente coltivati e nel contempo un legame con l’eredità della «primavera di Praga». L’ironia di Amendola colse nel segno quando indicò il rischio di sviluppare «il complesso del primo della classe». Ma non era la prima volta che i comunisti italiani si candidavano a questo ruolo. Diversamente da come doveva essere rappresentato nelle autonarrazioni postume, il Sessantotto praghese non fu l’inizio di un piano inclinato verso la risoluzione dei rapporti con Mosca. I comunisti italiani fecero una scelta diversa. Raccolsero la bandiera del «socialismo dal volto umano» per collocarsi al punto nevralgico delle dinamiche di riforma e conservazione aperte sino allora nel mondo comunista. Furono l’unico gruppo dirigente a connotarsi in chiave riformatrice quando tale visione era bandita nel «campo socialista» e in gran parte avversata nel Terzo Mondo.
La posizione espressa sulla Cecoslovacchia presentava un nesso preciso con la scena nazionale. Alla Direzione del 31 ottobre 1968, Berlinguer dichiarò che senza quella dissociazione da Mosca si sarebbe verificato un «totale cambiamento del quadro politico espresso dalle elezioni del 19 maggio», quando il Pci aveva ottenuto il migliore risultato della sua storia, sfiorando il 27 per cento dei voti66. Le parole di Berlinguer esprimevano un modo di vedere largamente condiviso nel gruppo dirigente. La consapevolezza cioè che la forza del comunismo italiano fosse ormai legata non soltanto alla capacità di difendere una sfera di autonomia, ma anche di prendere le distanze dal modello di socialismo sovietico. Poco dopo, in sede congressuale, precisò che i comunisti non avrebbero fatto la stessa scelta dei socialisti nel 1956 e non avrebbero sacrificato sull’altare del governo del paese il loro legame politico, ideologico e identitario con il «campo socialista». «La questione è ben diversa», dichiarò, «ed è quella di una riconferma e di un rilancio dell’internazionalismo […] in forme e con contenuti nuovi», volti a colmare il divario tra la potenzialità di un movimento variegato e dotato di una «dimensione universale» e il suo «peso effettivo» ancora non adeguato nella politica mondiale67. A suo giudizio, sul piano nazionale non si poneva la questione del governo ma quella di una diversa qualità della democrazia italiana, di una «democratizzazione del regime politico». Berlinguer rilanciò la sfida classica dell’assedio reciproco che caratterizzava i due blocchi politici e sociali della vita nazionale, puntando sulla spinta al cambiamento generata dal Sessantotto.
Si riproduceva cosí una tensione tra l’appartenenza internazionale e la dimensione nazionale, in termini però molto diversi dal passato. La forza del comunismo italiano non risiedeva infatti soltanto nella polarizzazione imposta dalla guerra fredda eurocentrica, che aveva nello stesso tempo contenuto il suo consenso sociale e consolidato la sua egemonia nella sinistra. Risiedeva nella diversità dagli altri comunismi, convincente per una porzione crescente dell’elettorato democratico italiano, e nella capacità di vivere e prosperare nella grande trasformazione del paese. Ciò costituiva una smentita delle tesi che la modernizzazione avrebbe reciso le radici del comunismo, sulla quale si era largamente fondato il progetto del centro-sinistra. Al contrario, il Pci mostrava una capacità di adattamento al primo impatto della società dei consumi, un radicamento sociale e territoriale formidabile nel centro Italia, una pratica riformatrice di governo locale68. Il partito di massa e il suo insediamento nella società italiana si confermavano come una decisiva eredità di Togliatti, che aveva ormai acquisito i caratteri di un pilastro del sistema politico mentre la classe dirigente tradizionale iniziava a mostrare i segni di una difficoltà e di un’assenza di prospettive. La secolarizzazione della società italiana non aveva messo il piombo nelle ali del comunismo italiano. Era sotto gli occhi di tutti la conversione in tempi rapidi della «religione politica» costruita nel dopoguerra in una forza piú laica e in grado di dare risposte alla richiesta di diritti moderni emergente dalla società italiana, in modo piú efficace del cattolicesimo politico e in competizione con i socialisti, da posizioni di vantaggio dopo la fine della stagione riformatrice del centro-sinistra. Quella forza prometteva perciò un’espansione quanto piú il Sessantotto avesse lasciato una traccia sensibile nella società italiana, sebbene la contestazione avesse anche messo a nudo gli elementi contraddittori e conservatori presenti nell’identità e nel corpo profondo del partito.
Tuttavia, i comunisti italiani intravedevano solo in parte la crisi dell’orizzonte esistenziale e concettuale bipolare destinata a caratterizzare il «Sessantotto globale»69. Essa rivelava, in realtà, il tramonto delle mitologie legate alla presenza dell’Unione Sovietica nel mondo. Il ritorno stesso del marxismo tra i giovani presentò tra i suoi elementi caratteristici la contestazione della natura dei sistemi di tipo sovietico oppure la semplice indifferenza per il loro significato. Il mito sovietico aveva smarrito per sempre la sua funzione di promessa del futuro e di speranza rivoluzionaria. Persino l’antiamericanismo traeva alimento dai simboli e dai linguaggi delle controculture americane, molto piú che dagli stereotipi della propaganda comunista tradizionale. La «comunità immaginata» del comunismo internazionale, dotata di un ethos, un linguaggio e un suo codice culturale, apparteneva ormai per molti aspetti al passato70. Ma tutto ciò non poteva essere semplicemente dismesso senza minacciare l’esistenza dell’identità comunista, anche per una forza come il Pci. Di qui la necessità di una narrazione del socialismo realizzato, e di quello da realizzare, volta a salvare il salvabile del suo passato e nutrire il bisogno di marcatori identitari, anche per fronteggiare la sfida della «nuova sinistra». L’idea della potenza sovietica come contrappeso pacifico all’imperialismo occidentale, la fiducia nella missione progressista delle società di tipo sovietico, la persuasione che una domanda di socialismo fosse intrinseca nei punti alti della modernità capitalistica, le aspettative tuttora riposte nelle forze antimperialiste del Terzo Mondo corrisposero a un simile bisogno. Il socialismo umanistico divenne cosí una «invenzione della tradizione» destinata a convivere con le narrazioni postmitologiche del socialismo sovietico, con la rimozione del suo volto disumano e con la ricerca di nuove forme di internazionalismo.
Tale evoluzione creò una dinamica precisa tra politica internazionale e nazionale. Mentre il gruppo dirigente si candidava a erede della «primavera» praghese, realizzò un giro di vite intollerante espellendo il gruppo del «manifesto» con il plauso dei sovietici71. Le due scelte erano coerenti tra loro. La difesa della «primavera» praghese non implicava infatti una rottura con il «campo socialista», che invece Rossanda, Magri, Pintor e gli altri esponenti della sinistra radicale invocavano, denunciando le ipocrisie di una «normalizzazione» sotto la minaccia dei carri armati. In sede congressuale, Rossanda aveva rinnovato la critica della «coesistenza pacifica» come pratica incentrata sugli interessi dell’Unione Sovietica e del blocco sovietico, invocando la loro subordinazione ai movimenti di liberazione e rivoluzionari72. Questi argomenti trovavano consenso tra i giovani politicizzati del Sessantotto e mettevano a nudo gli anacronismi del vecchio internazionalismo. Il gruppo del «manifesto» raccoglieva alcune tra le istanze piú libertarie delle controculture, poneva in discussione la stessa natura socialista dell’Unione Sovietica e, intanto, coltivava nuove mitologie della sinistra, di ispirazione maoista o castrista. Il gruppo dirigente decise di serrare le file del «centralismo democratico» come un modo per blindare il partito dalle influenze della «nuova sinistra» e dalle loro possibili conseguenze disgregative. La requisitoria di Natta contro il gruppo del «manifesto» nell’ottobre 1969 presentò due aspetti: il rigetto di una posizione che avrebbe isolato il Pci sul piano internazionale, dal «campo socialista» come dagli interlocutori tra i non allineati, e la dura reazione al rischio di una perdita di coesione del blocco politico e sociale comunista proprio nel momento del suo massimo consolidamento e quando l’insubordinazione sociale si estendeva dalle università alle fabbriche nell’«autunno caldo» del 1969. Esplicita fu la difesa del ruolo antimperialista svolto dall’Unione Sovietica, implicito il timore che l’abbandono della speranza nell’autoriforma dei paesi socialisti avrebbe significato un colpo mortale all’identità comunista73. Negli anni a seguire i comunisti italiani avrebbero piú di una volta ribadito il dissenso sull’invasione del 1968 e sulla dottrina della «sovranità limitata», mantenendo per molti aspetti intatti i loro rapporti con l’Est europeo, con l’eccezione della Cecoslovacchia. Sotto questo profilo, essi non erano degli autentici dissidenti, ma l’ala illuminata e minoritaria di un universo comunista postinternazionalista, composito e frammentato tra ortodossie, eresie, nazionalismi e antimperialismi.
3. Dopo il Sessantotto: ridefinire l’Europa.
All’indomani del biennio di movimento 1968-69, il comunismo italiano fu sottoposto alle influenze e tensioni contrastanti dei nuovi scenari nazionali, europei e globali. La prospettiva nazionale apparve incerta e fragile dopo la strage di piazza Fontana nel dicembre 1969, che innescò brutalmente la deriva della violenza politica nel paese. Si fece strada l’idea che l’eccezione costituita dall’Italia quale unica democrazia dell’Europa mediterranea, circondata dai regimi di destra in Spagna, in Portogallo e in Grecia, fosse sotto l’attacco di forze eversive che reagivano al Sessantotto con progetti di destabilizzazione finalizzati a un regime autoritario ed erano dotate di complicità sul piano internazionale. Tale percezione non era affatto infondata e inquadrava un pericolo autentico. Tornarono a esercitare una sensibile influenza immaginari della guerra fredda che non erano mai scomparsi dalla scena. L’amministrazione Nixon lesse le conseguenze del Sessantotto in Italia esclusivamente come un nuovo rischio di avvento dei comunisti al governo, giudicando retrospettivamente l’apertura al centro-sinistra come un errore74. Le percezioni comuniste e della sinistra recavano anche l’immaginario di una minaccia cospirativa annidata negli apparati dello Stato e nella Nato, con il rischio di un cupo pessimismo circa le sorti della democrazia. La conseguenza piú immediata della percezione della fragilità italiana fu la tendenza a delimitare, se non invertire, lo smarcamento del Pci dal «campo socialista», visto quale unica possibile rete protettiva. I sovietici colsero presto questa vulnerabilità dei comunisti italiani e cercarono di servirsene come uno strumento di persuasione e di ricatto per mettere fine al dissenso nato nel Sessantotto. Mosca attaccò ad esempio esponenti della politica estera del Pci come Galluzzi. Nell’ottobre 1970 questi venne sostituito nella piena continuità politica da Sergio Segre, noto per i suoi rapporti privilegiati con i socialdemocratici tedeschi75. La pressione sovietica si rivelò però controproducente, nel senso che stimolò una forma di orgoglio di partito e indusse i dirigenti a riaffermare l’acquisizione piena della legalità democratica come linea di difesa della sovranità italiana.
La visione pessimistica dell’Italia era, in una certa misura, controbilanciata dall’evoluzione dello scenario europeo. Il consolidamento della distensione europea dopo il lancio della Ostpolitik compiuto dal governo di Willy Brandt alla fine del 1969 favoriva il progetto di un inserimento dei comunisti nel contesto dell’Europa occidentale, che significava modificare il ruolo di ponte tra le due Europe, pur senza rinunciare a esercitarlo. Da tempo era chiaro come la legittimazione nazionale del comunismo italiano implicasse una modifica delle posizioni ostili all’integrazione europea, sebbene le visioni della dimensione sovranazionale si risolvessero in un generico auspicio sull’intesa paneuropea tra le due parti divise del continente o fossero contraddette dalla riaffermazione della sovranità nazionale come argine al comando del capitale internazionale. All’indomani della «primavera di Praga», la questione europea acquisí nuovi significati. Alla fine del 1968, il Pci inviò al Pcus una nota per spiegare la propria politica europeista. Questo documento non faceva altro che reiterare posizioni già note (massimo allargamento possibile della Cee, superamento dei blocchi, distinzione tra politica europeista e atlantica). Anche cosí, però, si rimarcava una traiettoria divergente da Mosca tramite una visione positiva della Comunità Europea e si apriva implicitamente la strada a insidiosi interrogativi sul futuro del Comecon e sull’influenza sovietica nell’Europa orientale76. Subito dopo, nel marzo 1969, una rappresentanza comunista italiana entrò nel Parlamento europeo di Strasburgo, unico caso nell’Europa occidentale. Tale traiettoria venne bilanciata dal rilancio delle posizioni intransigenti sulla Nato, una reazione difensiva rispetto al rigetto suscitato in Occidente dall’invasione della Cecoslovacchia, e insieme un riflesso della guerra americana in Vietnam, acuito dalla competizione con le forze di estrema sinistra77.
I comunisti italiani interpretarono la Ostpolitik come una nuova chance di cambiamento politico nel continente europeo. Nell’aprile 1970, Berlinguer sostenne in Direzione che la «crisi dell’internazionalismo» emersa da tempo non aveva mai conosciuto «un punto cosí basso» e che per uscirne occorreva porre al centro «le questioni dell’Europa occidentale»78. Si delineava un codice destinato ad avere una lunga durata, per il momento adottato senza modificare le strutture dell’appartenenza. Lo chiarí a modo suo Amendola, polemizzando con Terracini per le sue critiche al socialismo sovietico e ponendo i propri compagni dinanzi all’alternativa logica che li sfidava dopo il 1968: mantenere il legame storico con il «campo socialista», accettandone in una certa misura anche i vincoli, oppure interromperlo e aderire alla famiglia politica della sinistra occidentale, rinunciando tra l’altro alle risorse finanziarie provenienti da Mosca79. Un aut aut retorico, perché il gruppo dirigente italiano aveva già fatto la sua scelta ed escluso a priori la seconda opzione. Quello di Amendola era anche un monito a vedere bene i confini della propria trasformazione, demarcati dallo spettro della «socialdemocratizzazione», che esponeva il Pci alle critiche di tutti coloro che ne avversavano le specificità, a Mosca come a Berlino Est e a Praga o nelle file della «nuova sinistra» extraparlamentare.
Nello stesso tempo, i comunisti italiani erano convinti che soltanto la connessione tra il movimento operaio in Europa e i movimenti di liberazione fuori di essa fornisse un orizzonte di senso alla nozione di internazionalismo. Le loro reti di relazioni intessute nel Terzo Mondo mostravano un quadro frammentato, che non sempre giustificava il forte investimento politico e organizzativo intrapreso da tempo. Essi dovevano fronteggiare la crescente competizione dei linguaggi neomarxisti e delle posizioni terzomondiste diffuse alla sua sinistra ma anche nel mondo cattolico, che dividevano il «fronte antimperialista» domestico80. Tuttavia, le relazioni con il mondo postcoloniale restavano la loro proiezione internazionale piú importante fuori del «campo socialista», in vari casi piú rilevante rispetto alle relazioni diplomatizzate o semicongelate con l’Europa centro-orientale.
Lo sforzo principale si appuntò sul Medio Oriente e sulla Palestina. La centralità del rapporto con il movimento palestinese di Al Fatah si stabilí negli incontri di Pajetta con Yāsser ʿArafāt, inaugurati dalla visita del dirigente comunista ad Amman nel dicembre 196981. La base d’intesa comune era l’idea che il legame tra il mondo socialista, compresi i comunisti occidentali, e la causa palestinese, escluse le componenti estremiste e antisemite, avrebbe potuto fornire nuovi incentivi al movimento antimperialista. I comunisti italiani appoggiavano la prospettiva di uno Stato multietnico, cosa che presupponeva però incompatibilità con lo Stato d’Israele nella sua forma attuale e non lasciava perciò intravedere una soluzione politica. Il problema non era tuttavia rappresentato soltanto dalla questione di Israele. I rapporti del Pci con vari attori del mondo arabo mostravano la difficoltà di promuovere la causa palestinese come catalizzatore di un rilancio antimperialista, sul modello algerino o vietnamita. Persino gli algerini, principali interlocutori dei comunisti italiani e attori terzomondisti di primo piano, rivelavano una impasse al riguardo e si tenevano distanti dalle politiche del «campo socialista»82. I contatti avviati ad Algeri, al Cairo e a Beirut per una nuova conferenza delle forze «progressiste e antimperialiste» nel Mediterraneo non ebbero seguito83. La scomparsa di Nasser e il regime di Sadat in Egitto tolsero ogni residua illusione circa le prospettive «progressiste» di rapporti coltivati da molto tempo84.
Le ricadute piú significative dell’attività transnazionale dei comunisti italiani riguardavano la loro tendenza a integrare e surrogare la politica estera del paese, pur da posizioni antiatlantiste. Per la prima volta nella storia della Repubblica, tra il 1969 e il 1972 si verificò un autentico rispecchiamento tra alcune opzioni di fondo dei comunisti e le strategie governative, che sotto la guida di Moro come ministro degli Esteri segnarono sensibili novità dopo un decennio di sostanziale conservatorismo. I punti di contatto erano la distensione vista come un processo di mutamento e scomposizione dei blocchi, la valorizzazione dell’Europa come un polo della politica mondiale e la creazione di relazioni con il Terzo Mondo piú estese rispetto alla tradizionale politica italiana85. Per lo piú viste come un’evoluzione personale di Moro, tali prospettive erano piuttosto il risultato di una competizione e una interazione con i comunisti, piú di quanto gli stessi protagonisti fossero disposti ad ammettere. La visione della questione mediorientale come tassello dell’interesse nazionale portava ora le principali forze politiche italiane su posizioni empatiche verso i paesi arabi del Mediterraneo.
Malgrado l’impasse circa le prospettive dei paesi arabi filosocialisti, la consistenza delle forze antimperialiste nel mondo era confermata, agli occhi dei comunisti, non soltanto dalla guerra del Vietnam ma anche dalla vittoria elettorale di Unidad Popular in Cile e dall’elezione del presidente Salvador Allende nel 1970. L’esperienza cilena rappresentava la realizzazione di una «via nazionale» pacifica nel contesto latinoamericano, sebbene in un rapporto ambiguo con Cuba, che veniva tuttavia giustificato alla luce della indifferenziata ostilità degli Stati Uniti. Il Pci aveva sostenuto la politica delle alleanze del leader comunista cileno Luis Corvalán, vista come l’unica esperienza latinoamericana consonante con l’ispirazione italiana. La stessa realtà politica cilena si prestava a essere letta in controluce con quella italiana, data la presenza di un forte partito di governo democristiano86. Nello stesso tempo, Unidad Popular si presentava come un attore di raccordo tra i paesi in via di sviluppo, che poteva consolidare la via di una gestione autonoma delle risorse nazionali, contribuendo alla crescita di tendenze verso l’emancipazione dal «neocolonialismo» americano. I comunisti italiani valorizzarono entrambi gli aspetti e si proposero come mediatori diplomatici tra Cile, Italia ed Europa, avanzando una solidarietà internazionalista molto piú pronunciata dell’accorta condotta sovietica87. L’identificazione tra l’esperienza cilena e quella italiana si sviluppò negli anni della presidenza Allende, ma trovò anche il suo limite nella constatazione dei problemi legati al frontismo. Emerse gradualmente la percezione delle difficoltà del governo di sinistra nella realizzazione del suo programma di nazionalizzazioni in una società attraversata da forti divisioni, con il rischio di una radicalizzazione dei ceti medi. All’inizio del 1972, Secchia incontrò Corvalán e inviò una nota preoccupata alla segreteria del partito88.
Le vicende del Cile rimandavano alla divisione tra sfere d’influenza mondiali, ma intanto l’ordine postbellico si decomponeva in modi imprevedibili solo pochi anni prima. Nel settembre 1971, la Direzione del Pci si riuní per discutere la fine del sistema di Bretton Woods, annunciata dal presidente Nixon un mese prima. La relazione di Amendola sottolineò le conseguenze politiche della decisione americana, che a suo giudizio portava al suo picco il «contrasto crescente» tra Stati Uniti e Comunità Europea. L’unilateralismo americano significava la ricerca di un diverso assetto mondiale e non doveva essere letto con le lenti catastrofiste della crisi terminale. Amendola lamentava l’assenza di un discorso dei paesi socialisti su questo tema, particolarmente negativa perché «ormai non ci sono solo due aree economiche»89. Questa notazione accresceva la rappresentazione di un declino del mondo bipolare nelle visioni dei comunisti italiani. Berlinguer ne trasse la lezione principale. Egli sostenne che la tesi dei «due campi» non era piú adeguata alla lettura del mondo contemporaneo90. La categoria dell’imperialismo restava valida, ma essa non era piú fondata su una concezione dicotomica della politica mondiale. In realtà, quella concezione era già stata liquidata di fatto da Togliatti nell’ultima fase della sua vita, ma Berlinguer ne proponeva ora un rigetto esplicito, alla luce della fine di un’intera fase della supremazia americana. Il gruppo dirigente comunista vedeva ora nella Comunità Europea un fattore di aggregazione, pur criticandone il nesso atlantista, e usava in modo diverso dal passato il linguaggio della sovranità, nella chiave cioè della tutela degli interessi nazionali nelle nuove interdipendenze economiche all’orizzonte, che avrebbero richiesto di liquidare il modello basato su prodotti a bassa tecnologia e compressione dei salari. In un convegno svoltosi a Roma nel novembre 1971, Amendola presentò le posizioni del Pci in favore dell’allargamento della Comunità e per una ridefinizione democratica del suo profilo politico91.
Sotto questo profilo, è difficile sottovalutare l’influenza decisiva di Amendola sulla scelta europeista del comunismo italiano, destinata a divenire un elemento cruciale della sua strategia. Divenuto segretario generale del Pci nel marzo 1972, Berlinguer sviluppò quella scelta come una priorità nel nuovo assetto mondiale disegnato dalla fine di Bretton Woods, dalla distensione internazionale e dall’onda lunga del Sessantotto, che in Italia e in altri paesi presentava anche contraccolpi conservatori. Nel gennaio 1973, accentuò la visione di «una fase internazionale di tipo nuovo», indicando nella distensione non piú solo un progetto di contenimento dell’imperialismo ma un segno di declino per la «concezione di un dominio del mondo a due», una perdita di controllo dei blocchi militari sui processi globali che era destinata a svuotarli di significato. Cosí egli pose come finalità congiunte e interdipendenti «la lotta contro il neocolonialismo» e i «problemi dell’Europa», coniando la formula dell’Europa «né antisovietica, né antiamericana», resa subito dopo pubblica in una riunione del Comitato centrale. La sua visione dell’Europa si qualificava cosí non piú come presa d’atto dell’integrazione, ma come progetto destinato a giocare un ruolo nelle relazioni globali e nel Sud del mondo. Berlinguer fu criticato nel gruppo dirigente da posizioni realiste. In particolare, Napolitano chiese di «non riproporre la discussione di dieci anni fa» sulla coesistenza come «superamento dei blocchi». Bufalini criticò il velleitarismo della invocazione «fuori l’Italia dalla Nato, via l’Urss da Praga», prendendo una posizione che era al tempo stesso piú attenta al nesso con Mosca e piú vicina alla concezione di Brandt e Bahr circa la necessità di riconoscere i blocchi per far progredire la distensione. Si delineava cosí, piú che una divergenza, un dilemma nel modo di vedere la distensione e il suo carattere piú o meno dinamico92.
In ogni caso, Berlinguer proponeva di vedere l’Europa come un nuovo soggetto della politica mondiale, in un panorama già pluralizzato dall’emergere del mondo postcoloniale. La sua Europa non coincideva con la Comunità Europea, ma questa era riconosciuta come un’entità autonoma e teatro del possibile rilancio di obiettivi progressisti e socialisti. Egli non prospettava un’integrazione tra le forze del comunismo occidentale e della socialdemocrazia europea, ma piuttosto una nuova competizione basata sul riconoscimento delle rispettive identità, come sembrava sancito dal programma comune delle sinistre francesi nel 1972. In questa ottica, le carte da giocare per i comunisti erano soprattutto la critica del riformismo legittimata dall’onda del Sessantotto, i linguaggi del socialismo umanistico e il nesso persistente con i movimenti di liberazione antimperialisti.
Stabilite le coordinate della propria visione e strategia, Berlinguer si impegnò in una diplomazia personale largamente rivolta al mondo comunista europeo, secondo una logica che puntava ostinatamente a smuoverne le acque. Nel corso del 1973, egli si recò a Mosca, Parigi, Sofia e Berlino Est per incontrare Brežnev, Georges Marchais, Todor Živkov ed Erich Honecker. Non è troppo paradossale che gli scenari europei e globali fossero alquanto limitati nei colloqui che Berlinguer tenne a Mosca con Brežnev, il 12 e il 13 marzo 1973. Berlinguer illustrò la formula dell’Europa «né antisovietica, né antiamericana», negando che si auspicasse una «terza forza», perché l’obiettivo sarebbe stato il «superamento dei blocchi». Ma i sovietici vedevano comunque nell’Europa come soggetto della politica mondiale una minaccia alla propria sfera d’influenza. La freddezza tra i due leader era aggravata dal tenace dissenso dei comunisti italiani sull’invasione della Cecoslovacchia. Berlinguer fu molto chiaro su questo punto, dichiarando che quell’atto di violenza aveva «danneggiato l’immagine socialista e l’influenza ideologica» del movimento comunista in Occidente. Brežnev affermò invece che le riforme democratiche in Cecoslovacchia sarebbero state un ostacolo agli accordi tra l’Urss e la Germania occidentale e avrebbero compromesso la distensione93.
La divergenza tra le due visioni era difficile da comporre. Berlinguer rifiutava di accettare l’argomento che la repressione della «primavera di Praga» fosse stata una condizione necessaria per il lancio della distensione. A suo giudizio, le prospettive del movimento comunista dipendevano invece dal nesso inverso, l’idea cioè che la distensione europea fosse un processo volto a modificare il sistema della guerra fredda, non a garantire lo status quo, e che il socialismo umanistico emerso nel 1968 costituisse la risorsa di cultura politica principale per realizzare tale cambiamento. Per quattro anni i comunisti italiani avevano seguito una linea volta a diplomatizzare il loro dissenso, con il risultato che i sovietici restavano irremovibili e impermeabili ai loro argomenti. Ora la saldatura tra europeismo e socialismo umanistico delineata dal gruppo dirigente del maggior partito comunista occidentale sembrava piú difficile da circoscrivere in una relazione bilaterale e assumeva significati piú generali. La visione dei comunisti italiani divergeva chiaramente dal rigido bipolarismo sovietico. Il punto di accordo tra Berlinguer e Brežnev era che la distensione rappresentasse un successo dell’Unione Sovietica nel contenere la guerra fredda occidentale. Ma essi ne traevano lezioni opposte in Europa e nel Mediterraneo. Berlinguer prospettava scenari di mutamento che contestavano di fatto le risposte di Mosca alla Guerra dei sei giorni e alla «primavera di Praga», vale a dire la politica di potenza nel Mediterraneo e la stabilizzazione con la forza della sfera d’influenza europea94.
Gli incontri tra Berlinguer e Marchais del maggio e del settembre 1973 sembrarono decretare un successo dell’europeismo comunista. Con l’ingresso del Pcf nel Parlamento europeo, si delineava per la prima volta un polo del comunismo occidentale. Si creò cosí una divisione inedita tra comunisti filo- e antieuropei. Mosca ispirò infatti un fronte di resistenza alle iniziative italo-francesi tra i piccoli partiti comunisti occidentali. Alla Conferenza di Bruxelles del gennaio 1974, Berlinguer e Amendola invitarono per la prima volta i comunisti occidentali a unirsi attorno al progetto di un’Europa «né antisovietica né antiamericana», in grado di costituirsi come soggetto mondiale. Ma ebbero un seguito limitato ai francesi, ai belgi e agli spagnoli95. La nuova parola d’ordine europeista incontrava la comprensione di Honecker, interessato alla distensione con la Repubblica federale tedesca, ma sbatteva contro il muro di Mosca e della maggioranza degli altri regimi esteuropei, preoccupati dalla minaccia anche remota di destabilizzazione generata dalla polarità di un’Europa politica96. Il gruppo dirigente italiano sapeva di dover seguire un sentiero stretto e lo aveva anzi scelto come propria modalità di influenza, a Ovest come a Est. La sua azione generò una tensione destinata a durare nel tempo e a costituire una declinazione delle divergenze trasversali che attraversavano il mondo comunista.
Nel settembre 1973, il colpo di Stato militare in Cile e la morte di Allende ebbero un impatto molto rilevante sulla definizione del nesso tra politica nazionale e internazionale. Berlinguer formulò in tre celebri articoli la strategia del «compromesso storico» con la Dc, che traeva dalla vicenda del Cile la lezione di evitare ogni spaccatura frontista nel sistema politico e nella società. Sotto questo profilo, egli fu indotto a esplicitare una proposta politica che si iscriveva nella tradizione comunista italiana richiamandosi al precedente dell’«unità nazionale» alla fine della Seconda guerra mondiale. Il mito dell’unità antifascista come pilastro fondativo della Repubblica restava vivo fino a configurare la base di una strategia ancora operante dopo la parentesi della guerra fredda occidentale. Sin dai primi commenti al colpo di Stato in Cile tale visione fu condivisa nel gruppo dirigente. Pajetta menzionò un suo recente colloquio con Corvalán per criticare la tendenza dei socialisti a forzare il cambiamento e la sottovalutazione da parte di Allende della minaccia eversiva97. Ora l’intreccio immaginato tra l’esperienza italiana e quella cilena cambiava di segno. Il Cile alimentava la percezione della fragilità italiana, piú precisamente l’idea che l’eccezione democratica rappresentata dal paese nel Mediterraneo potesse scomparire. La dittatura di Pinochet interagiva simbolicamente con lo scenario di un «largo fronte di tipo clerico-fascista» evocato da Berlinguer come «il problema politico centrale» della storia italiana. Di qui la sua tesi che anche un governo di sinistra fondato sulla maggioranza assoluta dei voti e dei seggi in Parlamento non sarebbe facilmente sopravvissuto e che fosse invece indispensabile una politica di alleanze molto piú larga98. Nella sua visione convivevano la fiducia nelle risorse dell’Italia per superare la crisi e un sottofondo pessimistico che riteneva la nazione italiana sottoposta dall’ideologia anticomunista a «un incombente pericolo di scissione». Le concezioni berlingueriane, in altri termini, oscillavano tra l’idea dell’Italia come battistrada di trasformazioni progressiste in Europa e laboratorio per mettere fine alla guerra fredda, da una parte, e la percezione di un paese esposto al crollo di istituzioni e assetti democratici mai davvero consolidati, dall’altra.
La mobilitazione comunista contro la dittatura di Pinochet fu estremamente rilevante, anche con l’obiettivo di dividere la Dc e costringere i suoi dirigenti a prendere posizione circa il sostegno all’eversione di una parte dei democristiani cileni, che rimandava al sospetto di zone d’ombra analoghe anche in Italia. La campagna ebbe pieno successo e contribuí a fare dell’Italia il paese piú impegnato, anche sul piano governativo, nella solidarietà alle vittime della dittatura. Il discorso pubblico del Pci costituí la fondazione di un vero mito politico contrapposto alle mitologie guevariste e maoiste dell’estrema sinistra99. La vicenda del Cile e il suo mito rimandavano anche a considerazioni di carattere internazionale. Berlinguer dedicò il primo dei suoi tre articoli al tema «imperialismo e coesistenza». In esso rivendicò una concezione «dinamica e aperta» della distensione in Europa contrapposta a quella, attribuita all’«imperialismo», di strumento per mantenere lo status quo100. Evitò invece di stabilire un’analogia tra il Cile e la Cecoslovacchia. In entrambi i casi, le grandi potenze avevano reagito nelle rispettive sfere d’influenza, limitando la sovranità nazionale e soffocando forze di movimento potenzialmente transnazionali. La distensione non esprimeva soltanto il tramonto della guerra fredda, ma anche un ambiguo senso di incertezza che poteva generare opportunità di mutamento, disordine endemico o semplice conservazione dell’ordine101. L’interrogativo era se e come le forze di movimento potessero trovare il loro momento sulla scena europea e globale. I comunisti non erano equidistanti nel formulare tale interrogativo. Consideravano infatti illegittima l’interferenza americana in Cile e nell’intera America Latina, mentre non discutevano la legittimità della presenza sovietica nell’Europa orientale, vista come un’eredità dell’antifascismo non diversamente dal discorso ufficiale dei regimi comunisti. Entro questi confini, come era nella loro tradizione, elaborarono visioni che eccedevano il perimetro di una «via nazionale» e si confrontavano con gli scenari globali usando lenti e idiomi non sempre collimanti con il resto del movimento comunista.
4. Dopo lo shock petrolifero: ridefinire l’ordine mondiale.
Tra la fine del 1973 e l’inizio del 1974, lo shock petrolifero provocato dalla guerra dello Yom Kippur diffuse in Occidente le previsioni di una crisi che evocava la Grande Depressione degli anni Trenta102. Le conseguenze per l’Italia furono ambivalenti. La crisi della classe dirigente e le spinte al cambiamento conobbero un’accelerazione, ponendo la «questione comunista» all’ordine del giorno. Nello stesso tempo, l’intervento della Germania occidentale e degli Stati Uniti per evitare un collasso finanziario del paese configurò un rinnovato “vincolo esterno” che combinava condizioni economiche e politiche iscritte in una concezione conservatrice della distensione internazionale103. Vista da Washington e dalle principali capitali dell’Europa occidentale, l’Italia era il conclamato «malato d’Europa» aggravato da un deficit di legittimità della sua classe dirigente tradizionale, ma non aveva soluzioni di ricambio. Anzi la sua ripresa implicava il mantenimento della pregiudiziale anticomunista, sebbene i modi di interpretare quel punto fermo mostrassero sfumature e scenari diversificati. Le implicazioni della «questione comunista» spaccarono la classe dirigente italiana, ma anche le leadership occidentali, tra falchi e colombe. Una divisione analoga sembrava profilarsi anche nel blocco sovietico. In particolare, era legittimo il dubbio che la politica di Kissinger potesse sacrificare la democrazia sull’altare del contenimento anticomunista non soltanto in America Latina, ma anche nell’Europa meridionale. Non meno lo era il sospetto che Brežnev preferisse un Pci piú orientato alla mobilitazione sociale che alla prospettiva di governo, nel contesto bipolare delle sfere d’influenza europee.
I comunisti italiani vissero il colpo di Stato in Cile e la guerra dello Yom Kippur come due eventi che creavano un corto circuito geopolitico. L’ombra lunga del Cile si estese per almeno un anno, alimentata dalla tragica recrudescenza dell’eversione nelle stragi di Brescia e dell’Italicus, e dalla minaccia di un colpo di Stato di destra. Il nuovo conflitto arabo-israeliano coinvolse l’Italia, come mostrò tragicamente l’attentato all’aeroporto di Fiumicino del 17 dicembre 1973. Simili eventi acuivano le percezioni già esistenti di una spirale drammatica tra l’instabilità mondiale, lo shock economico come rischio di marginalità per l’Italia e la fine della sua eccezione democratica nel Mediterraneo. Nello stesso tempo, le sirene della «crisi del capitalismo», intesa come conferma degli assiomi marxisti-leninisti, subito evocati nelle analisi delle élite sovietiche e dell’Est europeo, potevano esercitare la loro attrazione e togliere spazio alle peculiarità italiane. La visione dei comunisti italiani venne modellata da Amendola, cosí come era accaduto due anni prima. A suo giudizio, la crisi provocata dalla guerra in Medio Oriente non si doveva leggere soltanto con le lenti dei meccanismi di potere economico, perché mostrava il logoramento dell’egemonia americana e dell’asse tra Stati Uniti ed Europa. Ma l’Europa si presentava alla sfida largamente impreparata104.
Il gruppo dirigente comunista tenne ferme coordinate e posizionamenti già assunti, vale a dire una lettura non determinista della crisi economica mondiale, l’ispirazione del “partito d’ordine” volto a difendere le istituzioni della Repubblica, il progetto di mettere fine alla guerra fredda interna grazie alla distensione internazionale. Piú lenta fu invece la capacità di mettere a fuoco le ambivalenze degli eventi del 1974, che insieme ai profili di crisi segnavano anche accelerazioni e trasformazioni in Italia e in Europa. L’«onda lunga» del Sessantotto e il suo contributo ai processi di secolarizzazione della società italiana determinò la prima vera sconfitta politica della Democrazia cristiana e della Chiesa cattolica, nel referendum sul divorzio del maggio 1974, e con essa l’uscita di scena dell’opzione anticomunista di stampo clerico-reazionario. La scena politica italiana conobbe un’evoluzione entro la fine dell’anno con il ritorno al governo di Moro, che non faceva mistero della sua adesione a una prospettiva di solidarietà nazionale e dichiarava attenzione verso la funzione democratica dei comunisti. Il linguaggio stesso di Moro si rivelava in sintonia, ancora piú che nel passato, con alcune tematiche care ai comunisti italiani, in primo luogo, un’idea della distensione diversa da quella della «cristallizzazione dell’esistente». Ciò lo pose in diretto contrasto con Kissinger105. La caduta delle dittature in Portogallo e in Grecia, rispettivamente nell’aprile e nel luglio 1974, improvvisamente avviava transizioni democratiche nell’Europa meridionale, apriva possibilità di allargamento alla Comunità Europea e dissolveva molti fantasmi di un’Italia democratica accerchiata nel Mediterraneo. La Rivoluzione dei garofani portoghese ebbe ripercussioni per tutte le principali forze della sinistra europea. Nel contempo, le conseguenze dello shock petrolifero delineavano a livello mondiale una trasformazione nelle agende e nel discorso pubblico, che emersero all’Assemblea dell’Onu dell’aprile 1974. La risoluzione sul «nuovo ordine economico internazionale» ricalcava il linguaggio dei non allineati, indicava la priorità della sovranità dei paesi in via di sviluppo e sfidava il potere degli Stati Uniti nell’economia internazionale106.
Il progetto del «nuovo ordine economico internazionale», che ora si imponeva nell’agenda globale, sembrava annunciare il passaggio dalla fase rivoluzionaria del Terzo Mondo, consumatasi nel decennio passato, a una fase riformatrice rivolta a prospettare un’alternativa alla supremazia occidentale. Un variegato schieramento di soggetti nazionali antimperialisti condivideva la prospettiva di modificare gradualmente le relazioni economiche tra Nord e Sud. Il loro vocabolario comune poteva però assumere significati diversi, a cominciare dalle nozioni di sovranità e internazionalismo, autodeterminazione e interdipendenza107. I comunisti condivisero gli auspici presentati nella medesima circostanza dal rappresentante italiano Giolitti, volti a sottolineare come l’obiettivo della sovranità postcoloniale si fosse dimostrato insufficiente senza una nuova architettura delle interdipendenze economiche mondiali, che chiamava in causa il ruolo dell’Europa. Essi ritenevano che l’Unione Sovietica rappresentasse una forza indispensabile per rendere praticabili simili sviluppi e interpretarono con favore il commitment alla distensione presentato dal ministro degli Esteri sovietico Andrej Gromyko in polemica con i cinesi108. Il nesso tra distensione e fine della guerra fredda non era però affatto evidente fuori d’Europa, dove invece la stabilizzazione del vecchio continente poteva significare nuove violenze e guerre.
In questa rapida evoluzione nazionale e internazionale gli attriti dei comunisti italiani con il «campo socialista» restavano contenuti in una modalità diplomatica. Durante una serie di incontri con l’ideologo Ponomarëv, nel luglio 1974, Segre presentò la politica estera italiana come «parte essenziale [della] nostra lotta per [una] svolta democratica», insistette sull’impegno del Pci nell’ambito comunitario europeo e dichiarò che se in passato le posizioni dei comunisti italiani erano viste come «esoteriche», ora cresceva l’interesse non solo tra i comunisti occidentali ma anche tra socialisti e socialdemocratici. Tutte questioni invise ai sovietici ma non discusse a viso aperto109. Persino il cruciale scenario mediorientale, che nel recente passato aveva prevalentemente registrato convergenze tra le due parti, sembrava ora accrescere gli elementi di attrito. All’indomani della guerra dello Yom Kippur, Mosca stava perdendo terreno nella regione e tendeva ad appoggiare soggetti e istanze estremiste. Il Pci assegnò invece un ruolo importante alla Comunità Europea e ribadí la propria convergenza con la politica estera del governo italiano, in chiave filoaraba, ma sulla base del riconoscimento dello Stato d’Israele110.
Ponomarëv cercò soprattutto di fare leva sulla drammaticità del contesto interno italiano, segnato da una rinnovata violenza eversiva, e rinnovò le pressioni perché il gruppo dirigente italiano si riallineasse a una visione classista della politica e si preparasse a fronteggiare il «fascismo» di ritorno mettendosi sotto l’ala protettiva del «campo socialista». Tra le preoccupazioni di Mosca rientrava evidentemente anche la possibilità che il Pci potesse avvalersi della nuova legge di finanziamento pubblico dei partiti per accrescere la propria autonomia. Ciò era in effetti nelle intenzioni di Berlinguer, che poco dopo avrebbe incaricato Gianni Cervetti di mettere fine ai flussi finanziari da Mosca. Berlinguer respinse il richiamo dell’ideologo alla «lotta di classe» confermando che i comunisti italiani avrebbero lavorato per «una rivoluzione democratica»111. Fu questo, a nostra conoscenza, l’ultimo tentativo dei sovietici di far rientrare la semieresia italiana agitando gli spettri dell’involuzione reazionaria in Italia. Il mutamento degli scenari internazionali alla metà del decennio avrebbe prodotto nuovi circuiti politici, discorsivi e conflittuali, logorando ancora di piú il legame tra i due partner.
Nel dicembre 1974, Berlinguer presentò al Comitato centrale un impegnativo discorso che respingeva l’idea del «crollo» del capitalismo ma delineava lo scenario dell’ingovernabilità mondiale, aperta a rischi e opportunità. Il suo impianto analitico era, in realtà, molto prudente e tradizionale. Restava intatta la categoria costituita dai «rapporti di forza» mondiali favorevoli al socialismo e alle forze antimperialiste. La nozione di crisi si applicava al mondo capitalistico, mentre il mondo socialista ne era immune. Mutava invece il codice della «necessità» del socialismo nel mondo, che non sgorgava piú dalla forza autoevidente del socialismo sovietico e dal suo incontro con il mondo postcoloniale. A giudizio di Berlinguer, era emersa nel 1968 una ribellione di massa contro un’organizzazione sociale che sacrificava «essenziali valori umani», subordinandoli al profitto. Egli vedeva affiorare una nuova coscienza di massa «fuori dalla logica del capitalismo», che si legava alle lotte antimperialiste e che si doveva esprimere in un linguaggio piú improntato al socialismo umanistico e meno alla «lotta di classe». In questo panorama, il centro di gravità restava il nesso tra il Secondo e il Terzo Mondo. Berlinguer riconosceva che non si poteva vedere quest’ultimo come «un tutto omogeneo e autonomo» ma ne evocava il «carattere dirompente ed esplosivo» quale elemento «esterno» al sistema di potere del capitalismo occidentale. Rivendicava al movimento comunista il ruolo insostituibile di interlocutore e soggetto rivoluzionario che aveva spostato «molteplici forze reali e correnti ideali» in senso antimperialistico112.
Il discorso di Berlinguer è stato solitamente citato per la sua revisione della pregiudiziale antiatlantista. In realtà, egli non fece altro che aderire interamente alla filosofia della Ostpolitik e all’idea di riconoscere realisticamente l’esistenza dei blocchi per porre a lungo termine l’obiettivo del loro superamento. La decisione di far cadere la richiesta di una fuoriuscita dell’Italia dalla Nato era già implicita nella revisione europeista del Pci, che diveniva cosí piú efficace e coerente. Il principale elemento di novità nel discorso di Berlinguer era però un altro e nasceva dalla distinzione tra l’elogio della distensione e il declino dell’ordine bipolare. La distensione tra le grandi potenze rappresentava una condizione necessaria ma non sufficiente. Assumeva cosí un posto cruciale il ruolo dell’Europa occidentale e il suo nesso con il Terzo Mondo, che poteva aprire prospettive di cooperazione internazionale «come obiettivo rivoluzionario a livello mondiale». In altre parole, Berlinguer non soltanto faceva propria la visione del «nuovo ordine economico internazionale» prospettata dall’Assemblea dell’Onu, ma assegnava alla Comunità Europea un peso determinante in quel contesto. La revisione della politica dei comunisti italiani verso l’Europa si legava a una nuova visione globalista. Tale visione non era frutto di immaginazione, ma trovava fondamento nella pluralità degli orientamenti postimperiali delle classi dirigenti europee e dei socialisti in particolare. La guerra dello Yom Kippur e la crisi petrolifera avevano delineato una nuova identità mediterranea dell’Europa e una sua maggiore autonomia nel contesto transatlantico113.
Con questa miscela di visioni trasformatrici e realismo geopolitico, Berlinguer si proponeva di legittimare il Pci, cercare un’intesa con Moro e salvaguardare l’identità comunista114. La sua sintesi evitò la divisione del gruppo dirigente tra moderati e intransigenti. Tra i primi si iscrivevano Bufalini e Napolitano, tra i secondi Pajetta e Ingrao, che dava voce ai sentimenti antiatlantisti prevalenti tra quadri, militanti e intellettuali. Tuttavia tale divisione non era pari a quella generatasi nel decennio precedente attorno alle figure di Amendola e Ingrao. La leadership di Berlinguer stabiliva un equilibrio forte e creava consenso. L’estromissione dalla segreteria di Cossutta, secondo Barca divenuto troppo potente e legato a Mosca, completava il quadro115. Berlinguer adottò a proposito della politica interna il medesimo dispositivo realista e progettuale della politica internazionale. Rilanciò il «compromesso storico», inteso come «qualcosa di piú di una formula nuova di governo», ma prospettò anche l’idea che la crisi dell’Italia fosse l’occasione per introdurre «elementi di socialismo». Un simile concetto richiamava le «riforme di struttura» togliattiane ma alludeva a forme di controllo pubblico sull’economia e di ristrutturazione dei consumi, che nella congiuntura dello shock petrolifero potevano sembrare un orientamento piú generale in Europa. La narrazione della storia italiana del dopoguerra si collocava interamente nel solco della tradizione togliattiana, fondata sul paradigma della responsabilità della classe operaia, sul tema della sovranità nazionale e sulla persuasione che la guerra fredda avesse interrotto un’autentica trasformazione democratica del paese. Berlinguer vi aggiungeva l’idea che il ripristino della stagione dell’unità antifascista e la liquidazione dell’anticomunismo non avrebbe semplicemente riparato un danno e sbloccato il sistema democratico, ma fatto dell’Italia un laboratorio politico e sociale in Europa116. Il suo accento sull’azione da svolgere in Europa occidentale presentava cosí un duplice risvolto, la prospettiva combinata di un ruolo globale europeo e di un cambiamento nazionale destinato a esercitare influenze internazionali117.
Berlinguer spostò il baricentro dei comunisti italiani in Europa occidentale, riconoscendo di fatto l’esigenza di riequilibrare un sistema di relazioni storicamente proiettato verso l’Europa orientale e il Terzo Mondo. Le relazioni con la sinistra europea occidentale restavano però in gran parte da costruire. L’autocompiacimento per l’interesse suscitato dal comunismo italiano era sotto molti aspetti eccessivo. Vari leader socialdemocratici europei mostravano attenzione e curiosità per l’evoluzione del Pci, visto soprattutto come una forza che poteva contribuire a stabilizzare la situazione italiana. Era questo il caso del socialista svedese Olof Palme e, notoriamente, di Brandt, che però cedette nel luglio 1974 la leadership della Spd a Helmut Schmidt, espressione delle componenti piú moderate e anticomuniste. Anche il leader socialista francese François Mitterrand non aveva mancato di aprire ai comunisti italiani, con il fine di proporre il suo modello di «unione di sinistra» nel Sud dell’Europa, inviso ai socialdemocratici nordici. Tuttavia, nessuno dei principali leader socialisti europei era propenso a stabilire una relazione pubblica e impegnativa, ancor meno a cedere qualcosa in termini di identità118. Ciò era vero da entrambe le parti. La creazione di una polarità comunista occidentale implicava molto piú una competizione, come accadeva in Francia, che non un’integrazione tra le due culture politiche della sinistra europea. La spaccatura tra filo- e antieuropeisti, evidenziata dalla Conferenza di Bruxelles, impediva che il comunismo potesse costituire un magnete verso elettori, militanti e sindacalisti della sinistra in Occidente. Le idee professate dagli italiani potevano esercitare maggiore influenza tra i comunisti dell’Europa orientale, un effetto collaterale certo non estraneo agli intendimenti del gruppo dirigente. In sintesi i comunisti italiani non avevano davvero lanciato una loro Westpolitik, sebbene una simile prospettiva fosse invocata apertamente da Segre119.
Gli interlocutori piú consonanti con le loro posizioni si rivelarono i comunisti iugoslavi, una forza influente e autorevole, ma piú fuori d’Europa che nel vecchio continente. Nel suo incontro con Tito del 29 marzo 1975, Berlinguer affermò, sapendo di parlare un linguaggio condiviso, di considerare «sempre meno adeguata ai tempi la concezione e la nozione stessa di movimento comunista internazionale» perché questa rispondeva «a una visione ristretta delle possibilità»120. Queste parole appaiono innovative e contraddittorie nello stesso tempo, dal momento che il gruppo dirigente italiano continuava ad agire in gran parte entro il perimetro del movimento. Di certo, nessun altro leader comunista, a parte Tito, avrebbe sottoscritto né addirittura capito il senso di una simile tesi. La visione di Berlinguer costituiva il segnale di un ripensamento profondo, destinato ad avere conseguenze importanti, ma per il momento restava un fatto riservato.
Il senso di una forza autosufficiente, nelle rappresentazioni dei comunisti italiani, non si basava esclusivamente su elementi di ordine nazionale, anche se questi balzarono in primo piano con la conquista di un terzo dei voti nelle elezioni amministrative del giugno 1975. La crescita elettorale del Pci, che conservava larghe basi di massa dopo il Sessantotto e aveva rinnovato per circa un quarto i propri ranghi, si collocava in una congiuntura particolarmente favorevole tanto in Europa quanto sul piano globale. La Rivoluzione dei garofani in Portogallo e i suoi riflessi internazionali, la definitiva vittoria dei comunisti in Vietnam, la conclusione della Conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa, la fine del regime di Franco in Spagna costituirono altrettanti tasselli di scenari promettenti che, in modi diversi, investivano anche il comunismo italiano. La crisi istituzionale generata dall’affare Watergate, che provocò le dimissioni di Nixon nell’agosto 1974, integrava quegli scenari e creava una connessione tra lo shock economico mondiale e l’apparente indebolimento del primato americano. Sul piano pubblico, dirigenti come Bufalini e Segre sostenevano, alla luce del Medio Oriente e dell’Indocina, che il bipolarismo rappresentava una sopravvivenza del passato, che il ruolo delle grandi potenze era ormai di dare risposte agli attori locali e nazionali, invece di imporre i propri modelli, e che l’Europa doveva fare i conti con questa nuova realtà121. Sebbene tramite giudizi anche opposti tra loro, una simile percezione della politica mondiale alla metà degli anni Settanta accomunava molti attori e soggetti politici. Candidati al governo di un importante paese occidentale, i comunisti italiani potevano a buon diritto sentirsi nei panni degli attori protagonisti, che avrebbero potuto inserirsi nelle dinamiche del mutamento globale, esercitando una funzione di traino sui comunisti occidentali.
La Rivoluzione dei garofani ebbe ripercussioni su tutto il contesto politico europeo, concentrando l’attenzione delle grandi potenze e dei governi occidentali. Idee diverse emersero sulle due sponde dell’Atlantico alla vigilia delle prime elezioni politiche, nell’aprile 1975. Washington considerò la possibilità di applicare al Portogallo la medesima versione illiberale del containment sperimentata in Cile, al fine di evitare che l’asse del governo slittasse drasticamente verso sinistra, data la presenza attiva di un forte partito comunista sotto l’influenza di Mosca. Bonn, Londra e Parigi esclusero una simile opzione e puntarono sugli attori politici che potevano garantire una transizione democratica, a cominciare dai socialisti122. Tutti condividevano la visione dell’Europa meridionale come un teatro di crisi unitario e interdipendente, ma i principali governi europei si espressero contro ogni dottrina della «sovranità limitata» in Occidente e influenzarono la condotta americana123. I riflessi sulla sinistra europea furono rilevanti perché la questione portoghese coinvolgeva partiti socialdemocratici di governo e rappresentava un discrimine per i partiti comunisti occidentali. Nel giudizio sulla condotta di Álvaro Cunhal, il leader del Pcp, la convergenza tra gli unici due partiti di massa, il Pci e il Pcf, si dissolse completamente. Berlinguer capí che la credibilità dei comunisti italiani dipendeva in una misura significativa da tale giudizio. Al contrario di Marchais, egli prese le distanze dal tentativo dei comunisti portoghesi di impedire la partecipazione dei democristiani alla prova elettorale e difese il principio del pluralismo politico. La preoccupazione del gruppo dirigente italiano era aggravata dal linguaggio dei portoghesi sulla «democrazia borghese». Ad esempio, Segre riferí che, in un incontro riservato, l’esponente governativo Mário Ruivo, vicino al Pcp e di lí a poco nominato ministro degli Esteri, gli aveva confidato di pensare a «un modello cubano con un po’ piú di pluralismo e libertà»124.
Anche questa volta gli italiani si trovarono quasi isolati nel comunismo europeo e in contrasto con Mosca. Oltre a Tito, soltanto il segretario del partito spagnolo Carrillo esprimeva il medesimo giudizio di Berlinguer. In un incontro riservato, pochi mesi dopo, i due leader convennero che le posizioni di Cunhal avrebbero danneggiato il loro progetto europeista e democratico125. Nell’intera vicenda, i comunisti italiani furono molto piú vicini alle posizioni dei socialisti europei che non a quelle degli altri principali partiti comunisti. Ciò non indicava però un sostanziale cambiamento dei rapporti reciproci, anche se i contatti si erano intensificati a livello di Sezioni esteri. Reduce da un viaggio negli Stati Uniti nel settembre 1975, il dirigente della Spd Horst Ehmke inquadrò il dilemma costituito dal comunismo occidentale per le socialdemocrazie, vale a dire come si potesse favorirne il distacco da Mosca senza accrescerne l’influenza126. Sotto questo profilo, la questione italiana era persino piú controversa della questione portoghese.
La Rivoluzione dei garofani presentava anche un altro aspetto, la fine dell’ultimo impero europeo nel continente africano. I comunisti italiani si distinsero per l’attenzione e le connessioni con i movimenti di liberazione in Angola, in Mozambico e nella Guinea Bissau, che erano in vari casi mediate dall’Algeria. Sin dalla metà degli anni Sessanta il Pci aveva stabilito relazioni con il leader del Frelimo, Marcelino dos Santos e con Cabral in Guinea-Bissau, che era subentrata alla Guinea come «avanguardia rivoluzionaria» nell’Africa subsahariana. La centralità del carattere «nazionale» costituiva un terreno d’intesa e sollecitava la vena pedagogica dei comunisti italiani, mentre restava un tema indigesto ai comunisti francesi e messo in soffitta dai sovietici in nome delle lealtà ideologiche127. I comunisti italiani videro perciò la Rivoluzione dei garofani e le nuove indipendenze postcoloniali nell’Africa lusofona come eventi intrecciati ai quali partecipavano non soltanto in chiave di solidarietà, ma come un attore dotato di una certa influenza. Il loro linguaggio diverso dalla visione classista e filosovietica dei comunisti portoghesi in Europa si legava allo sforzo di professare le «vie nazionali» in Africa anche dopo l’involuzione delle prime esperienze di indipendenza. Ciò segnava una netta distanza dal marxismo-leninismo cubano e sovietico, che era emersa da tempo e si accentuò dopo l’intervento militare dell’Avana nella guerra civile angolana. Persino l’inevitabile nesso con il trionfo dei comunisti in Indocina mise in evidenza linguaggi diversi. Berlinguer presentò la fine della guerra in Vietnam come l’inizio di «un nuovo assetto internazionale democratico» nel quale l’Europa avrebbe fatto la sua parte128. Il rilancio del motivo dell’antimperialismo, nella chiave «nazionale» e non marxista-leninista, si sovrappose cosí al motivo dell’antifascismo sulla scena italiana ed europea. I termini e i significati di una simile combinazione erano decisamente cambiati rispetto agli anni Sessanta. Ciò nonostante, i comunisti italiani mantenevano le coordinate stabilite sin da allora tra la sinistra occidentale, il «campo socialista» e il mondo postcoloniale, ridefinite alla luce della distensione, della cooperazione e della diversificazione degli attori nel Terzo Mondo.
Il viaggio di Berlinguer del novembre 1975 in Guinea, Guinea-Bissau e Algeria si svolse nel segno del «nuovo internazionalismo» che si immaginava oltrepassare i confini del movimento comunista e annodare fili piú stretti tra le forze progressiste europee e i paesi strategici nel mondo postcoloniale. La coincidenza con la dichiarazione d’indipendenza dell’Angola conferí al viaggio un significato simbolico particolare129. L’ambizione dei comunisti italiani era di contribuire a disegnare un nuovo ruolo dell’Europa sull’asse Nord-Sud del mondo. Essi aderivano largamente alla visione del commissario europeo allo sviluppo, il socialista Claude Cheysson, promotore della Convenzione di Lomé sottoscritta nel febbraio 1975 tra la Comunità Europea e quarantasei paesi in via di sviluppo in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico, che introduceva una nuova politica di cooperazione e revisione dell’aiuto comunitario. Il progetto poteva essere visto come una convergenza strategica della Comunità verso i paesi in via di sviluppo e le idee del «nuovo ordine economico internazionale», rivolta a far emergere un mondo postbipolare130. Il problema era conciliare in modo convincente la prospettiva eurafricana con la distensione Est-Ovest, che suscitava la diffidenza di molti attori del Sud globale, ad esempio gli algerini. Mentre l’Unione Sovietica e il blocco socialista davano un giudizio critico sull’iniziativa della Cee, che bollavano come una forma di «neocolonialismo» temendone però soprattutto le implicazioni favorevoli al non allineamento. Il Comecon respingeva esplicitamente la partizione stessa tra Nord e Sud del mondo, ritenuta una formula maoista131.
Un simile contesto globale accresceva per il Pci il significato dell’alleanza tra i comunisti occidentali, ma amplificava anche i dissidi politici con il Pcf, evidenti tanto nel giudizio sulla rivoluzione portoghese quanto sul ruolo dell’Europa verso l’Africa. La direzione del Pci dedicò notevoli energie ai rapporti con i francesi e a preparare una nuova conferenza paneuropea dei partiti comunisti, che si trovava in una impasse generata dal contrasto tra i fautori di un rilancio ideologico del movimento, invocato soprattutto dalla Sed ma anche dal Pcf, e i sostenitori della distensione e della cooperazione internazionale, vale a dire gli italiani e gli iugoslavi132. Buona parte dei dirigenti, a cominciare da Amendola, giunsero alla conclusione che i francesi mantenevano posizioni difficilmente conciliabili con la politica europea del Pci133. Nell’incontro tra Berlinguer e Marchais svoltosi a Parigi il 29 settembre 1975 si prese atto del fatto che la sola base comune consistesse nel generico interesse per «certi tratti comuni» del rapporto tra democrazia e socialismo in Europa occidentale134. Questo quadro non fu modificato dai successivi incontri tra Berlinguer e Marchais a Roma, nel novembre dello stesso anno135. Ciò nonostante, il generico messaggio di unità trasmesso pubblicamente ebbe un impatto sull’opinione pubblica anche fuori dai rispettivi confini nazionali. L’intesa proclamata dai due principali partiti comunisti occidentali alimentava la percezione che una sinistra dal volto nuovo, né filosovietica né socialdemocratica, fosse protagonista nell’Europa meridionale, compresa la Spagna dopo la scomparsa di Franco.
Il panorama in movimento nell’Europa meridionale metteva ancora piú in rilievo il carattere strategico della crisi italiana, che poteva spostare a sinistra le traiettorie delle transizioni democratiche e minacciava instabilità proprio nel momento storico dell’equilibrio dei blocchi sancito alla Conferenza di Helsinki. Per le grandi potenze e per i principali governi europei, l’Italia costituiva un motivo di allarme e il suo «comunismo della prosperità» un rebus. Kissinger temeva la prospettiva di un’Italia trasformata in una seconda Iugoslavia, che avrebbe minacciato la coesione dell’Alleanza atlantica. Nella sua visione, destinata a restare fissa negli anni a venire, i comunisti al potere in Europa occidentale avrebbero «totalmente ridefinito la mappa del mondo postbellico»136. Con simili premesse, i risultati delle elezioni amministrative in Italia potevano soltanto accrescere le tensioni. Nell’estate 1975, Ford e Kissinger respinsero con asprezza le argomentazioni di Moro circa l’evoluzione politica dei comunisti italiani e la natura democratica del loro consenso elettorale137. In un incontro con i rappresentanti di Francia, Germania occidentale e Gran Bretagna nel dicembre 1975, Kissinger dichiarò enfaticamente che l’Alleanza non sarebbe sopravvissuta al «dominio» dei partiti comunisti in Occidente. I leader europei condivisero nella sostanza la sua convinzione che il Pci credesse ancora nella «dittatura del proletariato» e che la sua relativa indipendenza da Mosca non avesse un gran significato. Restava perciò senso comune che la partecipazione dei comunisti al governo in Italia avrebbe destabilizzato la Nato138. In parallelo, Mosca espresse a piú riprese serie riserve e diffidenze per la scelta europea del Pci e l’ipotesi di un polo comunista occidentale, che configuravano un’idea di distensione incoerente con l’assetto bipolare, una contestazione dell’egemonia sovietica nel movimento e una minaccia per la stabilità e il futuro del Patto di Varsavia139.
Nel discorso pubblico, rivolto all’opinione internazionale occidentale, Berlinguer si preoccupò soprattutto di sottolineare che i comunisti italiani non si proponevano di alterare gli equilibri tra i blocchi140. Era consapevole che a Washington e a Mosca prevaleva una politica conservatrice, ma continuava a pensare che la distensione potesse avere molteplici implicazioni. Vedeva soprattutto «un elemento antieuropeo» nella politica di Kissinger, come affermò nel suo incontro con Tito, che avrebbe potuto accrescere la differenziazione tra Europa e Stati Uniti141. D’altro lato, l’Atto finale di Helsinki nell’agosto 1975 riconosceva la divisione europea risalente a trent’anni prima ma allentava i confini della «cortina di ferro» e poteva perciò essere inteso come un inizio invece che un punto di arrivo. Proprio per questo però, come notò Natta, i sovietici vedevano nelle conferenze dei partiti comunisti un «contrappeso» ideologico a Helsinki, cioè un modo per ribadire la compattezza della «comunità socialista» e del comunismo europeo142. La questione disvelò accenti diversi tra i comunisti italiani. Berlinguer e Bufalini puntarono sulla prospettiva della distensione dinamica, subordinando a essa le sollecitazioni volte a intensificare i rapporti con le socialdemocrazie in Europa, provenienti da Amendola e Napolitano143.
Questa scelta rifletteva la convergenza con il governo Moro, il quale identificava Helsinki con gli interessi nazionali, e con le visioni della Chiesa cattolica, che con la sua stessa presenza aveva legittimato le interpretazioni volte a immaginare la fine della guerra fredda144. Nello stesso tempo, è probabile che l’orientamento di Berlinguer vada compreso anche alla luce della congiuntura mondiale segnata dalla dissoluzione dell’impero portoghese in Africa, dalla fine della guerra in Indocina e dall’attualità della questione palestinese in Medio Oriente. Il movimento dei non allineati si presentava come un’alleanza non soltanto negativa, costituita dal rifiuto della logica dei blocchi, ma come un soggetto sufficientemente coeso e propositivo, che aveva imposto nell’agenda mondiale il tema del «nuovo ordine economico». Il riconoscimento degli assetti geopolitici nati alla fine della Seconda guerra mondiale compiuto a Helsinki rappresentava il momento del definitivo ingresso dell’Europa nell’epoca postimperiale e il possibile passaggio verso la fine della sindrome della sicurezza radicata a Mosca. Fu anche per questo motivo che i comunisti italiani svilupparono la loro duplice visione della distensione: da un lato, la presa d’atto delle compatibilità internazionali e la ricerca di legittimità fondata sulla collocazione occidentale; dall’altro lato, l’idea che il cambiamento globale potesse contribuire a rompere le compatibilità del sistema bipolare, indurre cambiamenti nel «campo socialista» e aprire la strada per la nascita di un nuovo sistema internazionale.
Tale duplice visione era l’espressione piú evidente di risposte diverse e sovrapposte alle sfide dell’ultimo decennio. In primo luogo, l’impulso del Sessantotto era all’origine di un rapporto tra il socialismo umanistico e la dimensione europea occidentale, una nuova genealogia a vocazione internazionalista sebbene motivata prevalentemente con il lessico dell’eredità nazionale e del policentrismo togliattiano. Ciò implicava una funzione transnazionale tanto verso la sinistra occidentale, con l’obiettivo di fornire risposte alla «domanda di socialismo», quanto verso gli establishment comunisti, con l’obiettivo di influenzare riforme. In secondo luogo, l’impulso dello shock economico mondiale induceva a leggere con la categoria della crisi l’evoluzione dell’Occidente, mentre si accettava l’immagine di un mondo socialista indenne seppure non piú dinamico come in passato. Anche se i suoi effetti erano da decifrare, lo shock globale sembrava poter creare consensi al rafforzamento del ruolo dello Stato nell’economia capitalistica, spostando l’ago della bilancia in favore di nuove forme di economia mista. Ma soprattutto, la congiuntura mondiale registrava la presenza attiva dei soggetti postcoloniali e il tentativo di stabilire una nuova agenda postbipolare. In questo contesto, il nesso tra Europa e Terzo Mondo assumeva centralità, mentre l’Unione Sovietica manteneva la funzione di un baluardo antimperialista, sebbene la sua riluttanza ad assumere i temi della cooperazione e dello sviluppo costituisse un punto dolente. I comunisti italiani basavano le proprie motivazioni e ambizioni sulle rappresentazioni e sulle prospettive del socialismo umanistico, delle riforme nel mondo socialista e del ruolo globale dell’Europa.
Capitolo sesto
Europeismo e globalismi
1. Il lancio dell’eurocomunismo.
Le visioni dei comunisti italiani si inserirono in diversi vettori delle trasformazioni politiche e culturali alla metà degli anni Settanta. Nel contesto nazionale, i comunisti esprimevano la spinta a modificare la «democrazia bloccata» che raccoglieva consensi nel paese, specie nelle sue regioni piú modernizzate. Condividevano con alcuni esponenti dei partiti di governo una profonda inquietudine per l’impatto sociale e politico della crisi, proponendosi come una forza responsabile della nazione. Messa la sordina sull’antiatlantismo militante, integravano la politica estera dell’Italia in Europa e nel Mediterraneo, o competevano con essa, senza le suggestioni neutraliste del passato. Sotto molti aspetti, esercitavano un’influenza superiore a quella di un partito politico di opposizione e costituivano un tramite del paese nei rapporti globali. Cosí erano percepiti a Washington come in altre parti del mondo, nelle chiavi opposte di una minaccia o di una risorsa per l’Italia1.
Nel contesto dell’Europa, essi miravano a inserirsi tra le forze di movimento dando voce alle interpretazioni piú dinamiche della distensione e ai tentativi di operare una distinzione tra appartenenza europea e lealtà atlantica. Rappresentavano un soggetto minoritario negli istituti della Comunità, ma condividevano con altre forze progressiste i discorsi sul suo ruolo globale, che declinavano nella versione di un nuovo rapporto tra Nord e Sud del mondo alla luce delle idee del «nuovo ordine economico internazionale». Li avvicinava alle componenti di sinistra delle socialdemocrazie l’idea che lo shock economico avrebbe aperto una stagione di ripensamento delle esperienze welfariste, nel senso di una piú intensa propensione pubblica e statale. La loro proposta di un’alleanza comunista occidentale fondata sul connubio tra socialismo e democrazia aveva acquisito credibilità e contestava la logica dei blocchi, sebbene passando sopra a differenze importanti che riguardavano anzitutto la stessa integrazione europea e la tavola dei principî a essa sottesa, inconciliabile con i regimi di tipo sovietico. Le loro idee di riforma non interagivano con le leadership dei partiti al potere nel «campo socialista» ma trovavano ascolto tra esponenti degli establishment e anche tra i dissidenti2.
Nel contesto globale, si presentavano come una forza autonoma dal blocco socialista, dotata di una solida rete di relazioni anche oltre i confini del movimento comunista. I nessi con il Terzo Mondo, anzitutto nel Mediterraneo e in Africa, non incrociavano piú la carica rivoluzionaria delle lotte anticoloniali ma contribuivano alle idee di un ordine mondiale riformato e diverso da quello ineguale e «neocoloniale», con l’ambizione di modificare l’agenda globale grazie al declino dell’egemonia americana dopo il Vietnam. Il loro comunismo riformatore non presentava autentiche propaggini fuori d’Europa, ma si avvaleva delle cospicue reti di relazioni politiche transnazionali stabilite da un ventennio3. In diversi ambienti intellettuali, tanto nel mondo accademico anglo-americano quanto in America Latina, il prestigio del comunismo italiano si legava alla nuova fortuna internazionale del pensiero di Gramsci, ormai affrancato dall’immagine nazionale stabilita nel dopoguerra e presentato autorevolmente da Hobsbawm come l’unico «teorico della politica» nella storia del marxismo. Il nesso che si stabilí di fatto tra il pensiero di Gramsci e la realtà del comunismo italiano era per molti aspetti superficiale, ma coglieva nel segno quanto alle peculiarità intellettuali della sua tradizione4.
Fu Mosca la prima piattaforma internazionale dalla quale Berlinguer decise di lanciare il progetto di un socialismo pluralista incentrato in Europa, parlando al XXV Congresso del Pcus nel febbraio 19765. La scelta aveva un valore altamente simbolico e rivelava quanto quel progetto non fosse separato dall’idea di una riforma degli Stati di tipo sovietico. La risposta sovietica, com’era da aspettarsi, fu gelida. Berlinguer insistette vanamente con Brežnev sulle chance aperte globalmente dal «declino» americano, sull’esigenza che i sovietici si liberassero dal complesso della «fortezza assediata», sul tema della «cooperazione internazionale» e sul ruolo dell’Europa. Tra le questioni piú controverse, egli difese la libertà di espressione a proposito di Andrej Sacharov, pur dichiarando di non condividere le sue idee, e si riferí ai principî di Helsinki. Per la prima volta un leader comunista estendeva al mondo socialista la nozione dei diritti umani, sino allora applicata esclusivamente al Terzo Mondo quale strumento di condanna del colonialismo occidentale, ora legittimata come tassello della distensione internazionale6. Lo scontro sul dissenso intellettuale fu limitato ai discorsi riservati, per scelta diplomatica, ma non era destinato ad attenuarsi. Il pronunciamento pubblico di Berlinguer aveva comunque lasciato una traccia, che dietro le quinte non doveva dispiacere negli ambienti meno conformisti a Mosca e all’Est europeo.
Berlinguer confermava l’interazione di realismo e universalismo nella propria visione, la ricerca della legittimazione occidentale ai fini del governo e la prospettiva di un rilancio internazionalista su basi rinnovate. L’impianto di questa cultura politica riformatrice e anticapitalistica traspare bene nella nota inviatagli pochi giorni dopo da Antonio Tatò, il suo segretario particolare, che faceva riferimento a un colloquio avvenuto tra i due sul tema della «diversità qualitativa» delle basi sociali ed economiche della società sovietica, rispetto a quelle delle società dell’Occidente capitalistico. Il rifiuto della cultura socialdemocratica, a differenza che in passato, non era piú dettato dall’adesione o meno alle politiche dell’Unione Sovietica ma piuttosto dallo scenario di una «trasformazione socialista» in Occidente, che avrebbe dato impulso a riforme nei regimi e nelle società del «socialismo reale». Una simile prospettiva avrebbe assegnato al comunismo italiano un ruolo «di portata mondiale»7. Tatò esprimeva un pensiero comune, ma sembrava anche cercare di fare pressione sul leader, tramite un’enfasi estrema sulla missione dei comunisti italiani che si richiamava al pensiero marxista e cattolico di Franco Rodano. Fermamente opposta alle tendenze moderate all’interno del gruppo dirigente, tale visione insisteva sulla specificità dell’Italia, alla luce degli universalismi cattolico e comunista, fino a delineare una forma di “eccezionalismo”. Berlinguer non era insensibile a una simile ispirazione ma fu attento a evitare un punto di frattura. In vista delle elezioni politiche, che la crisi di governo in Italia aveva nel frattempo reso inevitabili, egli dette spazio al realismo e alla Westpolitik. In questo passaggio Giorgio Napolitano divenne la personalità di riferimento dei moderati, subentrando alla figura di Amendola, che dopo aver dato l’impulso decisivo alla scelta europeista si era defilato dalla strategia dell’eurocomunismo per le sue implicazioni di un distacco dal «campo socialista». Proprio su questo punto invece due personalità diverse come Berlinguer e Napolitano stabilirono una sintonia anche intellettuale, rivolgendosi a una platea italiana e internazionale8.
Il gruppo dirigente comunista mise in moto un attivismo diplomatico senza precedenti verso le socialdemocrazie. Fu questo soprattutto il significato del viaggio di Napolitano in Gran Bretagna nel marzo 1976, dove raccolse manifestazioni d’interesse per il discorso pronunciato da Berlinguer a Mosca. In parallelo, Segre si recò nella Repubblica federale tedesca, mentre due delegazioni rispettivamente guidate da Alfredo Reichlin e da Aldo Tortorella visitarono Svezia, Norvegia, Danimarca e Olanda, Belgio e Lussemburgo. L’agenda di lavoro puntava alla «domanda di socialismo» emergente dai cambiamenti della politica mondiale, che avrebbe movimentato se non spostato le tradizioni socialdemocratiche, valorizzato le ragioni dei comunisti per una riforma radicale del capitalismo e giustificato un avvicinamento tra le due parti9. Un simile approccio rispondeva all’idea che i comunisti italiani costituissero l’autentica avanguardia anche nel contesto della sinistra europea e non soltanto rispetto ai propri partner, una convinzione non sempre idonea a costruire relazioni in Europa. In ogni caso, per la prima volta nella loro storia essi si impegnarono a stabilire rapporti con le socialdemocrazie. Il limite visibile era l’assenza politica e simbolica di incontri al vertice, evitati da entrambe le parti per motivi di consenso interno e opportunità internazionali.
A integrare la ricerca d’inserimento nel contesto occidentale, Berlinguer sostenne in una celebre intervista al «Corriere della Sera», il 15 giugno 1976, pochi giorni prima delle elezioni, che il pieno riconoscimento delle alleanze internazionali dell’Italia non era una scelta riluttante e opportunistica, perché garantiva anche la strategia politica dei comunisti italiani. Rispondendo alla domanda se il Patto atlantico potesse costituire uno scudo protettivo per costruire il «socialismo nella libertà», egli replicò: «Io voglio che l’Italia non esca dal Patto atlantico anche per questo»10. Cosí Berlinguer, rivolgendosi all’opinione pubblica italiana, si difese dalle accuse di incompatibilità con il sistema occidentale e prese le distanze dalla «dottrina Brežnev» nel blocco sovietico. Il 20 giugno 1976, il Pci raggiunse il massimo storico del proprio consenso elettorale, sfiorando il 35 per cento dei voti, anche se restava il secondo partito del paese. Il confronto tra i due blocchi storici dell’Italia repubblicana varcò il punto di equilibrio oltre il quale non era piú possibile governare senza trovare una forma di collaborazione, che la portata della crisi economica rendeva urgente negoziare.
Gli attori internazionali si mostrarono largamente insensibili al dilemma italiano. Con tutte le sue particolarità, il comunismo italiano restava un soggetto diverso dalle socialdemocrazie nella cultura politica e non ne faceva mistero. Pur avendo un’agenda sempre piú simile nella politica nazionale e un largo consenso costruito su programmi e funzioni associabili alle socialdemocrazie, il Pci non possedeva legami internazionali forti in Europa occidentale. Vista dalle principali capitali occidentali, la differenza fondamentale tra il Portogallo o la Spagna e l’Italia era la continuità nel tempo dell’egemonia comunista sulla sinistra. Ciò creava il paradosso per cui l’unico paese dotato di un’esperienza democratica nell’Europa meridionale subiva un trattamento piú inflessibile degli altri. Il rifiuto opposto a Kissinger dagli statisti socialdemocratici circa l’adozione di una «dottrina Brežnev» in Occidente implicava un mutamento rilevante nel modo di operare, ma rispettando i limiti imposti dalla divisione dell’Europa. La questione italiana sembrò anzi ricompattare i governanti occidentali sotto il segno dell’anticomunismo. Il vertice di Portorico tra le maggiori potenze occidentali, svoltosi alla fine di giugno, adeguò ai tempi il “vincolo esterno” sull’Italia, stabilendo un intreccio tra condizionalità economiche e politiche, vale a dire la possibilità di accedere a un prestito del Fondo monetario internazionale per far fronte al precipitare della situazione finanziaria del paese, a condizione che i comunisti non entrassero nel governo. Tale condizione fu resa pubblica da una dichiarazione attribuita al cancelliere Helmut Schmidt il 15 luglio, prima della formazione del nuovo governo in Italia. Questa concezione evitava di evocare le teorie del domino kissingeriane e mirava a una stabilizzazione democratica nel quadro delle interdipendenze economiche occidentali. Ma rappresentava anche un’interferenza che rispecchiava le regole non scritte dell’ordine bipolare11.
La partecipazione di Berlinguer alla Conferenza di Berlino dei partiti comunisti europei, alla fine di giugno, mandò un segnale ambivalente, che poteva essere letto sia nella luce di un’ulteriore manifestazione di diversità, sia in quella dell’appartenenza malgrado le differenze. Berlinguer decise di andare a Berlino dopo un lungo negoziato, sulla base della convinzione che interrompere l’intesa tra il Pci e il Pcus sulla distensione, per quanto vaga, avrebbe costituito un errore strategico. Nel catalogo delle questioni presentate da Berlinguer non vi erano omissioni, a cominciare dal tema del ruolo mondiale dell’Europa e del «nuovo ordine economico internazionale», per finire con la rivendicazione del dissenso sull’invasione della Cecoslovacchia. Egli colse l’occasione per adottare pubblicamente il termine di «eurocomunismo», la cui circolazione a suo giudizio dimostrava l’ampiezza delle aspirazioni per una trasformazione socialista «di tipo nuovo» in Europa. Distinse tre piani di azione: la distensione paneuropea, la convergenza con altre forze progressiste europee e la prospettiva di «democratizzare» la Comunità Europea12. L’obiettivo principale era collocare il discorso dei comunisti italiani in un panorama di fatto pluralista del movimento comunista, anche grazie alla partecipazione di Tito. Berlinguer incassò l’apparente tolleranza dei sovietici, che avevano scelto una linea conciliante pur di esibire la loro capacità di chiamare a raccolta tutti i partiti comunisti europei attorno alla bandiera dell’«internazionalismo proletario»13.
La formazione del governo Andreotti, basato sull’astensione del Pci in Parlamento, offrí una soluzione precaria ma sufficiente a ottenere il finanziamento internazionale necessario al paese, sulla base di un duro programma di sacrifici. I comunisti si trovarono nella scomoda posizione di sostenere quel programma senza poter mettere sull’altro piatto della bilancia, per la propria base militante ed elettorale, l’ingresso nella compagine di governo. Sin dall’inizio, la strategia democristiana presentò il carattere ambiguo di una intesa necessaria ma anche di un logoramento del consenso del Pci, sebbene Andreotti e Moro avessero idee diverse circa le strategie piú o meno idonee e inclusive per ottenere questo risultato. Berlinguer non aveva altre opzioni che puntare sulla futura partecipazione al governo, instaurando insieme alla collaborazione anche un braccio di ferro per superare i veti interni e internazionali. La formula della «solidarietà nazionale» non costituiva perciò il ritorno all’«unità nazionale» postbellica invocato dai comunisti. Rappresentava un’apertura alla collaborazione tra i due blocchi e, nel contempo, l’apice dell’assedio reciproco risalente alle origini della guerra fredda. Il bipolarismo italiano presentava molto meno che in passato l’aspetto di lealtà internazionali diametralmente opposte, ma il vincolo delle grandi potenze era attivo non meno delle componenti intransigenti nei due blocchi politici e sociali.
L’avvento dell’amministrazione Carter e l’uscita di scena di Kissinger sembrarono introdurre sensibili cambiamenti in quel panorama. Il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, Zbigniew Brzezinski, marcò le distanze dal suo predecessore liquidando la priorità del balance of power. Ciò non significava che Washington avrebbe aderito a una prospettiva dinamica della distensione, ma piuttosto adottato un approccio rivolto a legare insieme la distensione in Europa, le rivalità imperiali nel Terzo Mondo e le strategie globali14. In un simile contesto, l’eurocomunismo poteva essere visto come un’opportunità e non soltanto come un problema, dal momento che metteva in discussione l’influenza di Mosca e contribuiva ad accrescere la vulnerabilità sovietica nell’Europa centro-orientale. Alla vigilia delle elezioni negli Stati Uniti si verificò un passaggio insolito e significativo. Segre fu invitato a una riunione della Commissione trilaterale, il gruppo informale creato tre anni prima da David Rockefeller e animato da Brzezinski, riportando a Berlinguer l’impressione di un’apertura15.
Le aspettative del Pci erano incoraggiate dalla ricezione empatica dell’eurocomunismo negli ambienti intellettuali liberal americani, in particolare tra gli studiosi che dopo il Sessantotto avevano liquidato le teorie volte a stabilire un legame tra l’ideologia dello sviluppo e l’insediamento sociale dei partiti comunisti. Era questo il caso di Joseph LaPalombara, Sidney Tarrow, Donald Blackmer, Peter Lange. La mancata concessione del visto per Giorgio Napolitano, invitato da Stanley Hoffmann nel 1975, non aveva impedito una crescente attenzione positiva verso il Pci, in contrasto con gli orientamenti di Kissinger, volta a suggerire una linea piú realistica dell’amministrazione americana verso l’Italia16. L’esordio del nuovo ambasciatore in Italia Richard Gardner, strettamente legato a Brzezinski e membro della Commissione trilaterale, fu quanto mai prudente e alimentò la percezione di una nuova politica americana in Italia, che poteva generare speranze o apprensioni a seconda dei punti di vista. Tuttavia, l’eurocomunismo restava una criticità, anzitutto agli occhi di Gardner e di Brzezinski17. I comunisti italiani svilupparono i contatti con l’ambasciata americana, avviati da Segre due anni prima e intrattenuti anche da Barca, ma non in una misura pari alle altre forze politiche18. In poche parole, l’aspettativa che la parola d’ordine «né ingerenza né indifferenza» significasse un chiaro distacco dalle categorie kissingeriane era fuori luogo. Nel luglio 1977, in una conversazione con il senatore comunista Franco Calamandrei, il giornalista del «Washington Post» Leo Wollemborg criticò la raffigurazione semplicistica dell’amministrazione Carter fatta dai comunisti italiani19.
La percezione di una nuova politica americana si fece strada anche a Mosca. Un dirigente del Dipartimento internazionale del Pcus come Anatolij Černjaev pensava che Brzezinski avesse preso «a giocare con l’eurocomunismo» e che per una «potenza ideologica» come l’Unione Sovietica il gioco potesse farsi «piú pericoloso del potenziale nucleare degli Stati Uniti»20. Il potenziale destabilizzante individuato nell’eurocomunismo da un analista empatico come Černjaev era altrettanto ben avvertito dalle leadership conservatrici a Mosca e nell’Europa dell’Est. Iniziata la propria partecipazione alla «solidarietà nazionale» senza poter contare su alcuna concreta apertura in Occidente, il Pci dovette anche fronteggiare la reazione di Mosca. Il discorso di Berlinguer alla Conferenza di Berlino aveva suscitato ripercussioni nell’Europa orientale, che Segre menzionò pubblicamente21. I leader sovietici liquidarono la loro tolleranza, spalleggiati dai tedeschi orientali. All’inizio del 1977, Berlinguer fu informato da Ceauşescu che Brežnev aveva esplicitamente invitato i leader dell’Europa orientale a adottare un orientamento intransigente e aggressivo, puntando ancora una volta il dito contro l’europeismo dei comunisti italiani22. Con i comunisti italiani coinvolti in un patto di governo e le imprevedibili conseguenze della fine dell’epoca di Kissinger, la leadership sovietica temeva il rischio di instabilità nella propria sfera d’influenza, specie in Polonia dopo le proteste operaie dell’estate 1976. La circostanza aggravante era che gli eurocomunisti figuravano tra le voci critiche circa la repressione della libertà di espressione nei paesi socialisti. Il tema dei diritti umani era divenuto particolarmente scottante perché l’amministrazione Carter ne aveva fatto il suo cavallo di battaglia, mentre i dissidenti di Charta 77 in Cecoslovacchia indicavano una strada legale di autodifesa, costituita dall’appello agli accordi di Helsinki. Una figura simbolica come Mlynář si rivolse nel gennaio 1977 ai leader eurocomunisti e della sinistra occidentale per denunciare la repressione contro i firmatari di Charta 77, ricordando il passato comunista e antifascista di molti di loro23. Il suo messaggio legava l’eredità della «primavera di Praga» alla critica delle società di tipo sovietico fondata sul linguaggio dei diritti umani e delle libertà, senza dismettere l’idealità socialista. Cosí fu accolto da alcuni intellettuali vicini al Pci24.
I tre partiti eurocomunisti organizzarono un meeting a Madrid per la fine di febbraio 1977, che doveva costituire l’atto conclusivo dell’alleanza. L’evento nascondeva tensioni significative. I protagonisti non erano d’accordo tra loro neppure sulla nozione di europeismo. Amendola fece notare alla Direzione del partito che «socialisti, socialdemocratici, democristiani e liberali hanno costituito partiti a livello europeo», mentre «noi non potremo creare un Pc europeo» perché «i comunisti, sul concetto di Europa, sono i piú divisi»25. Nello stesso tempo, Mosca tentò di impedire che si svolgesse l’incontro, inviando un messaggio che metteva in guardia dal compiere passi irreparabili verso una «scissione»26. Europeismo e distensione dinamica implicavano ormai una rotta di collisione con Mosca27. Berlinguer, Carrillo e Marchais riaffermarono genericamente a Madrid l’idea di sfruttare lo spazio della distensione per realizzare cambiamenti nei rispettivi paesi e in Europa. A questo punto, l’eurocomunismo era divenuto un fattore internazionale di primo piano, in grado di combinare il consenso e il ruolo nazionale dei tre partiti con un profilo apparentemente unitario. Esso sfidava l’ordine bipolare tramite la candidatura a entrare nella sfera del governo di importanti paesi nella sfera occidentale, l’ambizione di fondare una prospettiva di trasformazione socialista e democratica, la critica del modello sovietico e il linguaggio dei diritti umani, la visione della distensione come cambiamento, la partecipazione critica alla Comunità Europea, il nesso con le rivendicazioni dei paesi non allineati per una ristrutturazione delle relazioni economiche mondiali.
Ciascuno di questi aspetti e obiettivi poteva alterare delicati equilibri strategici. In realtà, nessuno di essi formava un tessuto autenticamente condiviso dagli eurocomunisti. Le loro critiche al socialismo sovietico mostravano per lo piú una funzione strumentale nella politica nazionale, assai meno un codice comune transnazionale. Le nozioni di pluralismo ed europeismo costituivano una tavola dei principî controversa e imprecisa. Le rispettive visioni della crisi dell’ordine bipolare e del «nuovo ordine economico internazionale» non coincidevano tra loro. In piú, l’influenza dell’eurocomunismo appariva comunque limitata e contenibile. In Europa le socialdemocrazie e i partiti-Stato dell’Est facevano muro sotto ogni punto di vista, sia sul piano delle ideologie sia respingendo opzioni destabilizzanti per la distensione. Fuori d’Europa, le relazioni globali coltivate da tempo dai francesi e dagli italiani non traevano necessariamente alimento dall’alleanza eurocomunista, che anzi poteva essere vista come un’ipotesi strategica soprattutto attiva lungo l’asse Est-Ovest.
È tuttavia un dato di fatto che gli establishment occidentali e comunisti avvertirono l’eurocomunismo come una minaccia, malgrado l’evidenza di simili fragilità e incongruenze. In questo senso, la vicenda appare rivelatrice di quanto fossero radicate le visioni incentrate sulla guerra fredda. A Washington l’incubo dell’«effetto domino» non era liquidato. Fu però Mosca ad alzare il livello del contenimento, definendo l’eurocomunismo come una forma di «revisionismo». Nei mesi successivi, iniziarono le operazioni coperte del Kgb volte a screditare Berlinguer e seminare la discordia tra i comunisti occidentali28. La percezione della minaccia ideologica rappresentata dall’eurocomunismo fu distintiva anche di altri establishment comunisti, in particolare nella Germania orientale29. All’inizio di luglio, quando Mosca aveva aperto la polemica pubblica prendendo a bersaglio Carrillo, Suslov si incontrò con una delegazione italiana composta da Bufalini, Pajetta e Macaluso. Il dirigente sovietico accusò il Pci di avere rinunciato all’«internazionalismo proletario» e di offrire una sponda alle accuse di violazione dei diritti umani rivolte all’Unione Sovietica in Occidente. Prese a bersaglio Napolitano, che si era pubblicamente espresso confermando la linea del realistico riconoscimento delle alleanze internazionali dell’Italia. Ma il suo attacco frontale investiva anche Berlinguer. I dirigenti del Pci avevano scelto preventivamente di adottare il massimo della diplomazia ed evitarono di aggravare la tensione30.
Berlinguer tenne ferma la propria rotta, malgrado le difficoltà nei rapporti con il Pcf, aggravate dalla crisi dell’Union de la gauche in Francia. Egli presentò l’eurocomunismo come una tavola di principî e non solo come un’alleanza politica. Scelse cosí di non seguire il consiglio dei suoi due interlocutori principali, Tito e il leader ungherese János Kádár. Entrambi solidali e scettici, consigliavano prudenza sul discorso universalista e sulle posizioni di principio, che all’Est rischiava di avere effetti di irrigidimento tra modelli, opposti a quelli desiderati31. Il discorso di Berlinguer a Mosca in occasione del sessantesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre costituí una sfida valoriale, con la definizione della democrazia come un «valore storicamente universale». Una simile definizione poneva di fatto il problema del rapporto tra socialismo e democrazia anche nel cuore del «socialismo reale». L’incontro tra Berlinguer e Brežnev si svolse nel gelo reciproco e senza un autentico scambio di opinioni32. Il linguaggio universalista di Berlinguer calamitò l’attenzione mediatica internazionale33.
2. La «solidarietà nazionale» e il “vincolo esterno”.
Nell’esperienza della «solidarietà nazionale», Berlinguer combinò il proprio lato realista con la visione di una trasformazione dell’Italia. Egli presentò i sacrifici chiesti ai lavoratori come una forma di «austerità» che recava in sé un’inversione di marcia rispetto alla traiettoria della società dei consumi e un’idea di società consapevole dei problemi legati allo sviluppo e all’ambiente34. Il tema dell’anticonsumismo era in armonia con sentimenti e aspirazioni presenti tra i cattolici che dopo il referendum sul divorzio cessarono di vedere nella Dc il loro punto di riferimento35. Il discorso sull’austerità costituiva anche un motivo di consonanza con le componenti socialdemocratiche volte a ripensare l’esperienza welfarista, tanto che Palme elogiò Berlinguer in un colloquio riservato con Segre36. I comunisti italiani svolsero un ruolo importante nelle politiche dei diritti e nella costruzione di un sistema sanitario nazionale, che consegnava al paese una struttura essenziale del welfare. La loro partecipazione nell’area di governo chiudeva cosí il ciclo riformatore che era stato avviato dal centro-sinistra oltre un decennio prima37. La scelta europeista e l’abbandono dell’antiatlantismo intransigente consolidavano il patto di governo e costituivano un veicolo di legittimazione, alla luce della solenne dichiarazione fatta in Parlamento sulle alleanze internazionali del paese alla fine del 197738. Idealmente, tale accordo abbatteva un muro della guerra fredda interna e sanciva un lungo processo di convergenza, che vedeva i comunisti colmare il proprio handicap sulla integrazione europea e contribuire alla formazione di un largo consenso nazionale europeista. Nello stesso tempo, l’accento sulla politicizzazione dello spazio europeo li poneva in una posizione attiva e non solo nelle vesti dei convertiti, dal momento che costituiva parte integrante del loro discorso sulla distensione come fine della guerra fredda.
La «solidarietà nazionale» non fu però in grado di contenere, e per molti aspetti alimentò, varie manifestazioni di disagio, opposizione e protesta nella società italiana. Il senso della responsabilità e del sacrificio necessario che costituiva l’elemento centrale del discorso dei comunisti e dei democristiani non fu riconosciuto come un elemento sufficiente a controbilanciare le paure degli ambienti anticomunisti intransigenti, a rassicurare le forze che paventavano una preponderante consociazione politica, e neppure a giustificare politiche moderate nei settori piú politicizzati delle giovani generazioni. Le tensioni sociali furono seriamente aggravate dal dilagare della violenza politica. La decisione presa dal gruppo dirigente comunista nel dicembre 1977 di aprire la crisi di governo fu per molti aspetti inevitabile, legata com’era alla crescente percezione di una perdita di consensi, persino tra gli operai e nel proprio elettorato, e all’esigenza di aprire una prospettiva di governo39. Tale prospettiva presentava una sequenza logica dopo la conclusione dell’accordo programmatico condiviso in Parlamento sulla politica interna e sulla politica estera, che aveva però significato sulla scena nazionale, molto meno su quella internazionale.
Nel contesto della crisi di governo, i legami internazionali dei comunisti mostravano un panorama in sensibile evoluzione ma anche la mancanza di una rete protettiva. I tempi della Westpolitik del Pci non coincidevano con l’accelerazione politica in Italia. Il primo incontro riservato tra Berlinguer e Brandt si svolse nel giugno 197740. Brandt era una figura di prestigio, da poco eletto presidente dell’Internazionale socialista, ma si trovava in minoranza nella Spd. I contatti con altri partiti socialdemocratici, in particolare il Partito laburista e i socialisti svedesi, si svolgevano all’insegna di un tiepido interesse reciproco che non dava luogo a iniziative concrete. Varie personalità e settori dei partiti socialisti restavano fermamente anticomuniste. Alla fine del 1977, i rapporti tra comunisti italiani e socialisti europei iniziarono anche a risentire negativamente delle ripercussioni che aveva avuto la rottura dell’alleanza di sinistra in Francia, che chiaramente indeboliva le prospettive eurocomuniste41. I limiti delle relazioni occidentali del Pci emergevano dal resoconto di Segre a Berlinguer, subito prima del suo viaggio a Mosca, circa una riunione della Trilaterale a Bonn. L’incontro aveva registrato un attacco di Kissinger, spalleggiato da Gardner, al socialdemocratico Richard Löwenthal, volto a respingere ogni credito all’eurocomunismo, mentre Brzezinski si sarebbe mantenuto su posizioni piú caute. L’atteggiamento dei socialdemocratici tedeschi era diverso da quello degli americani, dato che i primi erano interessati a integrare l’eurocomunismo in una dimensione di stabilità dell’Europa occidentale, mentre i secondi a impiegarlo come strumento di destabilizzazione dell’Europa centro-orientale. Nessuno però contemplava una prospettiva prossima di governo per i comunisti italiani. La fonte di Segre suggeriva che il punto autentico non fosse arrivare alla rottura con Mosca, ma semmai ottenere l’assenso tedesco occidentale al principio e alla pratica della «non interferenza»42. Non era chiaro in che modo si potesse verificare un passaggio del genere. Di certo, il conflitto con Mosca si svolgeva largamente dietro le quinte e contribuiva a esibire l’autonomia del comunismo italiano meno di quanto sarebbe stato possibile. Tale condotta rispondeva alla ricerca d’influenza che costituiva da tempo un tratto irrinunciabile della strategia del Pci e che disegnava ora un circolo vizioso. L’evoluzione europeista e la ricerca di legittimazione dei comunisti italiani moltiplicavano i motivi di conflitto con il socialismo sovietico. Ma una eventuale rottura avrebbe compromesso la possibilità di sollecitare riforme dei sistemi socialisti e, in ultima analisi, metteva a rischio la loro stessa identità diversa dalla socialdemocrazia. Di conseguenza, si sviluppò una tensione estrema tra l’obiettivo della legittimazione occidentale e l’identità del comunismo riformatore.
La debolezza delle alleanze internazionali del Pci agevolò il compito dell’ambasciatore Gardner, deciso a impedire che i comunisti accedessero al governo del paese. Tra la fine del 1977 e l’inizio del 1978, Gardner sollecitò l’amministrazione Carter a prendere posizione per prevenire passi che potessero favorire l’influenza comunista43. Il 12 gennaio 1978, il Dipartimento di Stato emanò una dichiarazione che riaffermava il veto americano contro la partecipazione dei comunisti al governo di paesi membri dell’Alleanza atlantica. La crisi delle relazioni bipolari, la riluttanza dei governanti europei a rischiare di compromettere la distensione, le contraddizioni e le tensioni domestiche italiane contribuirono a tenere in vita il paradigma di Kissinger44. I comunisti reagirono duramente alla dichiarazione americana, ritenendola non a torto una palese violazione del principio della «non interferenza». Tuttavia, la loro forza contrattuale era diminuita rispetto all’estate 1976, mentre le relazioni in Europa occidentale restavano sostanzialmente invariate da allora. Le loro carte da giocare dipendevano, piú ancora di prima, dalla strategia gradualista di Moro, che si proponeva di inserire il Pci nella maggioranza parlamentare. Berlinguer non aveva altra scelta che seguire questa strada, come fu evidente nell’ultimo incontro tra i due leader, il 16 febbraio, anche se essi svolsero la considerazione che, «al di là dei tempi», sarebbe stato un «passaggio necessario» governare insieme per un periodo delimitato ai fini del riconoscimento reciproco45.
Si è spesso insistito sulle convergenze politiche e progettuali di Moro e Berlinguer. Entrambi tentarono di fornire risposte alla crisi di un intero assetto postbellico, anche se Moro puntava a contenere l’onda lunga del Sessantotto, Berlinguer a svilupparla. Erano consapevoli di ereditare un compito essenziale dai padri fondatori della Repubblica, quello di governare la bipolarità italiana mettendo sotto controllo i suoi aspetti piú conflittuali e destabilizzanti. In questa ottica, condividevano l’idea che l’auto-contenimento dei due poli italiani nella guerra fredda non fosse piú sufficiente a garantire gli assetti democratici della Repubblica e a praticare una fuoriuscita dalla crisi. Li avvicinava anche l’idea che la distensione europea, inserita in una Comunità economica piú larga e stabile, potesse consentire di negoziare un “vincolo esterno” rinnovato e di modificare la “costituzione materiale” della politica italiana, pur senza smantellarne la struttura bipolare. La figura di Moro simboleggiava molte cose insieme: il potere democristiano e il tentativo di ricostituirne l’egemonia su nuove fondamenta, la cooptazione di un grande partito comunista nella sfera di governo occidentale, una strategia di cambiamento nazionale che fuoriusciva dagli schemi della guerra fredda. Tutto ciò gli procurò molti nemici, un destino che lo accomunava a Berlinguer46. I due leader mostrarono però anche prospettive diverse circa la nozione stessa di «solidarietà nazionale». Moro si fece referente di una linea che mirava al graduale riconoscimento reciproco tra le grandi forze politiche nazionali, con l’obiettivo di coinvolgere i comunisti in una responsabilità istituzionale, assai piú che associarli ad autentiche responsabilità di governo. Berlinguer invocava invece la difesa della sovranità nazionale quale scudo del «compromesso storico», con l’obiettivo di formare una coalizione di governo ispirata al precedente dell’unità antifascista. Questa differenza non era soltanto contingente. In realtà, non si profilò un fronte comune volto a ridisegnare il nesso tra ordine internazionale e politica nazionale in Italia, ma piuttosto la ricerca di una collaborazione necessaria per fronteggiare l’emergenza del paese.
Il rapimento di Moro da parte delle Brigate Rosse, il 16 marzo 1978, spezzò un equilibrio precario. La tragedia della prigionia conclusasi con il suo assassinio il 9 maggio mise a nudo tutta la fragilità politica della «solidarietà nazionale». La linea della fermezza adottata dai gruppi dirigenti della Dc e del Pci rispecchiò un’unità emergenziale. L’assassinio di Moro costituí uno shock per l’intera classe dirigente e per l’opinione pubblica italiana, ma non produsse l’effetto di un vero compattamento politico. L’“affare Moro” non dette luogo una ricomposizione della comunità nazionale, pur ponendo le premesse per il declino del terrorismo e della violenza politica nel paese. Le Brigate Rosse incentrarono i loro atti d’accusa contro Moro attorno allo stereotipo del «regime» democristiano come mera emanazione del capitalismo globale. L’idea stessa che sottoporre a interrogatorio il prigioniero fosse il modo per disvelare il volto nascosto del potere costituiva una subcultura e una mitologia della cospirazione. In realtà, i brigatisti non diffusero i testi creati dagli interrogatori, il cosiddetto «memoriale» di Moro, forse perché le sue riflessioni politiche e autobiografiche non si prestavano all’uso propagandistico che avrebbero voluto farne47. Nello stesso tempo, il loro schematico vocabolario marxista era sufficiente a rivelare una filiazione difficile da accettare per i comunisti, eppure lacerante e imbarazzante, anche perché condivisa nelle aree di consenso esistenti verso il terrorismo rosso. I lati oscuri della vicenda si rivelarono subito inquietanti, ma nessuna teoria del complotto poteva occultare l’evidenza dell’«album di famiglia», secondo la famosa definizione di Rossana Rossanda, anche se il marxismo non era l’unica matrice ideologica dei brigatisti48. Tra gli effetti simbolici dell’“affare Moro”, è difficile sopravvalutare l’amplificazione mediatica di quel linguaggio e le ripercussioni suscitate nel corpo politico di una nazione che tra le sue fratture conosceva, piú di ogni altra in Europa, l’antinomia di comunismo e anticomunismo.
La reazione dei comunisti fu di enfatizzare al massimo la missione della difesa delle istituzioni. Di qui la necessità di una rivendicazione identitaria che rischiava di confliggere con la relativa flessibilità delle strategie varate da alcuni anni. Due anni prima, sempre nella celebre intervista al «Corriere della Sera», Berlinguer aveva riconosciuto che c’era «un certo azzardo» a seguire una strada che non piaceva «né di qua né di là», nei due poli internazionali della guerra fredda. Due anni dopo, sotto questo profilo, si poteva trarre un bilancio della «solidarietà nazionale». L’idea di forzare i vincoli esterni nella scena nazionale, grazie alla distensione e al consenso sociale, si scontrava con una dura replica. I vincoli della guerra fredda si erano ampiamente manifestati prima dell’“affare Moro”. Washington esercitò il proprio peso per sostenere l’orientamento della fermezza prevalente nel governo Andreotti, senza nulla concedere ai comunisti, perché temeva il pericolo di una destabilizzazione dell’Italia. Nelle sue lettere dalla prigione brigatista, Moro alluse piú di una volta al ruolo che gli americani esercitavano nel senso di ostacolare la possibilità di negoziati49. Le tracce dei rapporti tra le Brigate Rosse e i servizi segreti dell’Est europeo, che i comunisti italiani identificarono, testimoniavano probabilmente molto piú una risalente ostilità nei confronti di Berlinguer che non una credibile presenza nell’“affare”50.
Il dato di fatto era che il Pci faceva parte della maggioranza, ma non vedeva prospettive di governo e aveva perso il suo unico interlocutore nel campo avversario. Le elezioni amministrative del maggio 1978 fornirono i primi segnali di una seria perdita di consensi. La priorità divenne quella di difendere un’identità appannata sia nella promessa di mettere fine alla «democrazia bloccata», rivolta agli elettori, sia nell’ambizione di introdurre «elementi di socialismo» nella società italiana, rivolta ai militanti. La tragedia di Moro assumeva il significato di una strada non presa e tale era destinata a rimanere nel tempo, in molte narrazioni postume. Queste però rappresentavano una semplificazione di problemi irrisolti che investivano tanto i comunisti quanto l’intera società italiana. Il paradosso della «solidarietà nazionale» era che aveva posto le premesse per salvare il paese da una grave crisi economica e sociale, senza però creare una soluzione politica stabile e legittimata. Ciò era la conseguenza combinata di rigide compatibilità esterne e di confini invalicabili tra gli stessi blocchi politici nazionali51.
Il «compromesso storico» e l’eurocomunismo conobbero una crisi simultanea. Da sempre assai tiepido verso entrambe le strategie, Amendola scrisse a Berlinguer criticando quella che riteneva una «adesione acritica» alla politica estera italiana e una subordinazione alla Dc52. La reazione di Berlinguer non fu univoca, ma combattuta tra l’appello identitario e la salvaguardia delle proprie acquisizioni. Fu questo il doppio registro adottato in pubblico il 24 luglio 1978, davanti al Comitato centrale. Pur rivendicando la linea dell’austerità e la posizione della fermezza nell’“affare Moro”, egli dichiarò esplicitamente che occorreva correggere l’impressione di una debole difesa dell’identità comunista nei confronti delle altre forze politiche nazionali. Toccò anche, dopo un periodo di relativo silenzio, il tema dell’internazionalismo. Il punto principale stava nel «duplice rifiuto» di prospettare «sia modelli come quelli sinora realizzati in Oriente sia i modelli socialdemocratici», i primi per motivi di «garanzia delle libertà», i secondi perché «il sistema capitalistico non ha piú una prospettiva che assicuri lo sviluppo indefinito delle forze produttive e della democrazia». Era a questo livello, secondo ogni evidenza, che si doveva davvero forgiare l’identità comunista occidentale. Berlinguer la definiva come il progetto di un «rinascimento socialista europeo» che non ambiva soltanto a risanare e innovare la società italiana, ma doveva avere un respiro mondiale53. In altre parole, nel momento di maggiore difficoltà egli rilanciò tutta l’ambizione della propria visione politica, che raffigurava il comunismo italiano come un’avanguardia in Europa.
Il discorso pubblico di Berlinguer seguí le linee di una nota inviatagli qualche giorno prima da Tatò, ferocemente avversa a Craxi quale avversario principale del «compromesso storico» e dell’eurocomunismo, vale a dire dell’«unica politica che rimane rivoluzionaria» in Europa. Vi era sottesa una visione non equidistante tra socialismo sovietico e socialdemocrazia. Il primo restava «comunque superiore» alla seconda e rinnegare questo assunto avrebbe significato rompere le righe e ammettere un «errore» originario54. Le parole di Tatò estremizzavano una logica condivisa da un ambiente politico e intellettuale piú ampio del gruppo dirigente. L’idea cioè che le società di tipo sovietico avessero «potenzialità» ancora inespresse, se riformate e liberate dalla cappa di piombo dei regimi autoritari. La posizione dei comunisti italiani sul dissenso all’Est, che rivendicava la libertà di espressione ma tendeva anche a selezionare tra dissidenti socialisti e non, dipendeva da una simile visione55. Il giudizio sulla socialdemocrazia come esperienza fallimentare non era nuovo, cosí come l’idea che i comunisti avrebbero beneficiato del tramonto della trentennale stagione welfarista. Berlinguer sembrava però spostare la propria ottica verso la priorità di una rivendicazione identitaria della tradizione leninista. Fu questo il suo cavallo di battaglia negli interventi pubblici dell’estate 197856.
La Westpolitik dei comunisti italiani raggiungeva cosí il suo limite. Il viaggio di Napolitano negli Stati Uniti del maggio 1978 poteva essere visto solo nell’ottica di un investimento a lungo termine, dal momento che aveva assunto il carattere di un tour negli ambienti intellettuali e liberal senza contatti con personalità significative sul piano politico e istituzionale57. L’incontro di Berlinguer con Brandt del luglio 1978 si incentrò sul reciproco contributo che, da collocazioni diverse, era possibile dare per salvaguardare la distensione europea58. Nella seconda metà dell’anno, Berlinguer incontrò gli interlocutori principali degli anni piú recenti, ma con un atteggiamento piú disincantato e meno propositivo, volto a verificare le rispettive opinioni sullo stato comatoso della distensione. Egli vide nell’ordine Marchais, Brežnev e Tito. Come già accaduto in precedenza, l’incontro con il leader francese fu inconcludente, quello con il sovietico aspro, quello con lo iugoslavo consonante.
Berlinguer si scontrò con Suslov, Ponomarëv e Brežnev in un modo senza precedenti nella storia delle relazioni tra i comunisti italiani e Mosca nel dopoguerra. La divergenza tra le due parti aveva ormai assunto toni impossibili da diplomatizzare se fossero divenuti pubblici. Il leader italiano stabilí un nesso diretto tra l’eredità della «primavera di Praga» e il tema dei diritti umani, del dissenso e del pluralismo, ricevendo in risposta l’accusa di difendere «spie» e di sostenere la campagna di Carter. Egli trasformò le sue precedenti esortazioni in un rimprovero, sostenendo che mentre si aggravava la crisi del capitalismo e cresceva il «bisogno di socialismo», mancava «una grande forza di attrazione dell’ideale socialista», insinuando chiaramente che ciò fosse soprattutto una conseguenza della condotta e dell’immagine dell’Unione Sovietica. I sovietici lo ammonirono ancora una volta che il loro era l’unico «socialismo reale», mentre l’eurocomunismo sarebbe stato soltanto un ideale astratto, con l’aggravante di dividere il movimento comunista. Brežnev presentò una requisitoria contro la «nuova Monaco» rappresentata dall’appeasement tra Stati Uniti e Cina e criticò l’esperienza della «solidarietà nazionale» perché a suo avviso aveva legato ancora piú strettamente l’Italia alla Nato in un momento cosí grave. Il risultato delle consultazioni di Berlinguer induceva al pessimismo, che egli condivise con Tito, sebbene entrambi ritenessero che fosse negli interessi dei sovietici preservare la distensione59. Rientrato a Roma, Berlinguer apparve a Barca particolarmente scoraggiato60. I dirigenti italiani avvertirono il rischio di un isolamento, che ai loro occhi aumentava il valore di una mobilitazione pacifista di massa, in vista della nuova fonte di tensione internazionale rappresentata dal problema dei missili di teatro in Europa.
Berlinguer decise di mettere fine alla «solidarietà nazionale» alla fine del 1978. I comunisti votarono in Parlamento contro l’adesione italiana al sistema di compatibilità monetarie europee, che giudicavano rigido e inconciliabile con la prospettiva di politiche sociali. Tale scelta costituí soprattutto un modo per uscire dai vincoli di maggioranza e non diminuiva la loro vocazione europeista, che anzi si consolidò in vista delle prime elezioni a suffragio universale. In linea con la propria visione, Amendola invocò un salto di qualità dell’integrazione europea e la creazione di un «forte potere plurinazionale»61. La crisi della distensione offuscava però la possibilità di distinguere tra europeismo e atlantismo, lo spazio politico essenziale che aveva consentito ai comunisti italiani di concludere l’intesa sulla politica estera con le forze di governo un anno prima. Ora quell’intesa si rivelava piú il punto di arrivo di una lunga convergenza nazionale che non la carta programmatica di una nuova politica in Italia. Sulla scena nazionale, Berlinguer continuò a rivendicare la linea dell’austerità e della fermezza contro il terrorismo, riproponendo la questione comunista come chiave di volta per l’esercizio di una funzione di direzione politica. Diversamente l’Italia sarebbe sprofondata verso la decadenza e l’ingovernabilità. Tuttavia, il profilo della responsabilità istituzionale aveva largamente oscurato le aspettative riformatrici che erano state alla base dei consensi del Pci. I comunisti non avevano presentato un chiaro disegno riformatore della «democrazia bloccata», ma soltanto la prospettiva di essere associati al governo del paese per far fronte all’emergenza nazionale coinvolgendo il mondo del lavoro, e nello stesso tempo avevano alimentato ambizioni di trasformazione scarsamente realistiche. La fine dell’emergenza e la crisi della distensione rendevano meno attuale la «questione comunista» in Italia.
Berlinguer si concentrò soprattutto sulla difesa dell’identità e della cultura politica. Dopo l’apertura della crisi di governo nel gennaio 1979, esplicitò la visione della «terza via» tra socialdemocrazia e socialismo sovietico, che aveva già delineato. Nel suo discorso al XV Congresso, il 30 marzo, inserí tale nozione in una visione storicista che assegnava al movimento operaio dell’Europa occidentale il compito di aprire una nuova epoca dopo quelle segnate dalla Seconda Internazionale e dalla Rivoluzione d’ottobre. Impiegò cosí una grammatica storica distintiva della tradizione comunista italiana e un codice per rivendicare, ma anche idealmente mettere alle spalle, il nesso con il comunismo sovietico. Come è stato notato, questa impostazione lasciava invece completamente in ombra l’esperienza del welfare socialdemocratico62. Di conseguenza, sembrava avere l’obiettivo di rinnovare la carta d’identità dei comunisti italiani ma anche riaffermare il marchio d’origine nel momento di aprirsi ad altri soggetti e platee progressiste. Il tentativo di applicare il «compromesso storico» si trovava alle spalle, ma non lo era la prospettiva di una forza rivoluzionaria e occidentale. Quella visione consentiva a Berlinguer di manifestare un pensiero covato già da alcuni anni. Egli dichiarò che non era «corrispondente ai tempi» parlare «in senso stretto di un movimento comunista internazionale»63. In altre parole, enunciò un principio di autosufficienza del Pci, che cercava di ribaltare l’isolamento politico in un punto di forza, cioè nella condizione per la libera affermazione di una visione universalista. In questo modo, Berlinguer sembrava guardare oltre l’appuntamento elettorale del giugno 1979, che era per molti aspetti scontato, e affilare le armi per una nuova fase di «guerra di posizione». In effetti, le elezioni segnarono una sconfitta dei comunisti e premiarono la strategia democristiana del logoramento. La forza di massa del Pci restava largamente integra, ma le motivazioni e le prospettive per tenerla insieme chiedevano una revisione. Berlinguer esaltò la peculiarità del comunismo italiano e la sua irriducibilità alla socialdemocrazia («le socialdemocrazie sono una cosa, noi un’altra e cosí dobbiamo restare»)64.
3. Il senso della crisi globale.
L’Italia rispecchiò fedelmente la «rivincita della geopolitica» che emerse in Occidente alla fine del decennio65. La guerra fredda stava iniziando a implodere come ordine globale, ma continuava a definire elementi della sovranità e spazi politici in Europa. Pur nel crescente carattere multilaterale della governance occidentale, la politica nazionale italiana forniva ampia evidenza di tale persistenza. La perdurante importanza del paese nelle strategie della guerra fredda, enfatizzata dagli euromissili, controbilanciava in apparenza la sua perdita di profilo internazionale e la sua esposizione al nuovo vangelo costituito da deregulation, disciplina monetaria e competizione, che assegnava nuovi significati alle interdipendenze occidentali66. I comunisti italiani fronteggiarono un simile scenario adattando i loro linguaggi alla «seconda guerra fredda» senza tornare sui propri passi nelle scelte internazionali e mantenendo stretto il nesso europeista come salvaguardia dalle logiche di blocco. Attorno a quel nesso ruotavano le principali coordinate della trasformazione culturale del comunismo italiano, comprese le visioni del Sud globale.
Il patto della «solidarietà nazionale» si era basato sulla solenne affermazione delle fedeltà europee e atlantiche, ma fu anche motivato dalle idee e dalle pratiche della cooperazione internazionale. La visione dei comunisti si articolò soprattutto attorno alla Convenzione di Lomé, entrata in vigore nell’aprile 1976. Essi speravano che il passaggio dal tema degli «aiuti allo sviluppo», risalente al decennio precedente, a quello della cooperazione economica e politica, con l’obiettivo di intervenire sulla divisione internazionale del lavoro, potesse creare una nuova prospettiva di interazione tra Comunità Europea, paesi socialisti e paesi del Terzo Mondo. La loro idea guida, espressa in particolare da Sandri nel gruppo parlamentare europeo, seguiva le interpretazioni piú radicali della convenzione: superare l’ispirazione regionalista e farne un modello globale, con il baricentro nel Mediterraneo e ramificazioni in tutto il Terzo Mondo e in America Latina. L’esponente comunista stabilí un dialogo al riguardo con il commissario europeo Cheysson67. Le priorità della politica nazionale misero in secondo piano simili questioni. Fu però proprio in questo contesto che affiorò piú chiaramente un cambiamento di idiomi rilevante per le sue implicazioni di cultura politica. Nell’aprile 1978, Sandri difendeva Lomé giudicando la convenzione come «la realizzazione qualitativamente piú eminente della Cee […] la piú avanzata sul terreno riformista». Gli sembrava semmai insoddisfacente che, salvo affermazioni generiche, essa tacesse sulla «questione dei diritti dell’uomo». Egli riteneva che non si dovesse transigere sulla tendenza di molti paesi africani a difendere «i propri infami regimi» con l’argomento dell’interferenza occidentale. Il tema dei diritti umani non era nuovo, ma assumeva un peso diverso perché non risparmiava i regimi africani filosovietici e si legava a una importante correzione dell’ottica adottata nella politica internazionale. Sandri pensava infatti che il richiamo ai principî delle Nazioni Unite fosse un antidoto all’invadenza degli interessi «della superpotenza capitalistica o della superpotenza socialista»68. Indicò l’esigenza di una politica comunitaria verso l’Africa australe, che rischiava di essere soltanto teatro dello scontro tra le superpotenze. Egli metteva cosí sullo stesso piano la condotta di Stati Uniti e Unione Sovietica in Africa, senza assolvere la seconda con argomenti internazionalisti, e impiegava il linguaggio dei diritti umani in opposizione alla politica di potenza69. L’osmosi tra la condanna della politica di potenza e l’adozione di una prospettiva etica, prima che classista, doveva accentuarsi molto nel discorso dei comunisti italiani.
A loro modo di vedere, la nuova politica comunitaria verso il Terzo Mondo forniva un terreno concreto ai tentativi di aggiornare l’agenda comunista. Anche su questo piano essi sperimentarono però soprattutto difficoltà e disillusioni. Nel mondo socialista, le tensioni tra cubani e iugoslavi circa la vocazione del non allineamento e la sua distanza paritaria o meno dai due blocchi si combinavano con l’indifferenza sovietica al tema del «nuovo ordine economico internazionale», che sembrava accentuarsi quanto piú Mosca era impelagata nella guerra fredda africana. La latitanza di un discorso comunista sulla questione era tanto piú problematica in quanto l’Internazionale socialista, sotto la guida di Brandt e di Senghor, stava lanciando un’iniziativa in Africa che si proponeva di superare il tradizionale eurocentrismo. Secondo gli iugoslavi, tale iniziativa prometteva di entrare in seria competizione anche con i non allineati, oltre che con le forze filosovietiche70. In sostanza, alla fine del decennio rischiava di indebolirsi quella che era stata storicamente una carta strategica dei comunisti europei nei confronti delle socialdemocrazie, lo sguardo e l’incontro con il mondo extraeuropeo.
I comunisti italiani non riposero significative aspettative nell’intervento cubano e sovietico in Africa. Essi avevano sollecitato un maggior dinamismo dei sovietici nel Sud globale, senza mettere in conto lo slittamento sempre piú evidente di Mosca dalle alleanze con il nazionalismo antimperialista ai movimenti e ai regimi caratterizzati da una dichiarata fedeltà ideologica71. L’appoggio sovietico al regime marxista-leninista di Hailé Mènghistu in Etiopia nella guerra contro la Somalia, scoppiata nell’estate 1977, creava seri dilemmi. Da alcuni anni i comunisti italiani vedevano il regime di Moḥammed Siad Barre in Somalia come la realizzazione di una «via africana» al socialismo e coltivavano rapporti con il movimento di liberazione in Eritrea, entrato in rotta di collisione con il potere rivoluzionario di Addis Abeba. Essi tennero le dovute distanze dal regime repressivo di Mènghistu ed erano scettici sull’idea, coltivata da Castro, che la rivoluzione in Etiopia avrebbe inferto un colpo fatale all’influenza occidentale nel continente. Il Pci si propose come mediatore nel conflitto, facendo leva sul fatto che il suo ruolo era accettato e riconosciuto dagli attori locali, come mostrano gli incontri di Pajetta con Mènghistu, con Barre e con i rappresentanti eritrei tra il 1977 e il 1978. Si tentò anche di coordinare l’azione del partito con il ministro degli Esteri Arnaldo Forlani a salvaguardia dell’interesse italiano in Etiopia72. In questo quadro, il Pci interloquí con Mosca, proponendo l’apertura a Roma di un negoziato tra Etiopia e Somalia e sottolineando di essere «in rapporto con tutti gli interlocutori»73. Fallita la proposta di negoziato, Pajetta ingaggiò una polemica con i cubani, riportando l’opinione del gruppo dirigente italiano che il loro interventismo in Africa fosse dannoso per il non allineamento74. Piú tardi, Berlinguer incontrò Barre e ne riferí a Mosca nel suo viaggio dell’ottobre 1978, insistendo sull’orientamento socialista dei somali e sull’importanza di «recuperarli», ma si scontrò con lo schieramento sovietico in favore di Mènghistu. Brežnev respinse le obiezioni di Berlinguer circa l’effetto negativo sulla distensione della politica sovietica in Africa75. L’attività diplomatica del Pci nello scenario del Corno d’Africa ebbe cosí prevalentemente il risultato di approfondire le fratture del comunismo internazionale prodotte dall’eurocomunismo. Fu quella vicenda a generare seri interrogativi sulla politica di potenza sovietica nel Sud globale, che ora entravano a far parte del bagaglio del comunismo riformatore.
La crisi politica in Italia si combinò con una catena di cambiamenti che alteravano radicalmente il contesto internazionale percepito dai comunisti, ma non soltanto da loro, alla metà del decennio. La congiuntura che aveva segnato l’apice della distensione in Europa, il trionfo dei comunisti in Indocina e il «malessere» occidentale si dissolse come neve al sole. Il mutamento piú visibile era l’eclisse della distensione bipolare, emersa attorno alla questione dei diritti umani e all’espansionismo sovietico in Africa. Alla fine del 1978, il viaggio di Deng Xiaoping negli Stati Uniti concretizzò l’incubo sovietico di un’alleanza che modificava la scacchiera della guerra fredda a sfavore di Mosca. Subito dopo, il Vietnam invase la Cambogia dopo vari scontri di confine, provocando la reazione militare cinese. Parallelamente, la rivoluzione islamica in Iran apriva uno scenario estraneo alle categorie e alle declinazioni del progressismo terzomondista, anche se per qualche tempo esse continuarono a essere coltivate. Come se non bastasse, la rivoluzione iraniana generò un secondo shock petrolifero destinato ad avere conseguenze inflazionistiche e recessive che provocarono politiche monetarie restrittive in Occidente. In Europa, la Nato aprí una contesa attorno ai missili di teatro sovietici che era nell’aria da tempo e si annunciava particolarmente dura e pericolosa, mettendo una pietra sopra al tempo delle intese bipolari. Nel marzo 1979, Tatò scrisse a Berlinguer che nel «passaggio d’epoca» in atto la distensione non era piú una condizione sufficiente, soprattutto perché concepita dai sovietici come una «garanzia statica», una «egemonia a due» degli affari mondiali. Secondo Tatò, l’Unione Sovietica aveva reagito con realismo alla «linea unipolare» americana, prima seguita in forma «metternichianamente conservatrice» da Kissinger, poi «aggressiva e avventurista» da Brzezinski. Tale reazione era stata comprensibile ma inadeguata. L’appunto considerava i focolai di guerra sul piano globale soprattutto come la conseguenza di un deficit di governo delle due superpotenze, ripartendo però le responsabilità in modo asimmetrico, e profilava esiti catastrofici senza un ruolo diverso dell’Europa occidentale76.
Nel suo discorso pubblico, Berlinguer impiegò la gerarchia di senso incentrata sulla crisi del capitalismo e sul lato oscuro della «civiltà dei consumi», ma sviluppò il registro della «crisi globale». Egli vedeva l’ambivalenza delle interdipendenze mondiali, fonte di inquietudini di massa non meno che di progresso economico e scientifico, teatro di guerre che evidenziavano una piú generale «crisi degli ordinamenti». I suoi toni si fecero accorati a proposito delle guerre tra i paesi comunisti in Indocina. Egli rivolse addirittura un appello a Pechino e Hanoi parafrasando Gramsci e presentando i comunisti italiani come «espressione di un popolo che dalla propria storia ha tratto una profonda ispirazione internazionalista». Rilanciò l’idea di un «nuovo internazionalismo» in grado di farsi carico dei problemi della cooperazione e dello sviluppo, perciò non limitato al movimento comunista. La scelta europeista, precisò, era parte essenziale di tale prospettiva, perché l’integrazione dell’Europa costituiva un fattore del progetto di un nuovo ordine mondiale, oltre che «una condizione per l’indipendenza reale dei paesi che fanno parte della Comunità»77.
A questo punto, l’europeismo costituiva visibilmente l’elemento centrale nella visione internazionale dei comunisti italiani. Il voto europeo del giugno 1979 doveva costituirne il momento simbolico, con l’elezione di Berlinguer insieme ad Altiero Spinelli, la figura chiave dell’europeismo, candidato come indipendente nelle liste comuniste. Per Berlinguer l’Europa non rappresentava una «scelta di civiltà», ma gli anni della «solidarietà nazionale» avevano contribuito all’adozione di un solido paradigma europeista. La convergenza sull’integrazione europea, sia pure con sensibilità molto diverse, rappresentava il punto di maggiore saldatura della comunità nazionale. Nello stesso tempo, il fatto di aver subito il “vincolo esterno” atlantista costituiva una lezione che spingeva i comunisti a immaginare la futura Comunità Europea come rete di sicurezza e di garanzia della sovranità. Il punto principale era che l’Europa diveniva un orizzonte di senso per le loro idee universaliste dinanzi al declino dell’internazionalismo comunista.
Tuttavia, il compimento del passaggio dal realistico riconoscimento della Comunità sul piano geopolitico e dell’interesse nazionale all’identificazione nell’integrazione come teatro principale di progettualità politica e ideale presentava vari problemi. La crisi degli euromissili appiattiva la distinzione tra europeismo e atlantismo, che per i comunisti restava invece strategica. Il giudizio circa le maggiori o minori responsabilità dell’Unione Sovietica nel tramonto della distensione costituiva un elemento di divisione con le altre forze della sinistra europea. Per loro, l’Unione Sovietica non era piú il centro di gravità del socialismo nel mondo ma la sua funzione di contrappeso all’imperialismo restava un dato essenziale. Nel gruppo dirigente affiorò la tendenza a difendere la distensione senza troppi distinguo tra la sua interpretazione come cambiamento o come status quo. Dopo tutto, la distensione dinamica risultava esaurita o smentita proprio nell’esito della «solidarietà nazionale». Berlinguer invitò a evitare «scelte di campo», se si voleva parlare «agli italiani e alle altre forze europee occidentali»78. Tra l’altro, annunciò al Congresso l’adozione di un’ottica analoga al rapporto Brandt sull’asse Nord-Sud del mondo. Ma stentava ancora a vedere il mondo socialista come parte della «crisi globale». Egli si incontrò con i leader sovietici nell’agosto-settembre 1979, nell’intento di sondare le loro valutazioni di politica internazionale. Compiaciuti per il passaggio del Pci all’opposizione, ma anche per l’eclisse dell’alleanza eurocomunista, Brežnev e Suslov confidarono che la mobilitazione pacifista e l’opera diplomatica svolta dagli italiani in Europa potesse produrre un riavvicinamento79. Il gruppo dirigente si divise circa l’opportunità di auspicare un negoziato sugli euromissili, accostandosi alle posizioni della Spd, o schierarsi di fatto con Mosca. Bufalini e Napolitano furono i piú fermi nel respingere la seconda opzione, avanzata soprattutto da Pecchioli e Pajetta, che avrebbe anche significato liquidare la dichiarazione comune con le altre forze politiche della Repubblica risalente al 1977. Berlinguer dichiarò alla direzione che il Pci non poteva farsi «portavoce» della politica sovietica e criticò le posizioni di Mosca come poco credibili e persino «sospette» in varie parti del mondo80. La sua scelta impedí una deriva che avrebbe rischiato di annullare parte essenziale delle peculiarità del comunismo italiano, ma non poté evitare l’isolamento interno e internazionale. L’Italia approvò la decisione Nato volta all’installazione dei missili occidentali, sia pure lasciando un margine di manovra per il futuro. Il voto contrario distinse il Pci dalle scelte della Spd malgrado i contatti diplomatici tra i due partiti. I comunisti francesi e polacchi lanciarono una mobilitazione antiamericana orchestrata da Mosca senza neppure consultare gli italiani.
L’invasione sovietica in Afghanistan, alla fine di dicembre 1979, ebbe un impatto molto piú forte degli euromissili per i comunisti italiani, i quali avevano inutilmente sperato che il Politbjuro non si sarebbe risolto a prendere una decisione cosí fatale per difendere il governo «marxista-leninista» di Kabul, lacerato da lotte intestine tra fazioni e sotto il tiro della guerriglia islamica ispirata da Teheran. La loro dura condanna fu però immediata e inconciliabile con la reazione degli altri comunisti europei, compresi i francesi, che si strinsero attorno a Mosca in una parodia dell’internazionalismo d’altri tempi. Cosí l’Afghanistan pose una pietra tombale sull’alleanza eurocomunista. In realtà, tale esperienza si era già largamente conclusa e il suo spazio temporale aveva coinciso con quello della «solidarietà nazionale» italiana. La reazione disciplinante dei sovietici aveva svolto un ruolo, riuscendo nell’obiettivo di richiamare all’ordine i francesi ma non gli italiani. Tuttavia, numerosi motivi di dissidio erano presenti sin dall’inizio e si erano accumulati invece di stemperarsi. Il problema non era mai stato confinato alle diversità nazionali. Gli eurocomunisti erano divisi su questioni centrali quali il ruolo dell’Europa come soggetto nella crisi del bipolarismo e il modo di tematizzare l’asse tra Nord e Sud del mondo, che soltanto gli italiani connettevano tra loro criticando la politica di potenza di Mosca. La letteratura ha spesso assunto l’eurocomunismo come un fenomeno unitario e coerente, fino agli studi piú recenti, e cosí ha mancato di mettere a fuoco la sua basilare disunione81. Il punto è che non tutti gli eurocomunisti erano anche comunisti riformatori. Soltanto il gruppo dirigente italiano coltivava la prospettiva di una liquidazione del vecchio internazionalismo e di una trasformazione della cultura politica, in grado di acquisire nuovi linguaggi e paradigmi nel rapporto con le forze di movimento emerse globalmente fuori dagli schemi binari della guerra fredda.
Il gruppo dirigente del Pci ribadí le proprie posizioni malgrado l’isolamento, anzi facendone un motivo di orgoglio. Esso respinse la logica dei blocchi e liquidò apertamente il principio di fedeltà all’Unione Sovietica nella politica mondiale. Bufalini confidò a Calamandrei di ritenere che l’invasione dell’Afghanistan fosse «il punto d’arrivo inevitabile di un binario sbagliato»82. L’opposizione di Amendola, che come i sovietici riteneva prossima una nuova guerra mondiale e giustificava la loro scelta in questa luce, non ebbe un impatto rilevante. Berlinguer respinse la «scelta di campo» che ne sarebbe seguita come una regressione politica e culturale83. Poi condannò pubblicamente l’invasione in un discorso al Parlamento europeo, una scelta che anche simbolicamente separava i destini del comunismo italiano dal resto del movimento comunista84. La visione globale dei comunisti italiani si era costruita nel tempo tramite le combinazioni reali e immaginate tra mondo socialista, movimento operaio occidentale e mondo postcoloniale, secondo modalità e contingenze variabili. L’invasione dell’Afghanistan fece crollare questa architettura progettuale, già da tempo logora e incerta nei suoi assi portanti. Il mito della «potenza pacifica» e la sua missione rivendicata nel Terzo Mondo subivano un colpo fatale. L’Unione Sovietica si collocava ora in prima linea nella guerra fredda globale. In un incontro con Ingrao, l’alto funzionario del Dipartimento internazionale del Pcus, Vadim Zagladin, presentò la condotta di Mosca come un aiuto a rivoluzioni autonome destinate altrimenti a fallire, che dall’epoca di Cuba era andata avanti coerentemente, ad esempio nello Yemen o in Etiopia, fino appunto all’Afghanistan. La sua previsione era che questa strategia si sarebbe accentuata in futuro, un pensiero che altri internazionalisti sovietici come Černjaev e Karen Brutens non condividevano ma che rifletteva l’opinione prevalente nel Politbjuro85. I sovietici identificavano la guerra fredda con lo sviluppo delle rivoluzioni antimperialiste, o presunte tali. Per i comunisti italiani, invece, un simile modo di pensare stabiliva una linea di divisione tra gli Stati socialisti e i paesi non allineati e perciò poteva solo fare danni. Il socialismo nel mondo postcoloniale appariva una costellazione di regimi filosovietici autoritari e militarizzati, mentre la galassia del Terzo Mondo esplodeva in traiettorie multiple che l’immaginario antimperialistico non era piú in grado di unificare.
Questo punto di divergenza allargava di molto lo spettro delle differenze tra i comunisti italiani e gli altri comunisti nel mondo. L’esperienza dell’eurocomunismo era finita con un duro ridimensionamento delle ambizioni di accrescere il ruolo delle forze rivoluzionarie nell’Occidente capitalistico. Alla fine del decennio, il panorama politico europeo registrava persino un indebolimento delle sinistre socialiste a vantaggio delle forze conservatrici e neoliberali. Si annunciava un cambiamento nello spirito dei tempi molto sfavorevole a tutti i progetti diversamente legati alla storia del socialismo. I comunisti italiani coltivarono la loro «terza via» e il loro europeismo in attesa di tempi migliori, combinando le due nozioni con un approccio deideologizzato e cooperativo al tema del rapporto tra Nord e Sud del mondo. Essi non erano meno orientati di prima dall’idea di influenzare le élite politiche sovietiche e dell’Est europeo, anche se non potevano vantare alcun risultato autentico al riguardo. Le modalità di esercizio di una simile influenza però si modificarono. Il gruppo dirigente decise di non partecipare alla conferenza comunista convocata a Parigi per sostenere l’Unione Sovietica. Per la prima volta il Pci non figurava tra i partecipanti di una conferenza di partiti comunisti europei. Berlinguer puntò sull’autosufficienza e sul «rilievo internazionale», come egli stesso lo definiva, del comunismo italiano dinanzi al nesso di problemi rappresentato dalla «seconda guerra fredda», dall’Afghanistan e dal futuro del non allineamento86.
La diplomazia del Pci si rivolse verso i comunisti iugoslavi e le socialdemocrazie europee. Gli iugoslavi dichiararono di sentirsi in prima linea insieme agli italiani nel resistere all’offensiva ideologica sovietica, oltre a svolgere il ruolo di un contrappeso a Cuba, come si era visto alla Conferenza dei paesi non allineati svoltasi all’Avana nell’estate 197987. Nel marzo 1980, Berlinguer si incontrò per la prima volta ufficialmente sia con Brandt sia con Mitterrand a Strasburgo, marcando un cambiamento di passo dopo un lungo periodo di relazioni informali, sottoposte ai vincoli delle politiche nazionali e condizionate da reciproche riserve. La sede europea diveniva cosí la chiave istituzionale per stabilire un nuovo rapporto, malgrado l’insistenza dei comunisti italiani sulla propria differenza dalle socialdemocrazie88.
Il dato piú nuovo, e per certi aspetti dirompente, nella politica internazionale dei comunisti italiani fu però la ripresa delle relazioni con il Partito comunista cinese. Dopo un lavoro preparatorio iniziato all’inizio del 1979 grazie alla mediazione iugoslava, Berlinguer, Bufalini, Pajetta e Antonio Rubbi, subentrato a Segre quale responsabile della Sezione esteri, si recarono in visita a Pechino nell’aprile 1980. L’evento presentava numerose implicazioni. Nella congiuntura della guerra in Afghanistan, era un fatto inaudito per i sovietici, che giustificavano tra l’altro l’invasione con la necessità di mettere fine all’ingerenza «controrivoluzionaria» degli Stati Uniti e della Cina nel paese. In un’ottica piú larga, gli incontri con Deng Xiaoping, Hua Guofeng e Hu Yaobang simboleggiavano la fine di una frattura nella storia comunista, che aveva perduto di senso perché il movimento comunista non costituiva piú un fattore imprescindibile. Sotto questo profilo, l’evento segnalava piuttosto l’incontro tra soggetti della tradizione comunista che in Europa e in Asia avevano conosciuto sensibili metamorfosi e fornivano le loro risposte al tramonto del mondo bipolare. Tale simbolismo metteva persino in secondo piano l’ovvia asimmetria tra il gigante rappresentato dal partito-Stato cinese e un partito politico non di governo come quello italiano. I leader cinesi riconobbero il profilo internazionale del comunismo italiano. Nelle sue memorie, Rubbi ricorda i toni particolarmente aperti usati da Deng nel suo colloquio con Berlinguer89. Quest’ultimo sapeva di incontrare la loro sensibilità quando dichiarò che il «vecchio internazionalismo» era finito per sempre, anche se rivendicò l’eredità del «memoriale» di Jalta. La constatazione delle rispettive diversità era un dato scontato sin dall’inizio e non impediva l’esercizio della diplomazia che, in modi diversi, costituiva uno strumento nelle corde nazionali di entrambe le parti. Berlinguer distribuí equamente le responsabilità di Mosca e di Washington nella «crisi globale» e sottolineò il necessario ruolo della Comunità Europea e dei non allineati ai fini di evitare una catastrofe. Il punto ovvio di dissidio era costituito dal giudizio dei leader cinesi sull’«egemonismo» sovietico come pericolo principale. Essi continuavano a ritenere che la guerra fosse inevitabile, seppure a lungo termine, rivelando cosí di non aver messo in soffitta la dottrina di Stalin e di Mao90. Tornato a Roma, Berlinguer presentò il rapporto stabilito con i comunisti cinesi in una sperimentata chiave ecumenica, che però aveva ora il senso di costruire reti di deterrenza dinanzi al precipitare delle relazioni tra le superpotenze. Egli riconobbe che Pechino non aveva tutti i torti a percepire un accerchiamento sovietico, dall’Afghanistan al Vietnam91.
La visione di Berlinguer si sottraeva alle letture di carattere apocalittico presenti tra i pacifisti all’epoca. Egli vedeva bene come la crisi della distensione nascondesse un fenomeno piú generale, la graduale implosione dell’ordine bipolare, mentre l’agenda delle superpotenze restava incentrata sulla guerra fredda. La lucidità di una simile visione si appannava al momento di definire il posto dell’Unione Sovietica nella «crisi globale» e, in connessione con questo nodo, di raffrontare l’immobilismo del socialismo di tipo sovietico con le trasformazioni in atto nelle società occidentali. Le aspettative riposte nelle potenzialità etiche del socialismo di Stato non sembravano tenere nel dovuto conto i segnali di crisi nell’Est europeo. Ma soprattutto, le visioni della modernità implicite in tali aspettative rischiavano di suonare obsolete e inefficaci come risposte alle spinte individualistiche e alla trasformazione postindustriale in atto nel mondo occidentale, che ribaltava le percezioni risalenti allo shock petrolifero. La platea disposta ad accreditare il comunismo e la sua eredità rivoluzionaria quale vettore di processi globali si stava visibilmente contraendo non soltanto in Occidente ma anche altrove. I comunisti italiani erano consapevoli del problema, ma ritenevano che fosse legato a una contingenza reversibile e non presentasse caratteri piú profondi e duraturi.
4. Il comunismo entra nella «crisi globale».
Gli scioperi di Danzica dell’estate 1980 spostarono il fuoco della «crisi globale» in Europa. Le loro conseguenze imposero seri interrogativi sulla portata dei problemi aperti nel «socialismo reale» e nel blocco sovietico, dal momento che la protesta operaia generò un sindacato indipendente, Solidarność, dopo un decennio di periodiche ribellioni sociali contro il regime. L’evidenza di un’opposizione “dal basso” sconsigliò sin dai primi giudizi di sperare in una riforma “dall’alto” sul modello della «primavera di Praga». Berlinguer invitò il gruppo dirigente a non «mettere il timbro» dell’eurocomunismo sul nuovo leader del partito polacco che sostituí Edward Gierek, Stanisław Kania, consapevole che le strutture del potere rischiavano la dissoluzione e paventando uno scenario cruento analogo all’Ungheria del 195692. Il Pci si adoperò per un compromesso che prevedesse il riconoscimento del sindacato libero, respingendo il termine di «controrivoluzione» subito adottato da Mosca e dagli altri comunisti europei. Tale iniziativa diplomatica non fu irrilevante soprattutto perché si svolse in sintonia con la Chiesa cattolica. Non era la prima volta che si stabiliva un parallelismo e un contatto tra i comunisti italiani e il Vaticano, attivato da tempo in vari scenari del Terzo Mondo. Le condizioni per sviluppare relazioni nella chiave della Ostpolitik sembravano compromesse dall’iniziativa di Giovanni Paolo II, che aveva rilanciato il ruolo politico del Vaticano sotto il segno dell’anticomunismo, compiendo un viaggio trionfale in Polonia nel 1979. Tuttavia ciò non impedí un’interazione fra le due diplomazie. Anzi i rispettivi legami con l’establishment polacco e con il movimento di Solidarność configurarono un ruolo internazionale di primo piano. La mediazione diplomatica intessuta tra il Pci e il Vaticano, soprattutto per opera di Bufalini e Pajetta e del cardinale Casaroli, costituí forse il piú importante cuscinetto per attutire l’impatto della crisi polacca nel cuore dell’Europa. I comunisti italiani erano refrattari alle venature nazionaliste del cattolicesimo in Polonia, ma potevano condividere tratti dell’ispirazione universalista di papa Wojtyła e parlavano linguaggi pacifisti non molto dissimili, duramente avversati da Mosca93. In un certo senso, questa dinamica compensò la loro traiettoria divergente dalla politica estera atlantista del nuovo centro-sinistra, creata dalla questione degli euromissili e aggravata dalla guerra tra Iraq e Iran, scoppiata nell’agosto 1980 e giudicata dal Pci un tentativo degli Stati Uniti di soffocare la rivoluzione iraniana. La crisi polacca si configurò come un momento di riconoscimento del ruolo di ponte svolto dal Pci tra le due Europe.
I comunisti italiani svolsero un simile ruolo opponendosi caparbiamente alla ripetizione di un intervento armato di Mosca sul modello del 1956 e del 1968. A lungo essi sperarono di aprire una breccia tra gli esponenti sovietici ed esteuropei piú disposti a eventuali compromessi e a riconoscere la realtà del movimento popolare polacco. Era questo il caso di Černjaev, divenuto vicecapo del Dipartimento internazionale del Pcus. Questi riteneva che si dovesse evitare di «internazionalizzare» la questione polacca e riconoscere il «malcontento di massa» che aveva generato la crisi, ma la sua voce non rifletteva gli orientamenti del Politbjuro94. Pesava l’inconsistenza delle forze riformatrici nell’establishment comunista polacco, che pure restavano il principale riferimento dei comunisti italiani e contribuivano a formare la loro lettura della crisi95. In un duro scontro verbale alla fine di dicembre, Zagladin confermò a Berlinguer che i margini per evitare qualunque tipo di opzione repressiva, dall’esterno o all’interno del paese, erano quasi inesistenti. L’esponente moscovita ricordò che erano in gioco gli interessi dello Stato sovietico, insinuando che un partito come il Pci non ne tenesse conto nel modo adeguato96. La crisi polacca metteva cosí a dura prova le speranze dei comunisti riformatori. Il mancato incontro dei dirigenti comunisti con il leader di Solidarność, Lech Wałęsa, durante il suo viaggio in Italia nel gennaio 1981, fu una spia della difficoltà di conciliare le relazioni con gli establishment e l’apertura a una forza che si configurava non piú come una forma di dissenso, ma come un’opposizione e un contropotere. Furono i dirigenti della Cgil a prendere una posizione di apertura, che vedeva nel sindacato indipendente polacco un soggetto delle riforme necessarie nei paesi dell’Europa orientale e sollecitava a riconoscere il carattere politico, e non soltanto economico, della crisi dei sistemi socialisti97.
La crisi in Polonia coincise con la congiuntura politica piú sfavorevole verificatasi in Italia e in Occidente da molti anni per il Pci. Il rilancio della guerra fredda e dell’atlantismo annunciato dall’amministrazione Reagan, insieme alla sua filosofia di politica economica neoliberale, interagí con un salto di qualità conflittuale nella politica interna, generato dalla dichiarata esclusione del Pci dalla sfera di governo, dalla questione degli euromissili e dallo scontro all’arma bianca con Craxi e con la sua strategia mitterrandiana per conquistare l’egemonia nella sinistra. Ciascuno di questi fattori era chiaramente destinato a durare a lungo. Anche per questo, la vittoria di Mitterrand nelle elezioni presidenziali francesi del maggio 1981 non poteva costituire un fattore di sollievo, anzi mostrava la minorità dei comunisti francesi e l’allineamento alle scelte della Nato. Il nesso tra politica internazionale e nazionale era profondamente cambiato di segno in un volgere di tempo relativamente breve. Lo scenario che aveva combinato distensione internazionale, europeismo e spazi progettuali progressisti si invertiva in uno dominato da guerra fredda, ortodossia atlantista e nuove progettualità neoliberali o neoconservatrici, mentre persisteva la divisione bipolare del sistema politico nazionale.
Berlinguer alzò un fuoco di sbarramento contro Craxi, che vedeva come la figura chiave della «seconda guerra fredda» in Italia. Ai suoi occhi, l’aggravante era costituita dall’illusione che le socialdemocrazie potessero giocare un ruolo rilevante in Europa, come era accaduto all’epoca della guerra fredda classica, mentre invece il clima attuale minacciava involuzioni «reazionarie» e metteva in pericolo persino la democrazia in Italia. Riemergeva cosí la ricorrente apprensione del rischio democratico in Italia, che aveva caratterizzato a suo tempo la proposta del «compromesso storico» in un contesto nazionale e internazionale completamente diverso. Ora essa poteva apparire come una sindrome piú difficile da giustificare. Alcuni dirigenti videro nella scelta di Berlinguer un arroccamento senza un chiaro sbocco politico. In sede riservata, Iotti e Napolitano denunciarono il rischio di un isolamento del partito già all’inizio del 198198. Berlinguer radicalizzò ancora di piú la propria posizione spostando il fuoco del suo discorso dal conflitto politico alla critica morale del sistema dei partiti al potere. La sua celebre denuncia della «questione morale» in Italia, compiuta in una intervista a Eugenio Scalfari nel luglio 1981, toccava un problema grave e reale della vita nazionale che esisteva da tempo. Ma presentava anche il significato di un incentivo alla polarizzazione politica. Berlinguer impiegava un vocabolario nuovo per mettere l’indice su una permanenza, l’assedio reciproco tra i due blocchi politici della Repubblica. La «questione morale» riguardava i partiti di governo, mentre i comunisti potevano reclamare la propria «diversità», che non era piú un dato di classe ma un connotato etico. Napolitano criticò pubblicamente il segretario del partito per aver deragliato dall’insegnamento togliattiano del «fare politica». Ne seguí una polemica feroce che mise in luce spaccature del gruppo dirigente non piú destinate a rientrare99.
La tesi della «questione morale» come «questione nazionale» correva il rischio di considerare il tema della nazione come esclusivo e separato dal nesso internazionale. La «diversità» rivendicata da Berlinguer presentava infatti un risvolto internazionale essenzialmente negativo. Il progetto della «terza via» implicava un’identità unica del comunismo italiano, irriducibile alle socialdemocrazie, che il corpo profondo del partito comprendeva meglio del distacco dal movimento comunista. La polemica contro la «degenerazione» del sistema dei partiti in Italia si legava cosí a una linea di demarcazione netta verso le socialdemocrazie in Europa, tracciata proprio nel momento del massimo avvicinamento possibile alle componenti «di sinistra» della socialdemocrazia tedesca. Tatò scrisse per Berlinguer una nota che sottolineava la «sintesi innovatrice» distintiva del Pci quale «principale forza di cambiamento e di innovazione in Italia e in Occidente»100. I rischi di una simile visione autoreferenziale erano sensibili. Essa poteva incoraggiare l’idea di un “eccezionalismo” italiano, innervato dalla presenza di una forza che si rappresentava all’avanguardia rispetto sia al mondo comunista sia a quello socialdemocratico, oltre che dialogante con il mondo cattolico. Un rischio che Togliatti aveva a suo tempo stigmatizzato, difendendo il legame con l’Unione Sovietica come un’àncora necessaria per evitarlo, e che Berlinguer aveva cercato di eludere in passato, tramite la combinazione fra «compromesso storico» ed eurocomunismo. Tracciare il confine verso le forze egemoni della sinistra occidentale significava anche accettare di restare ai margini delle scelte e delle alleanze nella Comunità, malgrado la convinta europeizzazione del Pci.
Berlinguer sviluppò analisi e visioni della «crisi globale» senza tornare sui suoi passi. Per la prima volta, riconobbe che esisteva una «crisi» del socialismo sovietico, una nozione ancora vaga che alludeva soprattutto alla perdita di universalità e di influenza ideale degli Stati e delle società di tipo sovietico e ai pericoli della loro ingovernabilità101. Una simile visione implicava enfasi ancora maggiore sulla riforma del socialismo sovietico, che non costituiva piú soltanto un’istanza di democrazia socialista ma si presentava come l’urgenza di arginare un’involuzione. L’idea della «riformabilità» dei sistemi di tipo sovietico rappresentava anche un modo per difendere la propria identità e contrastare la nozione di totalitarismo tornata pienamente alla ribalta nel discorso neoliberale in Occidente. La questione delle riforme in Unione Sovietica e nell’Europa orientale si era ormai fissata nell’agenda della «seconda guerra fredda» culturale e implicava da parte dei comunisti italiani qualcosa di simile a un atto di fede, piú che un’opzione realistica e fondata su analisi sviluppate nel tempo. Berlinguer era però consapevole che la propria difesa identitaria aveva senso se espressa come capacità di cambiare se stessi.
La Carta della pace e dello sviluppo, presentata nell’ottobre 1981 dopo due anni circa di elaborazione, tenendo come riferimento il Rapporto della Commissione Brandt all’Onu dell’anno precedente, ebbe questa funzione102. Ledda la legò all’analisi che costituiva il principale terreno di consenso nel gruppo dirigente, incentrata sul «declino della centralità delle grandi potenze», sull’emergere di nuovi soggetti statuali, nazionali e sociali, sulla persistenza delle ineguaglianze nei rapporti di scambio e nella divisione del lavoro internazionale, sul «divario tra “mondo reale” e “mondo legale”» negli affari globali. La critica della politica sovietica puntava l’indice sul dopo Helsinki, quando Mosca non aveva mostrato alcun orientamento verso la costruzione di un «nuovo assetto mondiale». Ledda però sviluppava la logica di questa tesi fino a presentare l’avvento stesso dell’amministrazione Reagan come una reazione alla politica di potenza dell’Unione Sovietica. Per la prima volta in una riunione pubblica destinata ad avere riflessi mediatici, un membro del gruppo dirigente del Pci equiparava di fatto le responsabilità sovietiche a quelle americane. Il suo accento sulla «cultura della pace» si rivolgeva alla sinistra europea. Ciò implicava un rilancio antiamericano che era però disallineato dal filosovietismo103. Il passo in avanti compiuto da Ledda non era condiviso da tutti. Bufalini, Pajetta e Cervetti manifestarono le loro riserve proprio sul giudizio paritario espresso circa le responsabilità sovietiche e americane. Cossutta difese un punto di vista integralmente filosovietico, presentandosi di fatto come il referente di Mosca. Tuttavia, Berlinguer si attenne all’idea che le scelte in termini di politica di potenza compiute da Mosca dopo Helsinki e il Vietnam fossero state decisive sul piano domestico e internazionale. In Direzione egli affermò in modo netto: «La politica dell’Urss è stata una delle cause della vittoria di Reagan, assieme ai fatti dell’Iran e la critica della situazione economica interna? Credo proprio di sí…»104.
Il colpo di Stato del generale Jaruzelski in Polonia, il 13 dicembre 1981, non colse impreparati i comunisti italiani, ma le loro risposte non furono preordinate. Berlinguer decise in solitudine di mettere il gruppo dirigente davanti al fatto compiuto, concedendo un’intervista televisiva nella quale pronunciò parole destinate a essere famose: dichiarò che la «capacità propulsiva» delle società dell’Est europeo era «venuta esaurendosi»105. Queste parole suscitarono sensazione nel partito e nell’opinione pubblica, anche se non rappresentavano molto piú di una constatazione piuttosto ovvia. Da tempo il «socialismo reale» emanava il messaggio di un’esperienza priva di progettualità e lontana dalle trasformazioni sociali radicali della storia comunista. Gli Stati socialisti si ammantavano di un’ortodossia ideologica meramente conservatrice, che presiedeva al patto sociale basato su stabilità autoritaria, welfare e timide forme di consumismo106. Il modello sociale ereditato dalla sovietizzazione non era mai stato attraente in Europa e aveva fatto pochi proseliti anche fuori d’Europa, dove aveva piuttosto fatto scuola il principio e la pratica del partito-Stato. Molta parte delle generazioni succedutesi nel «lungo Sessantotto» ne era consapevole. In una certa misura, ciò valeva per i dirigenti come per una significativa fetta dei militanti del Pci. La nascita di Solidarność aveva spazzato via le residue mitologie di un’identificazione tra classe operaia e Stati socialisti. Ma piú che comprovare la fine di uno slancio immaginato nel passato, la crisi in Polonia sollevava semmai interrogativi sulla tenuta del patto sociale autoritario e perciò sulla legittimazione dei regimi. La sortita di Berlinguer era soprattutto rivolta a consolidare la visione storicista della «terza via», che intendeva mettere alle spalle l’esperienza sovietica senza rinnegarla. Uno schema noto e reiterato proprio nei giorni precedenti negli appunti riservati di Tatò, con la consueta enfasi sull’eccezionalità dell’esperienza comunista italiana e la sua ambizione egemonica107. Eppure il fatto che Berlinguer preferisse agire senza consultarsi neppure con Tatò dice molto delle resistenze esistenziali e politiche radicate ai piú diversi livelli tra i comunisti italiani. Essi erano in gran parte all’oscuro delle tensioni piú gravi verificatesi negli anni precedenti con Mosca e restavano spesso legati a narrazioni acritiche dell’esperienza sovietica anche dopo il Sessantotto. Sebbene le parole di Berlinguer esprimessero significati già acquisiti nel suo discorso politico, ebbero l’effetto di far cadere un velo, amplificato dal veicolo mediatico televisivo.
Il colpo di Stato in Polonia fece emergere le contraddizioni del comunismo italiano in relazione alla crisi sovietica e ai suoi nessi con la «crisi globale». Piú che dividersi su linee precise, il gruppo dirigente si frammentò in accenti e rilievi molto diversi tra loro, che ruotavano però attorno a un interrogativo centrale, se cioè si fosse o meno in presenza di una soluzione di continuità nel rapporto tra il Pci e il mondo socialista. Alcuni, come Napolitano e Macaluso, retrodatarono alla repressione della «primavera di Praga» la perdita di un ruolo progressista credibile dei comunisti al potere e ritennero che la narrazione del ruolo pacifico dell’Unione Sovietica non fosse piú proponibile. Altri, come Bufalini e Pajetta, insistettero sul ruolo esercitato da Mosca come freno all’imperialismo e sul compito di aprire una via d’uscita per tutti, compresi i sovietici. Berlinguer si sottrasse a una scelta netta tra le due alternative. Egli mostrò un atteggiamento disincantato verso l’Unione Sovietica, che implicitamente suggeriva di non farsi troppe illusioni sugli scenari prossimi, ma sottolineò la prospettiva delle riforme. A suo giudizio, il fronte critico aperto sulla Polonia avrebbe potuto esaltare il ruolo sui generis dei comunisti italiani, «né mosche cocchiere, né grilli parlanti», ma «punto di collegamento» tra le diverse versioni del socialismo nel mondo. Rilanciò cosí l’aspetto universalista delle proprie visioni, aggirando le due diverse versioni di realismo politico rappresentate da Napolitano e Bufalini e relegando ai margini le posizioni giustificatorie di Cossutta108. Nel momento piú critico del mondo comunista, persino rispetto al precedente del Sessantotto, la leadership di Berlinguer si fondava piú che in passato su una missione internazionalista dei comunisti italiani, irriducibile a vecchie e nuove famiglie politiche, legata a un’idea «pacifista» della stessa tradizione nazionale e popolare, mirata a intessere relazioni transnazionali.
La pubblica dichiarazione del Pci compiuta il 30 dicembre 1981 eluse i nodi piú critici, quali la politica di potenza dell’Unione Sovietica e la necessità delle riforme, limitandosi a definire «datata» la concezione di un movimento comunista separato dalle forze progressiste109. Ciò nonostante, la reazione di Mosca portò le due parti sull’orlo della rottura. Per la prima volta si verificò uno scambio pubblico di accuse. In un acceso Comitato centrale, Berlinguer criticò pubblicamente i sovietici per non aver compreso la «profondità e natura della crisi polacca» ed esaltò la peculiarità del Pci quale «forza comunista radicata in Occidente»110. Nessuno intendeva però giungere a un punto di non ritorno. Berlinguer dichiarò alla direzione che la difesa del Pci poteva configurarsi anche come «un fatto nazionale e patriottico», ma escluse di poter concepire un polo contrapposto a Mosca, che avrebbe compromesso la strategia dell’influenza perseguita da tempo. La sua idea era che lo «strappo» potesse avere conseguenze soprattutto di politica interna, vale a dire la definitiva caduta della pregiudiziale anticomunista. Le altre forze politiche non avevano piú «alibi» per escludere i comunisti dal governo. Egli sapeva che lo scontro pubblico con i sovietici rafforzava la sua popolarità nel partito e che qualunque tentazione scissionista avrebbe dovuto farvi i conti. Ammoní con fermezza un gruppo dirigente per molti aspetti riluttante che il braccio di ferro con Mosca non era destinato a cessare e che le ragioni della linea eterodossa seguita dai comunisti italiani andavano riaffermate per mantenere l’unità della loro stessa compagine111.
I toni usati dai sovietici furono prossimi alla scomunica, specie per voce di Suslov. Tuttavia, Brežnev e Jurij Andropov, uomo forte del regime e capo del Kgb, ritennero che rompere i rapporti con l’unico partito comunista di massa in Occidente fosse una mossa autolesionista112. Dietro le quinte, Černjaev annotò nel proprio diario che i comunisti italiani vedevano come un loro compito internazionalista parlare della «crisi» all’Est per prevenire l’impreparazione a «qualcosa di peggio». Lo scenario del «disordine» nel blocco sovietico avrebbe anche potuto assumere proporzioni tali da far apparire la crisi in Polonia «come una scuola materna». La voce dei comunisti italiani aveva rivelato che «l’imperatore è nudo» e che «il movimento comunista internazionale non esiste piú»113. Queste note mostrano come la strategia d’influenza del comunismo italiano non fosse affatto priva di senso. La loro coscienza critica poteva suscitare motivi di riflessione e condivisione tra gli esponenti illuminati degli establishment comunisti. Tuttavia, l’effettiva influenza del Pci era aleatoria e difficile da valutare. La congiuntura della crisi polacca aggiungeva un elemento di distanza persino dalle componenti piú moderate nell’Europa centro-orientale, come gli ungheresi. Questi convergevano sulla narrazione sovietica e polacca che Jaruzelski avesse evitato una guerra civile che poteva investire l’Europa, mentre i comunisti italiani vedevano l’instaurazione della dittatura militare come un danno difficile da riparare per il socialismo nel mondo. Per alcuni anni essi avevano mancato di realizzare pienamente che la fine delle dittature di destra nell’Europa meridionale, avvenuta alla metà del decennio precedente, esponeva i regimi dell’Europa centro-orientale a una seria delegittimazione democratica, come le uniche dittature rimaste nel continente. Ora tale presa d’atto era inevitabile.
5. L’ultima battaglia di Berlinguer.
Berlinguer era ormai la bestia nera per gran parte dei dirigenti comunisti in Europa. I sovietici oscillarono tra le minacce di provocare una scissione e l’opportunità di mantenere rapporti nella speranza di ricondurre il Pci nei ranghi dell’ortodossia. Zagladin pronosticò una crescente difficoltà per la leadership di Berlinguer, che avrebbe potuto portare un cambiamento al vertice del Pci, e raccolse voci duramente critiche nei suoi confronti anche tra i comunisti occidentali, in particolare Marchais. Ma la solitudine nel mondo comunista non spaventava Berlinguer. Egli sapeva di avere «molti nemici» persino tra i dirigenti del suo partito, come avrebbe detto allo stesso Zagladin in un teso colloquio al momento dei funerali di Brežnev, nel novembre 1982114. La cosa però non sembrò davvero influenzare le scelte del leader italiano, che anzi si serví della reale o presunta minaccia di scissione per rafforzare la propria autorità nel partito e indebolire l’alternativa moderata rappresentata da Napolitano.
La dimensione di massa raggiunta dal movimento pacifista in Europa occidentale portò Berlinguer a rilanciare la propria vena visionaria. In uno dei momenti piú oscuri e tesi del dopoguerra nella politica internazionale, egli ripropose la prospettiva della fine della guerra fredda. A suo giudizio, il tema del «superamento dei blocchi», accantonato nel decennio precedente in nome del realismo, era divenuto «un obiettivo politico concreto». Il suo argomento era che i blocchi fossero ormai un «fattore di instabilità» invece che di governo del mondo115. Cosí parlò un linguaggio adeguato al nuovo pacifismo europeo, che era largamente dissociato dalle vecchie logiche binarie. Essere antiamericani e pacifisti non significava piú automaticamente essere filosovietici. In questo senso, i comunisti italiani potevano acquisire, tramite la partecipazione ai movimenti pacifisti di massa, rinnovate risorse di identità e connessioni in Europa che erano invece precluse ai francesi e agli altri116. Berlinguer intensificò gli scambi con i socialisti europei, in quel momento al governo in Germania occidentale e in Francia, avvalendosi del credito acquisito nella polemica con Mosca. Gli incontri con Mitterrand e con il segretario del partito socialista Lionel Jospin a Parigi nel marzo 1982, come era prevedibile, registrarono posizioni collimanti piú su alcuni punti, come il tema del rapporto tra Nord e Sud del mondo, e molto meno su altri, come gli euromissili e il giudizio sulle responsabilità di Mosca. Ciò era vero però anche nei rapporti tra diversi partiti socialisti, in particolare tra francesi e tedeschi. Per il Pci sembrava soprattutto importante inserirsi in una dialettica propria della sinistra europea. L’ostacolo principale era la visione italiana di una «terza via» simmetricamente distinta dal socialismo sovietico e dalla socialdemocrazia, che non poteva costituire un terreno d’incontro117. La caduta del governo Schmidt nell’ottobre 1982 e la sconfitta elettorale della Spd nel marzo 1983 agevolarono le chance del Pci di inserirsi in un confronto sempre piú teso tra i socialisti europei e configurare una sinistra rivolta a costruire un’Europa piú autonoma dalle superpotenze, ritenuta l’obiettivo di Brandt118. La relazione di Berlinguer al XVI Congresso, nel marzo 1983, fece propria una simile prospettiva. La sua analisi della «crisi globale» incluse i paesi socialisti e il loro ruolo inadeguato a liquidare le logiche distruttive del conflitto Est-Ovest e supportare una riforma dei rapporti diseguali tra Nord e Sud del mondo. Proprio la nozione della «crisi globale» lo portava, nello stesso tempo, a leggere il reaganismo sotto lenti molto tradizionali. Egli vi vedeva infatti il tentativo di coniugare liberismo e militarizzazione quale manifestazione dell’incapacità del capitalismo di risolvere le proprie «contraddizioni». Berlinguer assegnava ora al pacifismo un primato morale e politico sia rispetto all’antimperialismo, sia rispetto alla lotta di classe. Egli raffigurò il Pci come una forza della sinistra europea impegnata a cercare con le altre una via d’uscita dalla crisi del welfare state119.
Le relazioni con il Sud globale integravano la peculiare connotazione del comunismo italiano, che seguiva ispirazioni convergenti con i socialdemocratici ma se ne distingueva sotto il profilo delle reti e dei rapporti intessuti nel tempo. Sotto questo profilo, le iniziative politiche prese da Berlinguer in Cina, nel Mediterraneo, in Medio Oriente e in America Latina nei primi anni Ottanta costituirono una tela unitaria. Forse il contatto con la Cina era nato da considerazioni limitate all’ecumenismo comunista e alla ricucitura di vecchie fratture, ma i suoi risultati confluirono in una strategia piú larga. Vi era sottesa l’idea di una riforma della tradizionale visione antimperialista e un tentativo di rispondere alla frammentazione del Terzo Mondo con strumenti culturali diversi dal passato. Ciò configurava anche una risposta all’invasione sovietica dell’Afghanistan, mirante a costruire reti di relazioni accomunate dalla critica alla logica dei blocchi e dalla tematica delle relazioni Nord-Sud. Il Pci aggiungeva anzi un tassello in piú alla sua vocazione di mediatore transnazionale. I suoi interlocutori piú tradizionali, gli iugoslavi, davano infatti un giudizio negativo sul ruolo dell’Internazionale socialista nel Terzo Mondo, ritenendo che in Africa essa non rappresentasse forze progressiste e che la sua presenza alimentasse logiche di blocco in opposizione al «campo socialista»120. I comunisti italiani non condividevano un giudizio cosí drastico ma ritenevano di poter giocare un ruolo proprio al fine di modificare quelle logiche.
La Carta della pace e dello sviluppo presentava perciò varie implicazioni. Intendeva costituire un manifesto convergente ma anche in competizione con l’Internazionale socialista, uno sviluppo delle relazioni con i non allineati, un riferimento per le pratiche del Pci rispetto a quelle del «campo socialista». Nell’ottobre 1981, Berlinguer impiegò l’impianto della Carta nei suoi viaggi in America Latina e in Algeria, oltre a presentarla alla Conferenza dell’Onu a Cancún. Egli si recò in America Latina per la prima volta, ma il viaggio non aveva soltanto un significato di solidarietà rivolta alle rivoluzioni cubana e sandinista. Castro era divenuto la figura chiave del non allineamento dopo la morte di Tito nel maggio 1980 e rappresentava una radicalizzazione che negava i presupposti riformatori di un riequilibrio tra Nord e Sud del mondo e rifletteva la crescente frantumazione dei soggetti politici del Sud globale. Un cambiamento strategico che i comunisti italiani vedevano come un rischio letale e intendevano contenere. I colloqui tra Berlinguer e Castro confermarono tutti i limiti per un’autentica intesa politica, anzitutto sul nesso tra lotta antimperialista, democrazia e sviluppo. Il leader italiano espresse le proprie riserve sugli interventi cubani in Africa, sottolineando in particolare il crescente degrado politico e civile in Etiopia. Egli riteneva che l’instaurazione forzata di regimi «marxisti-leninisti» africani e nello Yemen non avesse un autentico significato progressista. Ma le sue parole non trovarono riscontro. Castro manifestò un generico interesse, ma anche il proprio scetticismo, per le tesi sul «nuovo ordine economico internazionale»121.
Anche l’incontro di Berlinguer con Daniel Ortega e il gruppo dirigente sandinista in Nicaragua, che in quel momento erano nel pieno delle campagne di modernizzazione forzata e anche dello scontro con gli Stati Uniti, ebbe soprattutto il risultato di evidenziare sensibilità distanti nelle rispettive culture politiche122. L’equiparazione tra le due superpotenze nella crisi dell’ordine bipolare e l’impianto «pacifista» della Carta costituiva una tesi divisiva nel mondo comunista e difficile da recepire proprio in America Latina. I comunisti italiani offrirono una sponda ai cubani e ai sandinisti al fine di evitare un abbraccio troppo stretto con Mosca e stabilire relazioni in Europa. Ma il viaggio di Berlinguer in America Latina fu una delusione, alla luce del sostanziale fallimento di Cancún, che segnò il definitivo inabissamento del «nuovo ordine economico internazionale»123. L’assenza dell’Unione Sovietica costituiva un segnale desolante di immobilità e un’occasione perduta, come Berlinguer constatò nel suo incontro con il presidente messicano José López Portillo124.
L’Algeria costituiva invece un interlocutore diverso e consonante con le visioni dei comunisti italiani, anche dopo la scomparsa di Boumedienne. Alla fine del 1980, i suoi successori proposero di dare vita a un patto triangolare di consultazione informale tra Pci, Fln algerino e Lega dei comunisti iugoslava. La loro idea era che il mondo socialista si fosse «messo da parte» sulle questioni del rapporto tra Nord e Sud, mentre l’approccio di Brandt non avrebbe previsto una «negoziazione globale» inclusiva della dimensione Sud-Sud. Questo doveva essere l’obiettivo da perseguire nel Mediterraneo125. Berlinguer presentò la Carta al leader algerino Chadli Bendjedid nell’ottobre 1981 e confermò la propria disponibilità a inaugurare un nuovo ciclo di conferenze del Mediterraneo, volto a coinvolgere tutte le forze politiche e i movimenti della regione senza le esclusioni del passato. In realtà, ancora una volta le divisioni tra i paesi della sponda Sud del Mediterraneo impedirono il pieno sviluppo dell’iniziativa126.
Le difficoltà di costruire un fronte transnazionale nel Mediterraneo non erano una novità e costituivano un ricorrente motivo di frustrazione. Era però crescente il senso del tramonto di un’epoca. La radicalizzazione di buona parte degli attori sulla sponda Sud, sempre meno inclini a mediazioni politiche sulle questioni dell’«imperialismo» nel Mediterraneo e in Medio Oriente e, insieme, la sensibile presenza nell’area di soggetti governativi, non governativi e comunitari europei, inducevano Remo Salati, esponente della Sezione esteri, a esprimere un certo pessimismo circa le possibilità di mantenere l’influenza dei comunisti italiani, percepiti come «socialdemocratici non al potere» e perciò meno «potenti» e interessanti127. Ciò rimandava alla difficoltà di un’interazione e compenetrazione tra il comunismo riformatore europeo e le tradizioni antimperialiste fuori d’Europa, emersa sin dall’epoca della «primavera di Praga». Era però anche evidente che il ruolo del Pci subiva la progressiva perdita del proprio accreditamento come ponte tra mondi diversi, dal momento che si manifestavano sulla scena svariati attori istituzionali o transnazionali, e insieme nuovi punti di congiunzione o di frattura. Le stesse aspettative riposte nel ruolo della Comunità Europea per una estensione della Convenzione di Lomé si erano largamente ridimensionate. Si faceva anzi stridente il contrasto tra le progettualità volte a un riequilibrio sull’asse Nord-Sud e le scelte concrete compiute dalla Comunità e dai governi nazionali128.
L’azione dei comunisti italiani in Medio Oriente dopo l’invasione israeliana in Libano, nel giugno 1982, mostrò tuttavia la loro sensibile influenza sugli orientamenti dell’Italia. Essi mirarono a integrare e condizionare la politica estera italiana, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento dell’Olp. Nello stesso tempo, si proponevano di influenzare le posizioni sovietiche attenuandone l’appoggio alle forze intransigenti nel mondo arabo, specie in Siria, Iraq e Libia, che con il loro antisionismo radicale ostacolavano qualsiasi negoziato per la causa palestinese. Il Pci respinse la presa di posizione sovietica sull’intervento israeliano in Libano, che Mosca bollava come imperialismo, e condivise la decisione del governo Spadolini di partecipare alla forza multinazionale che avrebbe dovuto consentire una tregua dell’assedio a Beirut e il ritiro dei palestinesi129. Bufalini si attivò con l’obiettivo di invitare ʿArafāt al Parlamento italiano e Rubbi lo incontrò ad Algeri per preparare i contenuti della visita. Nel settembre 1982 il leader palestinese incontrò a Roma il presidente Pertini e papa Wojtyła, sottolineando il profilo politico dell’organizzazione palestinese. Il suo incontro con Berlinguer fu limitato a pochi minuti perché la visita si interruppe a causa delle notizie del massacro di civili compiuto dai cristiani libanesi nei campi profughi di Sabra e Chatila. Ciò impedí a Berlinguer di sollecitare ʿArafāt nella direzione del riconoscimento di Israele e di un negoziato impostato sul tema della «pace in cambio di territori»130.
L’evento costituiva comunque un successo per la diplomazia comunista, che aveva messo alle strette il riluttante capo del governo. Simbolicamente, la visita di ʿArafāt rappresentò il punto di arrivo di una lunga costruzione di rapporti iniziata dopo la Guerra dei sei giorni, che ora la maggior parte delle forze politiche italiane riconosceva rilevanti sotto il profilo dell’interesse nazionale. Ma anche la sensibilità dei comunisti italiani aveva conosciuto da allora un serio cambiamento. Ne fece un compendio Reichlin, che invitò a evitare generiche e ambigue condanne del «sionismo» e a criticare l’azione del primo ministro israeliano Menahem Begin sul terreno esclusivamente politico131. La questione restava aperta, perché questo era uno dei terreni che registravano la possibile dissonanza tra il gruppo dirigente del partito e una parte significativa dei militanti legati alle mitologie antimperialiste.
Non era chiaro se l’azione svolta dal Pci sul teatro mediorientale aprisse ulteriori possibilità d’influenza. All’inizio del 1983, gli incontri con gli interlocutori tradizionali nel Mediterraneo, ad Algeri e a Belgrado, non furono incoraggianti al riguardo. In un colloquio con Natta, gli algerini smentirono la prospettiva di un’azione incisiva della Comunità Europea nel Mediterraneo, che giudicavano marginale nei giochi di potenza nella regione, persino a confronto della rinnovata presenza cinese132. Gli iugoslavi fecero notare a Pajetta che la posizione dell’Unione Sovietica nel Medio Oriente non mostrava segni di cambiamento133. Belgrado restava un punto di riferimento essenziale. In una nota per Berlinguer scritta nel febbraio 1983, Gerardo Chiaromonte riportò due aspetti condivisi: l’idea che la «crisi dello Stato sociale» in Occidente presentasse analogie e intrecci con la crisi dello statalismo di tipo sovietico; e la proposta di una «nuova Bretton Woods» e di un negoziato mondiale sulle relazioni finanziarie, che incontrava però la sordità di Mosca134. Nell’agosto 1983, Berlinguer visitò una seconda volta Pechino. Nel suo incontro con Hu Yaobang ricevette l’apprezzamento per le posizioni internazionali del Pci, che i cinesi ritenevano pragmatiche e non molto distanti dalla loro opposizione contro «l’espansionismo» delle grandi potenze. Il leader cinese non escluse una normalizzazione con Mosca ma la riteneva improbabile a breve termine. In altre parole, la ricerca di una sponda con Pechino, ai fini della deterrenza contro una escalation tra le superpotenze e di un rilancio dei temi della cooperazione internazionale, si rivelava praticabile soltanto in tempi lunghi. I cinesi erano anche insensibili alle sollecitazioni di includere nelle loro prospettive di modernizzazione il tema della democrazia politica, e anzi non condividevano la condanna del colpo di Stato in Polonia135. La febbrile attività di Berlinguer aveva portato al massimo grado possibile l’impegno globale di un soggetto politico come il Pci. I limiti delle sue effettive possibilità di costruire relazioni senza avere alle spalle né un governo né una famiglia europea di appartenenza, dopo la fine del progetto eurocomunista, erano stati toccati. Il prestigio internazionale del comunismo italiano era ancora riconosciuto ma le risorse politiche e simboliche a sua disposizione si rivelavano visibilmente decrescenti.
L’ultimo anno di Berlinguer fu segnato dalla ricerca di ricreare un canale diplomatico verso l’Est europeo. Succeduto a Brežnev, Andropov non era certo l’interlocutore piú adatto per sciogliere il gelo con il Pci, anche se avrebbe segretamente concordato con Cossutta l’inopportunità di operare per una scissione136. Berlinguer si propose di esplorare soluzioni realistiche sul problema degli euromissili, anche dietro sollecitazione di Brandt e Palme. Il negoziato non si aprí veramente e il suo stallo generò un motivo ulteriore di conflitto nella politica interna dopo l’insediamento del governo Craxi nell’agosto 1983. Berlinguer si oppose duramente alla decisione di Craxi di procedere all’installazione dei missili americani rispettando tempi e modalità della decisione Nato di quattro anni prima. Nello stesso tempo, impiegò la nozione di sicurezza interdipendente in Europa e accusò entrambe le superpotenze di adottare una visione incentrata su strumenti militari invece che politici, un argomento critico corrente nella sinistra socialdemocratica europea137. Il nodo del rapporto con le socialdemocrazie restava però irrisolto, come fece notare Napolitano in una nota sul Congresso del Partito socialista francese svoltosi nell’ottobre 1983, dove aveva riscontrato «un minore interesse, rispetto ad altri periodi, per la situazione italiana e per la nostra politica»138. Le divisioni tra i socialisti europei sul tema degli euromissili e della sicurezza, che vedeva su posizioni atlantiste i partiti al governo in Francia e nei paesi dell’Europa meridionale, compresa l’Italia, e contrari all’immediata installazione dei missili i socialdemocratici tedeschi all’opposizione, permettevano al Pci di inserirsi nel gioco tra le forze della sinistra europea. Ma ciò non prefigurava alleanze politiche. Il duello tra Berlinguer e Craxi nella politica interna costituiva l’ostacolo piú visibile a una simile evoluzione, ma non era l’unico. Il rischio della «socialdemocratizzazione» rappresentava come non mai lo spettro peggiore del gruppo dirigente berlingueriano.
Berlinguer si affidava soprattutto al ruolo delle forze “terze”. Il suo accento cadeva adesso molto piú sul movimento pacifista, sulle Chiese e sui paesi non allineati che non sulla Comunità Europea139. L’europeismo dei comunisti italiani era fuori discussione, ma egli riteneva che la sensibilità verso le questioni della pace e dello sviluppo costituisse piú un loro motivo di distinzione che di convergenza nel Parlamento europeo140. A suo giudizio, la prospettiva di un’integrazione europea piú profonda trovava ostacolo nella coscienza inadeguata degli interessi comunitari che avrebbero dovuto fondarla, vale a dire rovesciare il dato «strutturale» delle priorità geopolitiche Est-Ovest e ripensare i nessi e i modelli di sviluppo tra Nord e Sud del mondo141. La questione degli euromissili in Europa gli sembrava soltanto un aspetto di una politica delle due superpotenze, rivolta a contendere aree di influenza globali e limitare gli spazi dei paesi postcoloniali. Berlinguer riconosceva il ruolo di singole personalità quali Brandt, Palme, Mitterrand e il cancelliere austriaco Bruno Kreisky, ma riteneva che mancasse una strategia progressista in grado di legare il tema dell’integrazione con quello del ruolo autonomo dell’Europa. Una simile critica non era propria soltanto del Pci. Le stesse personalità citate non mancavano di avanzare spunti critici sul profilo internazionale della Comunità. Tuttavia le consonanze non facevano emergere strategie comuni.
▲ In un colloquio con i dirigenti iugoslavi Ante Marković e Dobrivoje Vidic, Berlinguer lamentò la perdurante assenza di legami intensi tra il «movimento operaio occidentale» e le «forze progressiste» nel Terzo Mondo, proponendo una nuova iniziativa congiunta tra Pci, Fln algerino e Lega dei comunisti. Fu Marković a notare l’opportunità di estendere la proposta a Brandt e alla Spd. Berlinguer acconsentí ma la sua proposta confermava sfiducia verso l’effettiva collaborazione con le socialdemocrazie sui rapporti tra Nord e Sud del mondo, dopo la forte convergenza degli anni precedenti142. È possibile che questo passo indietro fosse anche una risposta difensiva alla competizione ingaggiata dal governo Craxi con i comunisti non soltanto sulle questioni del dissenso e delle repressioni all’Est europeo, ma anche sui temi della politica estera e della cooperazione internazionale143. Il problema era però che le reti di relazioni costruite dai comunisti italiani tra Italia, Europa e Terzo Mondo mostravano segni di logoramento. Il fatto di costituire l’unico partito comunista di massa in Occidente non era piú un motivo rilevante come in passato per molti interlocutori, salvo le componenti riformatrici silenti in Unione Sovietica e nell’Europa centro-orientale.
La carta internazionale piú importante in mano al Pci restava il ruolo da spendere nelle relazioni con Mosca e con l’Est europeo ai fini di un negoziato sui missili, anche dopo la loro installazione in Occidente. Berlinguer seguí caparbiamente questa strada fino all’ultimo. A questo fine incontrò Ceaușescu, Honecker e il primo ministro greco Andreas Papandreou tra la fine del 1983 e l’inizio del 1984. L’incontro con il capo della Germania orientale non era una circostanza banale, visto che i precedenti risalivano a dieci anni prima e alla Conferenza di Berlino del 1976. Honecker confermò l’interesse della Rdt per mantenere la distensione con la Rft, malgrado il cambio del governo, ma non forní appigli alla mediazione promossa da Berlinguer e lo rinviò ai sovietici circa le possibilità effettive di una trattativa144. Berlinguer ne riferí al presidente Pertini e a Craxi, mentre osservò in Direzione che l’analisi stessa dei motivi della crisi tra le superpotenze divideva il Pci dalla Sed. Osservò, in particolare, come fosse «strana» la proposta sovietica di riportare i missili al livello del 1976, dato che proprio Mosca aveva alterato l’equilibrio esistente allora145. Egli non fece in tempo a incontrare Andropov. Si recò a Mosca in occasione del suo funerale, nel febbraio 1984, e ripropose il ruolo di mediatore del Pci, nel contesto di una visione ormai alquanto disincantata del mondo sovietico146. Il suo discorso pubblico prima della morte prematura, avvenuta nel giugno 1984, era incentrato sul tema della tregua al dispiegamento dei missili non meno che sulle questioni di politica interna, prima fra tutte quella dell’inflazione e della «scala mobile» che portava allo scontro frontale con il governo Craxi147. Negli ultimi mesi, i toni di Berlinguer si fecero talvolta apocalittici circa l’effettiva possibilità di una guerra termonucleare, con la conseguenza di accentuare l’aspetto di «utopia concreta» del pacifismo. Tuttavia egli non divenne profeta di sventure. In una delle sue ultime interviste, indicò nel pacifismo il principale fattore culturale dell’europeismo, anticipando una visione destinata ad avere lunga durata148. Berlinguer ripartí molto nettamente le proprie visioni tra l’idea della politica come regolazione dei conflitti e sfera delle possibilità reali, da una parte, e l’idea della politica come definizione identitaria e pensiero a lungo termine, dall’altra. Al momento della sua scomparsa, la tensione tra queste due dimensioni aveva raggiunto l’apice.
Berlinguer lasciò un’eredità forte, che accomunava buona parte del gruppo dirigente e segnava la formazione di una generazione piú giovane. La sua figura rappresentava nel comunismo italiano la rilettura della visione marxista del mondo in chiave etica. Il suo linguaggio costituiva una miscela di realismo e universalismo, contaminazione e autosufficienza, tradizione e postmodernità. Le sue coordinate si fondavano tanto sull’«invenzione della tradizione» del socialismo umanistico dopo il Sessantotto, quanto sull’acquisizione di grammatiche e spazi nuovi, anzitutto l’europeismo nelle sue diverse declinazioni realiste e visionarie. Entrambe le coordinate si potevano iscrivere simbolicamente nelle fonti originarie dell’antifascismo, ma implicavano un impianto di cultura politica trasformato.
Il legame tra classe e nazione si tramutava nel giudizio morale dei comunisti sui costi sociali e civili della guerra fredda e della «democrazia bloccata». In questo senso, il problema della guerra fredda restava al centro delle loro visioni. Malgrado le sue profonde trasformazioni sociali ed economiche, l’Italia portava ancora i segni della frattura lungo l’asse comunismo-anticomunismo nata alla fine della Seconda guerra mondiale e restava il paese europeo occidentale maggiormente condizionato dal bipolarismo antagonistico come architettura sovraordinante della politica. Molto piú delle classi dirigenti democristiane, i comunisti avevano cercato di modificare il “vincolo esterno” senza però poter immaginare una scomposizione dei fondamentali blocchi politici e sociali del paese. Finita l’esperienza della «solidarietà nazionale», il sistema politico italiano si era riorganizzato seguendo le logiche binarie della guerra fredda. I comunisti potevano contare sulla rendita di posizione garantita dalla divisione in due blocchi della Repubblica, confermata dall’affermazione come primo partito nelle elezioni europee subito dopo la morte di Berlinguer. Tuttavia, a differenza che in passato, i comunisti pensavano la nazione italiana in un rapporto di stretta interdipendenza con l’integrazione europea e nella prospettiva di una crescente architettura politica dell’Europa, mentre il loro «nuovo internazionalismo» liquidava l’appartenenza al movimento comunista. In questa ottica, l’idea dell’Europa come soggetto della politica mondiale acquisiva un posto privilegiato, anche e soprattutto al fine di valorizzare il patrimonio di relazioni costruito nel Sud globale. La battaglia contro le ineguaglianze tra Nord e Sud del mondo si intrecciava con il linguaggio dei diritti umani, identificato come un tema contendibile all’egemonia americana e neoliberale.
L’obiettivo fondamentale di una simile trasformazione era fornire una risposta al declino del comunismo come attore e soggetto politico, emerso con la rottura tra Unione Sovietica e Cina, con il «lungo Sessantotto» e con la guerra fredda globale. Per definizione, una simile risposta non poteva essere nazionale, ma ambiva ad avere una risonanza europea e internazionale che era consentita dall’unicità di una forza comunista di massa in Occidente. Il Pci berlingueriano si autorappresentava come un soggetto a sé stante tra le forze progressiste in Europa e nel mondo extraeuropeo, che non si poteva ricondurre né alle appartenenze socialdemocratiche né alle diverse tendenze antimperialiste. Perciò la sua assertività identitaria era particolarmente insistente. Il disegno di contribuire a un radicale cambiamento del modello di sviluppo capitalistico in Occidente e influire sulla riforma del comunismo sovietico costituiva parte essenziale di tale identità ma creava anche un campo di tensioni difficili da comporre. Le sue fondamenta erano rappresentate da uno schema storico lineare e irrinunciabile, che presentava l’esperienza comunista aperta dal 1917 come un passaggio necessario del progresso umano, ma non piú sufficiente. Le società di tipo sovietico avevano ancora un ruolo da giocare sulla scena globale, a condizione che una riforma autentica ne liberasse il potenziale umano e culturale e che in Occidente si sviluppasse una nuova coscienza anticapitalistica, declinata con i nuovi linguaggi dell’ambientalismo e del «nuovo ordine economico internazionale». In questa luce, l’esperienza delle socialdemocrazie e del welfare state europeo costituiva una pagina relativamente marginale, priva com’era di una carica anticapitalistica e di una vera proiezione fuori dal vecchio continente.
La progettualità dell’ultimo Berlinguer presentava una forte impronta normativa, che sembrava farsi tanto piú radicale quanto meno i vettori e i rapporti egemonici in Europa e nel mondo autorizzavano una scommessa sulle sue possibilità. Ciò rivelava le aporie accumulate nel tempo. La visione universalista si prestava all’obiezione di fornire una valutazione ipertrofica del ruolo del Pci e dell’Italia nella scena mondiale, basata su un’idea dei nessi culturali tra comunisti e cattolici per molti aspetti inattuale nella seconda modernizzazione italiana degli anni Ottanta. La stessa possibilità di svolgere un ruolo transnazionale come partito politico, senza una sponda sovranazionale e governativa, sembrava aver esaurito le sue prospettive. Il patrimonio di relazioni globali costruito dai comunisti italiani costituiva un capitale sempre meno spendibile, alla luce della disgregazione del Terzo Mondo e dell’inerzia del Secondo Mondo. L’integrazione del comunismo italiano nella sinistra europea rischiava di configurare una posizione subalterna invece che di avanguardia, proprio in ragione della sua peculiarità irriducibile a una cultura di ispirazione riformista.
La persuasione che il capitalismo non avesse un futuro faceva velo alla decifrazione delle dinamiche di trasformazione postfordista e postkeynesiana evidenti già nei primi anni Ottanta. Ma soprattutto lasciava in ombra il mutamento di paradigma ormai emerso nel confronto tra comunismo e capitalismo. La percezione generale in Europa, e in un modo crescente nel Sud globale, era che il socialismo sovietico avesse perduto la sfida della modernità e che l’antagonismo tra l’Occidente e l’Unione Sovietica si fosse ridotto alla geopolitica e agli armamenti nucleari. Le ambizioni di disegnare globalizzazioni alternative erano un ricordo del passato e il loro tramonto comprometteva largamente le visioni di progresso ed emancipazione espresse nei linguaggi marxisti per oltre mezzo secolo149. Ciò consentiva al neoliberalismo di affermarsi costruendo un canone che segnava la fine del compromesso keynesiano e delegittimava qualunque modello statalista o di economia mista. Cosí la stagione neoliberale in Occidente poneva problemi comuni a tutte le culture della sinistra europea, piú di quanto i comunisti italiani fossero disposti a riconoscere. Se la difesa del welfare state costituiva un terreno difensivo e sofferente per le socialdemocrazie dinanzi all’onda del monetarismo e della globalizzazione finanziaria, ancor piú ciò valeva per le idee di andare oltre l’esperienza welfarista, che rischiavano di apparire un’illusione e una forma di autoreferenzialità150.
La trasformazione culturale dei comunisti italiani rappresentava una risposta vitale unica nel contesto del comunismo mondiale, in ragione della capacità sincretica di assumere visioni, sensibilità e linguaggi della modernità tardo novecentesca. Ma la loro influenza in Occidente si era estremamente ridotta dopo la fine dell’eurocomunismo. Le chance di influire sulla circolazione di idee riformatrici nell’Europa orientale e in Unione Sovietica non erano invece ancora esaurite, malgrado le apparenze. La capacità di riconoscere per tempo la crisi dell’internazionalismo comunista costituiva una spina nel fianco delle autorappresentazioni ortodosse e un tentativo di combattere l’emarginazione. L’europeismo rappresentava un nesso importante per le silenti componenti riformatrici del mondo sovietico, perché consentiva di ripensare l’internazionalismo e concepire visioni di integrazione senza violare il tabú della «socialdemocratizzazione». Tuttavia, il problema non era soltanto rappresentato dal possibile esercizio di un’influenza, sebbene tutt’altro che trascurabile, nel mondo socialista sovietico. Il comunismo riformatore implicava la ricerca di nuove forme di legittimità, nonché l’immaginazione di un diverso ordine mondiale postbipolare, in una congiuntura storica che sembrava piuttosto segnare il capolinea della principale tradizione rivoluzionaria del secolo.
Epilogo
Il sogno di un nuovo ordine mondiale (1985-1991)
1. L’avvento di Gorbačëv.
Berlinguer consegnò ai suoi successori una forza che non era in alcun modo scontata all’indomani del Sessantotto, quando aveva preso in mano di fatto le redini del Pci. Il comunismo italiano rappresentava un soggetto egemonico nella sinistra italiana, rispettato nella sinistra europea e ancora dotato di relazioni globali. L’eurocomunismo era fallito come movimento politico ma la sua trasformazione culturale costituiva un bagaglio riconosciuto, anche se piú sul piano internazionale che nazionale. Tale trasformazione non implicava soltanto una conversione all’europeismo e al valore universale della democrazia, ma abbracciava un complesso di idee multiforme, che dopo molte resistenze si apriva al femminismo, alle istanze ecologiste, al linguaggio dei diritti umani, al pacifismo postbipolare. Il patrimonio di cultura politica accumulato dai comunisti italiani restava vivo malgrado lo spirito dei tempi fosse nel frattempo radicalmente mutato, configurando uno scenario avverso. Essi fronteggiavano la «seconda guerra fredda», la svolta neoliberale in Occidente, la crisi conclamata delle società di tipo sovietico, lo sgretolamento del Terzo Mondo. Il movimento comunista internazionale non costituiva piú un’autentica appartenenza, anche per loro scelta, mentre nella politica nazionale affioravano i primi segnali di una disaffezione sociale verso il sistema dei partiti.
Le aporie sperimentate dai comunisti italiani alla metà degli anni Ottanta erano piú forti di quelle risalenti al «memoriale» di Jalta di Togliatti vent’anni prima. Essi rappresentavano l’unico soggetto del mondo comunista che aveva cercato di fornire risposte allo shock globale e ai problemi emersi nel blocco socialista, ma i loro strumenti analitici restavano per molti aspetti influenzati da rigide categorie della crisi o da mitologie persistenti. La loro strategia puntava su un forte orgoglio identitario, che intendeva distinguerne il profilo dalle socialdemocrazie come dal socialismo di tipo sovietico, ma produceva anche isolamento politico. L’idea della «terza via» costituiva piú una testimonianza in attesa di tempi migliori che non un’idea-forza in grado di fare proseliti. La reinvenzione dell’internazionalismo fuori dalla logica dei blocchi si era rivelata un compito improbo. Il legame esistenziale con i destini del mondo socialista rappresentava un connotato molto piú visibile di quanto non lo fosse la progettualità politica in Italia e in Occidente. La tensione tra la legittimazione come forza di governo in Occidente e la prospettiva di riforma del comunismo restava irrisolta. I successori di Berlinguer affrontarono queste aporie dividendosi tra loro, anche e soprattutto sotto il profilo generazionale.
L’avvento al potere di Michail Gorbačëv, eletto segretario generale del Pcus nel marzo 1985, costituí il fattore centrale per tutti, malgrado la distanza progettuale che ormai li separava dal socialismo di tipo sovietico e la loro crescente integrazione nelle agende della sinistra europea. Come i successori di Togliatti avevano identificato nella «primavera di Praga» il senso di una missione rinnovata, cosí i successori di Berlinguer videro nei riformatori sovietici l’occasione per rilanciare una vocazione cosmopolita che aveva in modi diversi caratterizzato il comunismo italiano nella sua storia. Dopo una prima fase di cautela, essi ritennero vendicate le proprie profezie e speranze. Seppure con sfumature diverse, dirigenti, intellettuali e militanti comunisti di generazioni diverse percepirono Gorbačëv come un riscatto delle loro ragioni. La loro visione non si limitò però a un simile aspetto, dopo anni di frustrazioni. Ciò che contava ai loro occhi non fu soltanto la perestrojka, cioè l’inizio di una stagione di liberalizzazione e riforme del sistema sovietico, ma soprattutto il «nuovo modo di pensare», cioè la formulazione di una visione universalista che si richiamava alla “invenzione della tradizione” del socialismo umanistico. Tale visione costituiva infatti una forma di ibridazione culturale ispirata alla prospettiva di un mondo post-guerra fredda, convergente con altre culture politiche e religiose, senza rinnegare le narrazioni volte a rivendicare l’identità comunista.
Le memorie dei protagonisti, a cominciare dallo stesso Gorbačëv, hanno enfatizzato il momento topico rappresentato dai funerali di Berlinguer nel giugno 1984. Gorbačëv ricorda che il vasto sentimento di commozione popolare e nazionale da lui allora percepito rivelava «una mentalità e una cultura politica molto diversa dalla nostra» e che questa esperienza ebbe per lui un significato persino superiore alla lettura di Gramsci1. Anche Černjaev ha fissato nelle proprie memorie la forte impressione destata sui delegati sovietici dall’intensità e dalle dimensioni di massa del commiato popolare2. Rubbi afferma che in quella circostanza Gorbačëv riconobbe l’influenza esercitata da Berlinguer sulla generazione piú giovane dei dirigenti sovietici3. In occasione dei funerali del successore di Andropov, Konstantin Černenko, il 14 marzo 1985, la decisione di Gorbačëv di incontrare un solo leader comunista europeo, il segretario del Pci Alessandro Natta, costituí di per sé un segnale di cambiamento4.
Ciò nonostante, ammaestrati dalle esperienze passate, i comunisti italiani accolsero il nuovo leader sovietico con molta cautela. Nella conversazione con Natta, Gorbačëv non andò oltre formulazioni alquanto tradizionali e riaffermò genericamente il ruolo di tutti i comunisti nella «battaglia per la pace»5. Pochi giorni dopo, riferendo alla Direzione, Natta disse che ci si poteva aspettare «qualche cambiamento e una certa dinamicità, ma sappiamo quanto sono complessi i problemi dell’Urss, del Pcus, per le posizioni che conosciamo. Fiducia e prudenza insieme, dunque»6. Come ricorda Giuseppe Boffa, «appuntavamo su di lui qualche speranza piuttosto che certezze»7. Il primo comunista italiano a colloquiare con Gorbačëv su temi strategici, quali l’europeismo, fu Gianni Cervetti in un incontro informale richiestogli dallo stesso leader sovietico durante un soggiorno a Mosca, poco prima di incontrare Craxi e Andreotti nel giugno 19858. L’iniziativa di Craxi, tra i primi capi di governo europei a vedere Gorbačëv, rilanciò la Ostpolitik italiana e fu volta a sottrarre ai comunisti il ruolo giocato in precedenza nei negoziati sugli euromissili9. Le questioni di politica estera non cessavano di costituire anche un fattore della politica interna, come già era accaduto nella prima metà del decennio.
Soltanto nel gennaio 1986 si delineò una evidente consonanza tra i comunisti italiani e la nuova leadership sovietica. L’attenzione di Gorbačëv verso le posizioni del Pci fu assai piú concreta, specie riguardo agli orientamenti europeisti10. Egli prospettò la propria visione di un mondo interdipendente e chiarí che il recupero di un «dinamismo» del sistema sovietico doveva investire anche il sistema politico e la «democrazia socialista». La sua idea di sviluppare «le potenzialità del socialismo», che riteneva inibite «per cause storico-oggettive», quali il condizionamento della guerra fredda, ma anche «per ragioni soggettive», presentava un’ovvia sintonia con le posizioni dei comunisti italiani. Le rispettive idee sul comunismo internazionale restavano invece distanti. Secondo Gorbačëv, il movimento comunista, sebbene «indebolito», rappresentava ancora «una enorme forza su scala mondiale», che doveva rispondere «al contrattacco economico-culturale-politico del capitalismo» con il ritorno ai suoi «obiettivi ispiratori». «Non propongo di riesumare l’Internazionale comunista», precisò il leader sovietico, «ma incontrarsi è necessario». La replica di Natta marcò la distanza che ancora separava le due parti: «Il Pci non è, né si sente, parte di un m[ovimento] c[omunista] i[nternazionale] che nella accezione tradizionale della definizione non esiste oggi e la cui rifondazione oltre che impossibile comporterebbe gravi danni». A questo punto, Gorbačëv dovette riconoscere che si erano confrontate «idee diverse» ma ribadí di voler stringere i rapporti con il Pci. Entrambi i leader sapevano che le rispettive visioni potevano divergere sulla percezione del movimento comunista, ma erano accomunate dall’idea che proprio la prospettiva riformatrice richiedesse di marcare la distinzione dalla socialdemocrazia. Gorbačëv affermò che i comunisti non potevano ridursi a una «variante» della socialdemocrazia («se i comunisti passano alle posizioni dei socialdemocratici dove finirà la prospettiva comunista? Ne verrebbe meno la stessa ragione storica»)11.
Natta riferí a Roma di aver riscontrato in Gorbačëv il tentativo di ricomporre le relazioni basandole su una visione «un po’ tolemaica» dei rapporti tra Mosca e i partiti comunisti. Sostenne però che la formula gorbaceviana della «mancata progressione» del sistema sovietico potesse considerarsi «sinonimo» del berlingueriano «esaurimento della spinta propulsiva». I dirigenti del Pci accolsero queste valutazioni, anche se con accenti diversi. Il piú scettico fu Napolitano, secondo il quale tutto era «da verificare» nei propositi di rinnovamento sovietici, mentre il Pci non poteva pensare di «tornare a identificarsi con i vecchi blocchi e movimenti». Sulla base della propria esperienza, Rubbi presentò lo scenario di una partita da giocare, osservando che a Mosca si era svolta «una lotta di tre anni» circa l’opportunità di riportare il Pci all’ortodossia oppure «comprendere le nostre ragioni e […] coesistere»12. Dopo la catastrofe di Černobyl′, gli italiani intercettarono alcuni segnali di un cambiamento piú deciso nella condotta di Gorbačëv13. Durante un incontro con una delegazione del Pci guidata da Napolitano, nel giugno 1986, Zagladin espresse «comprensione» per le posizioni del Pci sulla sinistra europea e pose l’accento sulla «revisione» sovietica nel giudizio verso i partiti socialdemocratici. Napolitano ne trasse l’impressione che le cose fossero in movimento, come del resto provava il passaggio da un interlocutore come Ponomarëv a un altro «cosí radicalmente diverso» come il diplomatico Anatolij Dobrynin14. Alla fine dell’anno, il vertice di Reykjavík tra Gorbačëv e Reagan, malgrado il fallimento di un’intesa concreta, segnalò la possibilità di una nuova distensione bipolare basata sul disarmo, mentre il rilascio di Andrej Sacharov dal confino annunciò la liberalizzazione in Unione Sovietica15. L’interazione tra riforme domestiche e cambio di paradigmi internazionali costituiva ormai un dato di fatto nella percezione mondiale di Gorbačëv. I comunisti italiani non facevano eccezione, ma potevano vantare un rapporto privilegiato, che si basava su un linguaggio comune ritrovato. L’intervista rilasciata da Gorbačëv all’«Unità» del 20 maggio 1987 fu uno dei veicoli per la risonanza delle sue idee nell’opinione pubblica italiana ed europea, anzitutto sul tema della «casa comune europea», che era stato avanzato a Praga un mese prima e alludeva alla riunificazione del continente diviso16. I cambiamenti che si profilavano a Mosca interagirono con le strategie degli italiani, soprattutto incoraggiando rinnovate prese di contatto nell’Europa centro-orientale, ma non indussero modifiche sostanziali per un certo periodo di tempo.
Natta seguí le coordinate internazionali lasciate da Berlinguer, continuando a intrecciare i rapporti con le sinistre in Europa, con i tradizionali interlocutori iugoslavi, algerini e palestinesi nel Mediterraneo e con i comunisti cinesi. Egli riprese la trama di una conferenza sul Mediterraneo, interrotta da oltre due anni, discutendone insieme a esponenti iugoslavi, algerini e palestinesi17. Nell’ottobre 1985, incontrò Deng Xiaoping e Hu Yaobang a Pechino, constatando la convergenza delle rispettive posizioni contrarie alla logica dei blocchi. Deng sottolineò l’importanza di un ruolo autonomo dell’Europa occidentale, che avrebbe favorito qualcosa di analogo nell’Europa centro-orientale, e dichiarò di avere abbandonato la visione dell’inevitabilità della guerra. Natta rilevò il significato di un simile cambiamento concettuale nella politica estera cinese, che consolidava l’opposizione ai blocchi e la solidarietà con il Terzo Mondo, fondata sulla critica del modello sovietico in Africa e sulla prospettiva della fine dell’ordine bipolare18. Alcuni mesi dopo, incontrando Hu Yaobang a Roma nel giugno 1986, Natta e Napolitano sollecitarono valutazioni su Gorbačëv. I cinesi ritenevano che la spesa militare fosse il principale tra i nodi da sciogliere della perestrojka e che l’unico modo per salvare l’Unione Sovietica fosse la sua rinuncia alla attuale «posizione strategica» nel mondo19. Un argomento legato alla critica maoista ma anche alquanto realista. I comunisti italiani non parevano realizzare appieno il carattere dirompente del distacco cinese dal modello sovietico di economia amministrata e la loro influenza delegittimante per il socialismo sovietico nel Terzo Mondo, che a metà degli anni Ottanta era ormai visibile20. Per loro contava di piú l’idea che potessero crearsi visioni convergenti circa la nascita di un mondo post-guerra fredda, in grado di congiungere per la prima volta il Pci con sovietici e cinesi.
La principale novità fu però la formula coniata da Napolitano, che rappresentava il Pci quale «parte integrante della sinistra europea» con l’obiettivo di liquidare la «diversità» e le ambiguità nei rapporti con la socialdemocrazia. Scomparso Berlinguer, egli era di gran lunga l’esponente piú autorevole del comunismo italiano in campo internazionale. Divenuto responsabile della politica internazionale al posto di Pajetta, dette impulso alle intese in tema di sicurezza europea con la Spd21. L’incontro di Natta con Brandt del 26 marzo 1986 fu volto a concretizzare questo passaggio tramite l’ipotesi di instaurare un rapporto formale22. La ricerca di intese riformatrici si rivolse anche all’Europa centro-orientale. Nell’ottobre 1986, Natta incontrò Kádár a Budapest guidando una delegazione al massimo livello, composta da Napolitano, Pajetta e Bufalini, a riprova dell’importanza annessa ai colloqui. L’argomento principale degli italiani fu che tutta la sinistra europea, e non soltanto i comunisti, doveva rispondere all’«offensiva neoliberista». La loro metodologia era quella degli incontri bilaterali, implicitamente volta a evitare un coinvolgimento nel movimento comunista. Kádár si dichiarò in sintonia con Gorbačëv e ammise che il «socialismo reale» aveva creato «un compromesso sociale di basso livello» tra retribuzioni modeste e bassa produttività23. Completamente diverso fu il tono freddo e teso dell’incontro tra Natta e Jaruzelski, mentre Honecker si mostrò propenso a adottare riforme economiche ma non istituzionali24.
In sintesi, i comunisti italiani inserirono il nuovo rapporto con Mosca in un telaio già preesistente di relazioni internazionali, senza mirare a un asse preferenziale e limitandosi a sondare le prime ripercussioni della perestrojka nell’Est europeo. Tuttavia, nel corso del 1987 Gorbačëv si impose come la figura chiave di una riforma dell’ordine mondiale, che investiva direttamente l’Europa e non soltanto il contesto delle superpotenze. Egli intensificò i propri rapporti con l’Europa occidentale, concepiti come un aspetto centrale del «nuovo modo di pensare»25. L’obiettivo iniziale di arginare il declino sovietico e liberare risorse ponendo un freno alla corsa agli armamenti acquistò toni e orizzonti ideali piú pronunciati, ispirati all’idea di creare nuove forme di legittimazione politica e di rilanciare una missione universalistica. Ciò suscitò una crescente adesione, ma anche accenti diversi, tra i comunisti italiani. Napolitano fece osservare che la spinta riformatrice in Unione Sovietica doveva essere meglio compresa, e non soltanto assecondata in modo acritico, proprio perché poneva questioni «fortemente intrecciate ormai con quelle del nuovo sistema di relazioni internazionali», che non si poteva piú limitare al multilateralismo occidentale. In questa luce, il problema prioritario era, a suo giudizio, il ruolo dell’Europa nella distensione internazionale. Una parte del gruppo dirigente, ad esempio Reichlin, riteneva invece che gli scenari aperti dall’iniziativa di Gorbačëv implicassero anche una «crisi» del neoliberismo, come avrebbe mostrato il «lunedí nero» di Wall Street, il 19 ottobre 198726. Il corto circuito tra le speranze accese dai riformatori sovietici e le illusioni di una crisi dell’egemonia neoliberale occidentale doveva restare influente nelle visioni del gruppo dirigente anche dopo che il crollo della borsa americana si rivelò un fenomeno contingente.
Nel suo discorso in occasione del settantesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre, Gorbačëv dichiarò impossibile analizzare «gli sviluppi globali» soltanto nell’ottica del confronto «tra due opposti sistemi sociali» e senza comprendere le interdipendenze mondiali. Cosí sancí la fine di una visione dicotomica del mondo forgiata dai comunisti molto prima della guerra fredda. Una simile nota non poteva non suonare armonica ai delegati socialdemocratici presenti a Mosca, ma anche ai comunisti italiani e ai riformatori dell’Est europeo rimasti silenti nell’epoca brezneviana. Probabilmente fu invece una dichiarazione inquietante per gli establishment, che avevano coltivato le proprie pratiche di potere all’ombra del Muro. Lo stesso Gorbačëv lamentò riservatamente come le sue riforme suscitassero piú interesse tra i socialdemocratici che non tra molti partiti comunisti27. I comunisti italiani costituivano la principale eccezione. La loro stampa presentava ormai il leader sovietico come un riformatore che seguiva l’eredità di Berlinguer. Nel settantesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre, Gorbačëv fu celebrato come una risorsa simbolica del comunismo italiano, mentre gli altri partiti comunisti si mostravano tiepidi o persino ostili28. La sua figura equivaleva per molti alla dimostrazione che il sistema sovietico fosse riformabile, risolvendo cosí una volta per tutte una questione dibattuta ferocemente negli ambienti intellettuali e politici occidentali. Fece breccia l’idea che il «nuovo modo di pensare» avesse ormai egemonizzato l’agenda internazionale. In Direzione, il vicesegretario Occhetto sostenne che il «governo mondiale dei processi» era adesso una «utopia davvero concreta»29.
Nel marzo 1988, in un memorandum sul proprio viaggio in Italia, Zagladin riferí a Gorbačëv l’impressione di «un radicale e profondo cambiamento» nell’atteggiamento dei comunisti italiani verso Mosca. A suo giudizio, i contrasti del passato erano ormai superati, compresa l’incomprensione sovietica verso l’eurocomunismo e le diffidenze iniziali del Pci verso lo stesso Gorbačëv. Il memorandum conteneva anche indiscrezioni sulla situazione interna del Pci, che evidenziavano conflittualità e crisi di leadership. Secondo le informazioni raccolte dal dirigente sovietico, il principale punto di frattura nasceva dal tentativo di omologare il comunismo italiano alla socialdemocrazia e di raggiungere una «reciproca comprensione» con gli Stati Uniti, attribuito a Napolitano. Uno degli uomini che piú direttamente rappresentava il legame con l’eredità di Berlinguer, Tatò, confidò a Zagladin che il sensibile indebolimento dei «legami di massa» del Pci, emerso con la sconfitta elettorale del 1987 e motivo di crescente preoccupazione tra i dirigenti del partito, doveva anche essere attribuito all’attività di coloro che lo spingevano verso una «socialdemocratizzazione». Tatò attaccava in modo frontale Napolitano, riferendosi tra l’altro, implicitamente, alla sua affermazione che i comunisti italiani erano ormai «usciti dai confini della tradizione comunista», che aveva provocato reazioni largamente negative nel Pci30. Al fine di invertire la rotta, l’ex segretario di Berlinguer riteneva necessario un cambio generazionale di leadership e indicava in Occhetto l’uomo giusto per realizzare una «perestrojka del Pci»31. Non si può escludere che simili affermazioni fossero rivolte a sondare l’atteggiamento dei sovietici, se non a ottenere il loro favore, verso la candidatura di Occhetto a segretario generale. In ogni caso, le informazioni riportate nel memorandum di Zagladin erano attendibili nelle loro linee generali. A dividere i comunisti italiani non era il giudizio su Gorbačëv, ma la maggiore o minore consistenza della linea di demarcazione identitaria con le socialdemocrazie europee, un nodo strettamente intrecciato con la scena politica nazionale e la prospettiva del governo.
Gli incontri con Gorbačëv a Mosca, il 29 e il 30 marzo 1988, suscitarono la viva partecipazione dei principali dirigenti del Pci32. Il tema dell’Europa fu al centro dell’intesa tra le due parti. Natta ribadí le posizioni del Pci sul ruolo dell’Europa occidentale nella distensione e sul fatto che la Comunità non aveva provocato una subalternità europea agli interessi degli Stati Uniti, a differenza di quanto ritenevano altri partiti comunisti. Gorbačëv confermò che l’Unione Sovietica si considerava «prima di tutto un paese europeo» e non giudicava la Comunità «solo in termini negativi». In questo contesto collocò il significato della nozione di «casa comune europea», sostenendo che «se nel mondo avanza l’interdipendenza, ciò tanto piú vale per l’Europa». Egli pose ai comunisti italiani il dilemma che piú li angustiava, rilevando che non si trattava soltanto di riconoscere l’integrazione quale «tendenza oggettiva», ma di chiedersi se la sinistra europea avesse «un progetto per governarla, per rifondarla ai propri fini». A suo parere, i comunisti italiani avrebbero dovuto allearsi con i partiti socialisti al governo «per mutare indirizzi di cui essi sono corresponsabili». Sostenne che l’unica alternativa alla perestrojka era il declino della presenza dell’Unione Sovietica «negli affari mondiali» e ne andava perciò «dello stesso destino del socialismo». Rassicurò però i suoi interlocutori circa la gradualità del cambiamento «senza destabilizzazioni» nell’Europa centro-orientale33. Dopo l’incontro, Gorbačëv riferí al Politbjuro di avere constatato insieme agli italiani «la seria e pericolosa arretratezza delle concezioni di molti partiti comunisti […] in primo luogo quelli a noi piú fedeli»34.
L’azione dei riformatori sovietici raggiunse il culmine nella primavera-estate 1988. Gorbačëv colse i frutti della propria offensiva diplomatica nei due summit tenuti a Washington nel dicembre 1987 e a Mosca nel maggio 1988, che finalizzarono gli accordi tra le superpotenze sulla riduzione degli armamenti nucleari a medio raggio. Nella sua passeggiata sulla Piazza Rossa del 31 maggio 1988, Reagan dichiarò che non considerava piú l’Urss come «l’impero del male», ritirando cosí il celeberrimo appellativo assurto a segno dominante della «seconda guerra fredda». Il problema degli euromissili che aveva assillato la politica europea e mondiale per un decennio venne liquidato35. Sull’onda di questo successo, Gorbačëv lanciò il progetto di separare il partito dallo Stato, annunciò il proposito di lanciare riforme di mercato e abbandonò l’idea della «coesistenza pacifica» come lotta di classe. In questo contesto, una vecchia conoscenza degli italiani come Černjaev, ormai braccio destro di Gorbačëv nella politica internazionale, si incaricò di liquidare l’internazionalismo comunista come un anacronismo36. In una nota per il leader, egli tagliò corto circa il senso e l’esistenza stessa del movimento («è chiaro a tutti che il movimento comunista, che noi tradizionalmente siamo usi a vedere come tale, di fatto non esiste»). Secondo Černjaev, era venuto il momento di mettere fine al movimento comunista internazionale in quanto «categoria politica» incapace di offrire soluzioni ai «problemi globali». L’autore portava ad esempio i comunisti francesi e si chiedeva in che modo e «per fare che cosa» essi potessero essere considerati «alleati». Quello che occorreva era invece «una rinascita della comunanza ideologica» che avrebbe richiesto tempo37.
La nuova leadership di Occhetto, subentrato a Natta nel giugno 1988, investí sull’interazione con Gorbačëv. Si progettò un documento comune tra Pci e Pcus sull’Europa come spazio e nozione centrale per ridefinire una missione internazionalista, mettendo in cantiere l’organizzazione di una «tavola rotonda» paneuropea, alla quale avrebbero dovuto prendere parte forze politiche di diverso orientamento, anche al di fuori della sinistra38. In ottobre, la Direzione discusse un documento sul «nuovo corso politico» del partito che indicava nell’interdipendenza la «nuova legge» dell’ordine mondiale e progettava un «nuovo fronte riformatore» europeo contro il neoliberismo, che avrebbe aspirato alla «sovranità politica del popolo europeo». Il linguaggio del gruppo dirigente guidato da Occhetto si intrecciava con quello gorbaceviano e soltanto Napolitano criticò le «definizioni suggestive da cui però non siamo in grado di trarre conseguenze»39. Il 27 dicembre 1988 Gorbačëv pronunciò all’Onu un discorso incentrato sulle interdipendenze mondiali, destinato a rappresentare il suo manifesto circa «l’erosione delle fondamenta della guerra fredda»40. Una simile prospettiva riguardava anzitutto l’Europa e lasciava intravedere la fine della sua divisione. Il 24 gennaio 1989, egli pose al Politbjuro una questione dirompente: come avrebbe reagito Mosca se l’Ungheria avesse fatto domanda per entrare nella Comunità Europea? Uno scenario che non si poteva escludere dal momento che i comunisti riformatori avrebbero affermato la loro agenda dopo il ritiro di Kádár, avvenuto meno di un anno prima. Gorbačëv fece capire che egli non si sarebbe opposto ma avrebbe semmai accettato la sfida creando un rinnovato sistema di relazioni internazionali41. In febbraio fu avviata in Polonia, anche grazie alla pressione di Mosca, la «tavola rotonda» tra il regime comunista e Solidarność volta a legalizzare l’opposizione otto anni dopo il colpo di Stato militare.
La visione dei comunisti italiani si concentrava ora quasi esclusivamente sull’Europa, seguendo la priorità della fine della guerra fredda, che appariva a portata di mano grazie al «nuovo modo di pensare». Ciò configurava un cambiamento del nesso stabilito da tempo tra europeismo e globalità e persino un abbandono del paradigma creato da Togliatti connettendo «coesistenza pacifica» e decolonizzazione. I nessi pratici e concettuali con il Terzo Mondo rappresentavano un patrimonio della storia comunista che il gruppo dirigente italiano aveva modellato e interpretato a suo modo in momenti diversi, legandoli al «campo socialista» come all’interesse nazionale. Quei nessi costituivano anche una carta d’identità a lungo cruciale per rivendicare la diversità dalle socialdemocrazie. Berlinguer aveva concepito la stessa scelta europeista in rapporto alle agende del «nuovo ordine economico internazionale» e dell’asse Nord-Sud nel mondo. L’europeismo dei suoi successori sembrava adombrare invece una rinuncia a riannodare legami difficili e improduttivi, una presa d’atto di fratture incomponibili e, insieme, l’inizio di una ridefinizione identitaria che intendeva l’europeizzazione come una sfera di valori autosufficiente.
Sotto questo profilo, l’evoluzione del Pci interagiva con la «ritirata» dal Terzo Mondo dell’Unione Sovietica, segno dei fallimenti conosciuti dai comunisti nel Sud globale anzitutto sotto il profilo del modello di sviluppo. L’aspetto piú simbolico era la decisione presa da Gorbačëv di lasciare l’Afghanistan, meditata sin dal 1985 e annunciata nell’aprile 1988, riconoscendo l’errore fatale compiuto con la scelta dell’invasione. Ma lo stesso «nuovo modo di pensare» implicava un abbandono dell’interventismo nel Terzo Mondo, recuperando le critiche di alcuni analisti sovietici e di matrice eurocomunista contro il supporto ai regimi socialisti africani, formulate alla fine degli anni Settanta42. Era anche sempre piú evidente la tendenza dei paesi del blocco sovietico ad abbandonare le politiche di sviluppo promosse nei decenni precedenti, fondamentalmente perché troppo impegnati a far fronte al proprio indebitamento con l’Occidente per cercare soluzioni al debito crescente nel Terzo Mondo43. I comunisti riformatori cercarono di fornire un orizzonte di senso al tramonto delle idee e pratiche di una globalizzazione alternativa, ricentrando in Europa le loro visioni dell’ordine mondiale e la loro cultura politica. Il tema dei rapporti Nord-Sud del mondo restava una declinazione essenziale ma non aveva piú il significato di un’agenda politica. Una simile dinamica affiorava in Europa tramite la crescente rilevanza del tema e del linguaggio dei diritti umani nel definire la missione stessa dell’integrazione44. Il duplice tramonto della guerra fredda e del Terzo Mondo sembravano cosí implicare una nuova forma di eurocentrismo culturale trasversale.
2. Il collasso del comunismo.
All’inizio dell’anno 1989, i comunisti italiani si trovavano in una situazione per molti aspetti inversa a quella conosciuta cinque anni prima, al momento della morte di Berlinguer. Nella politica nazionale, era emersa l’erosione del consenso elettorale e con essa il timore che la loro forza di massa potesse subire un declino, nel contesto di un piú generale logoramento delle forme di organizzazione politica della Repubblica. L’immobilismo del sistema politico incentrato sulla «democrazia bloccata» contrastava in modo stridente con il dinamismo della società italiana, ma anche con il radicale movimento della politica internazionale. La special relationship instaurata con Gorbačëv toglieva i comunisti italiani dalla scomoda posizione di predicatori nel deserto e offriva loro un ruolo di un certo rilievo, con ricadute positive nella politica nazionale data la crescente popolarità del leader sovietico in Europa e in Italia. Occhetto si proponeva di imprimere dinamismo alla propria politica nazionale, riconoscendo di fatto che l’emarginazione del passato decennio era stata anche una forma di autoesclusione. I riformatori sovietici incoraggiarono la nuova leadership italiana. Černjaev manifestò a Rubbi riconoscenza verso il Pci per aver espresso con un anticipo di dieci anni «idee, giudizi e critiche che hanno trovato piena conferma nei fatti», oltre che per il sostegno alle riforme in Unione Sovietica. Egli lamentò, per contro, le serie difficoltà causate al processo riformatore sia da resistenze interne all’establishment, sia dalla «fronda di alcuni alleati», tra i quali spiccavano Cuba, la Rdt e la Romania. Černjaev insisteva sul fatto che un fallimento di Gorbačëv sarebbe stato un duro colpo per tutti i comunisti: «Noi non vogliamo legare nessuno alla nostra esperienza, ma come si fa a dire che la perestrojka è cosa che riguarda solo i sovietici? (riferimento a Marchais). Abbiamo bisogno di cambiare tutti e alla svelta se vogliamo ancora avere una prospettiva»45. Il dirigente sovietico reclamava, in sostanza, il senso e la missione internazionale della perestrojka, un richiamo destinato a trovare forte ascolto nei comunisti italiani. Il passaggio generazionale verificatosi con l’elezione di Occhetto doveva anzi incrementare l’intensità delle relazioni e la prossimità di linguaggi tra comunisti italiani e riformatori sovietici. Nello stesso tempo, l’isolamento di entrambi i soggetti nel mondo comunista era anche un dato conclamato. Invece di generare un movimento riformatore, la perestrojka aveva saldato un fronte transnazionale di opposizione conservatrice che coinvolgeva i principali establishment dell’Europa centro-orientale, specie i tedeschi orientali, gran parte dei comunisti occidentali, specie i francesi e i portoghesi, e la stragrande maggioranza dei comunisti in Asia, Africa e America Latina. In modi piú o meno dissimulati, Gorbačëv era visto come un pericoloso sognatore, un revisionista e un traditore della lotta antimperialista46. I comunisti riformatori eliminarono dal loro lessico la nozione di comunismo internazionale, ma il problema rimaneva.
I comunisti italiani si rivolsero nello stesso tempo a Brandt e a Gorbačëv, ma il rapporto con il secondo era piú intenso. Occhetto e Napolitano incontrarono Brandt e altri dirigenti della Spd nel gennaio 1989. Le aperture reciproche furono sensibili ma senza varcare i confini già toccati negli anni di Berlinguer. L’instaurazione di rapporti formali era un’ipotesi tuttora non praticabile e le intese nel Parlamento europeo restavano limitate a un approccio tematico. I tedeschi fecero notare che il federalismo europeista degli italiani non favoriva le prospettive di collaborazione47. Un mese dopo, il 28 febbraio 1989, Occhetto si recò a Mosca per incontrare Gorbačëv. Il realismo che in precedenza aveva contraddistinto la condotta dei dirigenti italiani aveva ceduto il passo a una vera e propria identificazione. Occhetto sostenne che nel partito italiano si faceva ormai «il tifo» per Gorbačëv e caricò di significato i nuovi rapporti stabiliti fuori dal vecchio contesto del movimento comunista, nella prospettiva di una «ricomposizione di tutte le forze di progresso che si muovono sul terreno dell’europeismo» per definire «una concezione nuova, meno ingenua di progresso». Egli precisò che «il nostro problema non è però quello di chiedere di entrare nell’Internazionale socialista». Il codice comune principale restava la narrazione neoleninista, che vedeva lo stalinismo come una «degenerazione» e rimuoveva i nodi alle origini stesse del comunismo, nonché l’idea di realizzare una metamorfosi politica dell’intera tradizione secolare socialista. Cosí Gorbačëv la immaginava: «Se capisco, pensate a un movimento su una via che porti piú democrazia, economica, sociale, politica. Sarà dunque un processo, se intendo bene. Domanda: il partito si dissolve, diventa socialdemocrazia? Ho l’impressione che non sia cosí». Egli rivelò di avere proposto a Brandt una prospettiva di ripensamento comune («dopo il 1914 non vogliamo iniziare una nuova strada?») Il leader sovietico riteneva che nel mondo comunista si assistesse a «un generale ripensare che cosa è il socialismo oggi», ma non mancò di indicare «il pericolo di gettare nel fuoco della perestrojka anche materiale esplosivo», cioè una destabilizzazione dell’Europa centro-orientale che avrebbe potuto generare «fenomeni e decisioni di segno opposto»48.
Černjaev ricorda il colloquio tra Gorbačëv e Occhetto come uno scambio di particolare impegno, nello stato di incertezza sempre piú acuto sperimentato dal gruppo riformatore sovietico49. Riferendo alla direzione, Occhetto parlò di un confronto «tra due processi riformatori» rivolto al «superamento degli schemi» nei rapporti bilaterali e al definitivo accantonamento del «movimento comunista». Una simile affermazione provocò una forte divergenza con parte della vecchia generazione. Natta e Ingrao, in particolare, si dissero contrari a rompere i rapporti con gli altri partiti comunisti50. In realtà, Occhetto prospettava soprattutto un’identificazione emotiva e politica con Gorbačëv, immaginando di esercitare la funzione di ponte tra la perestrojka e la sinistra europea. Per altri invece il nesso europeo era anteposto al rapporto con Gorbačëv, anche per motivi di politica nazionale. In vista delle elezioni europee, due dirigenti diversi tra loro come Napolitano e D’Alema posero l’accento su come uno schieramento progressista in Europa avrebbe potuto contribuire a sanare «l’anomalia» italiana51.
L’incontro tra comunisti italiani e riformatori sovietici celava un interrogativo irrisolto. Si intendeva rinnovare la tradizione comunista, nella persuasione che essa avesse risorse autosufficienti per rivitalizzarsi in una nuova sinistra progressista? Oppure si voleva andare oltre quella tradizione, riconoscendo che la riforma del comunismo doveva modificare alla radice la sua stessa identità? Le risposte a questo duplice interrogativo non erano chiare né a Roma né a Mosca. Il «partito nuovo» di Occhetto si apriva ai rapporti con il socialismo europeo ma oscillava piú verso la prima che verso la seconda opzione, con un’ispirazione rivolta all’ultimo Berlinguer e al suo accento sulla «diversità» del comunismo italiano. Fu emblematica la scelta di dare vita a un nuovo gruppo parlamentare europeo, distinto da quello comunista ma anche da quello socialdemocratico, che rimarcava il caso speciale dell’Italia52.
I nodi cominciarono a venire al pettine nel giugno 1989. Emersero allora due modelli diversi di risposta alla sfida di Gorbačëv. In Polonia, le prime elezioni semilibere dal 1945 segnarono la clamorosa affermazione di Solidarność e misero in un angolo il Partito comunista. Fu subito evidente che il modello della democrazia monopartitica come forma di transizione era già al capolinea e che ciò non riguardava soltanto la Polonia ma anche gli altri Stati socialisti, compresa l’Ungheria guidata da un gruppo dirigente riformatore. In Cina, il Partito comunista rispose con l’uso della violenza alle proteste studentesche ispirate dalla perestrojka e dal viaggio di Gorbačëv a Pechino. Il massacro di Tienanmen configurava una pratica repressiva ben iscritta nella storia del comunismo e un’alternativa di ordine alla liberalizzazione gorbaceviana, che completava il modello di autoritarismo di mercato costruito da Deng. L’uscita di scena di Hu Yaobang, avvenuta poco prima, e la repressione di Tienanmen rompevano la convergenza riformatrice che era sembrata possibile tra Mosca e Pechino. Il gruppo dirigente italiano condannò la repressione a Pechino e salutò la nascita del governo guidato da Tadeusz Mazowiecki in Polonia, il primo premier non comunista in Europa centro-orientale dopo la Seconda guerra mondiale. Le posizioni del Pci combaciarono con quelle di Gorbačëv anche nell’idea che il nuovo governo in Polonia e le riforme democratiche in Ungheria delineassero un cambiamento graduale e controllabile, destinato a sbloccare i vincoli della guerra fredda liquidando le vecchie sfere d’influenza. Ciò non era affatto irrilevante in Italia, dove persisteva un’anacronistica conventio ad escludendum nei confronti dei comunisti.
L’idea di un mutamento graduale del socialismo nell’Europa centro-orientale, sotto l’impulso della perestrojka, doveva rapidamente dissolversi. Nel settembre-ottobre 1989 lo scenario gradualista fu liquidato da una straordinaria e imprevedibile accelerazione, scandita dalle manifestazioni di massa in Germania Orientale. Tutti i principali attori internazionali furono sorpresi dalla velocità degli eventi che seguirono, portando al crollo del Muro di Berlino. Gorbačëv dimostrò la propria coerenza nell’evitare l’uso della forza, una scelta decisiva per l’esito pacifico del collasso comunista in Europa53. Tuttavia, la sua visione delle riforme “dall’alto” subí un colpo mortale. Il dato di fatto era che i comunisti riformatori avevano sottovalutato la crisi di legittimità dei regimi nell’Europa centro-orientale. Essi furono sorpresi non soltanto dalla velocità degli eventi ma anche dalla loro natura, cioè dalla combinazione tra una rivoluzione pacifica e il crollo di autorità delle istituzioni54. I comunisti italiani non facevano eccezione: sostennero le ragioni della protesta di massa non violenta dilagante nella Repubblica democratica tedesca, ma non misero in conto la delegittimazione dei poteri statali. Le prospettive di riforma sino allora coltivate implicavano l’idea di un rinnovamento delle classi dirigenti comuniste, non certo quella di una generalizzata perdita di senso. A vent’anni dalla «primavera di Praga», il mito dell’autoriforma del socialismo costituiva una motivazione autentica ma anche un abbaglio. La persuasione che la rinascita delle idee riformatrici al centro del «campo socialista» avrebbe prevenuto la loro repressione, a differenza che in passato, e generato un cambiamento inarrestabile non era priva di fondamento. Ma il cambiamento fu molto diverso da quello atteso. I comunisti italiani sottovalutarono la portata della crisi esistenziale all’Est e il ginepraio rappresentato da progetti di riforma che acuivano il discredito degli establishment e innescavano dinamiche distruttive.
Le idee, le analisi e le prospettive di cambiamento legate a Gorbačëv e seguite dal gruppo dirigente del Pci non predisponevano ad affrontare la radicalità degli scenari creati dalla caduta del Muro di Berlino il 9 novembre 1989. La scelta di Occhetto di proporre lo scioglimento del Pci per costituire un nuovo partito della sinistra, compiuta subito dopo, costituí una forzatura coraggiosa nel corso sino allora seguito, anche se essa non sarebbe stata possibile senza il cambiamento di registro precedente, specie dopo il massacro di Tienanmen55. In ogni caso, la «svolta» significava acquisire la coscienza che il legame residuo con la vicenda secolare del comunismo mondiale era finito. La Direzione del Pci del 14 e del 15 novembre 1989 varò un lacerante processo di trasformazione destinato a concludersi soltanto un anno e mezzo piú tardi. Occhetto argomentò la discontinuità collegando strettamente l’aspetto nazionale con quello internazionale, un paradigma culturale di lunga durata che negli anni precedenti si era annebbiato. A suo giudizio, era giunto al capolinea l’ordine di Jalta e si poneva il problema di «un nuovo governo del mondo», ma si dovevano anche fare i conti con «il venir meno di identità di fondo» e con la realtà di una «crisi storica». Egli rivendicò l’originale identità dei comunisti italiani ma ammise che non aveva senso esaltarla e che la loro specificità «o si ricolloca o è destinata a spegnersi» riducendosi a «una funzione provinciale». Riconobbe che l’affermazione di non essere piú parte del movimento comunista era ormai «del tutto insufficiente» e che invece il ruolo dell’Internazionale socialista diventava «centrale» se si voleva svolgere una funzione internazionale. Soltanto una parte del gruppo dirigente aderí a questa rappresentazione. Napolitano reclamò un «rapporto organico» con l’Internazionale socialista, che implicava un impegno piú preciso di quello indicato dal segretario e una diversa ipoteca sull’identità del nuovo partito. Piú di altri, D’Alema rilevò il rischio di un isolamento del comunismo italiano e osservò che salvaguardare la sua funzione internazionale costituiva una «grande questione italiana»56. Entrambe le questioni dovevano però restare ampiamente in secondo piano nel dibattito per molti aspetti autoreferenziale che si accese nei mesi successivi.
Pochi giorni dopo, il 29 novembre, Gorbačëv fece la sua prima visita in Italia. La statura del leader sovietico sul piano internazionale era al suo punto piú alto: la liquidazione della «dottrina Brežnev» e la scelta di evitare ogni ingerenza di Mosca nelle «rivoluzioni di velluto» costituirono il banco di prova decisivo del «nuovo modo di pensare». Secondo le annotazioni di Černjaev nel proprio diario, la visita si svolse «in un’atmosfera di inverosimile euforia di massa, ovunque Gorbačëv facesse la sua comparsa»57. Gorbačëv incontrò Andreotti e Giovanni Paolo II, che fornirono il loro pieno appoggio alla perestrojka. Il capo del governo italiano costituiva un punto di riferimento per l’idea di un ordine europeo postbipolare, da ricostruire nello spirito di Helsinki, che era auspicato anche dai comunisti italiani58. Questi avevano contribuito a preparare la visita e Rubbi aveva incontrato lo stesso Gorbačëv a Mosca, alla fine di ottobre59. Un mese dopo, il viaggio si caricava però di significati particolari quale fonte di legittimazione della «svolta». Occhetto confrontò con Gorbačëv l’opinione che fosse opportuno accelerare l’avvicinamento all’Internazionale socialista, un passo sul quale il leader sovietico non poteva non esprimere il proprio consenso60. Pochi giorni dopo Occhetto scrisse al leader sovietico una lettera per chiedere un incontro a Mosca prima del Congresso di «svolta» del Pci, fissato per il marzo 199061. Tuttavia l’incontro non ebbe luogo.
I comunisti italiani attraversarono il guado della loro trasformazione mentre la perestrojka entrava nella sua fase terminale. La decisione dei riformatori sovietici di accettare la riunificazione della Germania nella Nato, nell’estate 1990, completava il disegno di porre fine agli assetti della guerra fredda ma fu anche un indice evidente di debolezza. L’idea che l’Unione Sovietica avrebbe conservato una sua capacità di influenza nell’Europa centro-orientale anche dopo la caduta dei regimi comunisti si stava dimostrando illusoria, come attestò la disgregazione del Patto di Varsavia62. Molti osservatori, tra i quali Boffa, riscontrarono il ripiegamento del progetto riformatore a Mosca63. Contemporaneamente, la «svolta» dei comunisti italiani rivelò contrasti e fratture anche nella cultura politica. Nel luglio 1990, Occhetto fece appello a discutere non attorno a una «identità metafisica» ma al ruolo che la nuova formazione politica avrebbe dovuto assolvere, invitando tutti a vedere le trasformazioni internazionali in atto, a cominciare dalla riunificazione della Germania e dalle sue implicazioni per l’Europa. Egli invocò «il mondo dell’interdipendenza» e criticò le prospettive di un mondo unipolare, rilevando i limiti delle visioni incentrate sulla «vittoria dell’Occidente» e il rischio di sottovalutare conflitti e diseguaglianze nello spazio eurasiatico e nel Sud globale. Il suo discorso fu rivolto fondamentalmente a raffigurare la dimensione delle sfide poste dal 1989 per un «governo mondiale». La sua persuasione era che il «socialismo democratico dal volto umano» avesse ancora carte da giocare e fosse anzi «una idea e una forza ben presente e radicata in Europa e nel mondo» che poteva dare vita al disegno di un internazionalismo post-guerra fredda. Proprio questo passaggio evidenziava una forte componente di wishful thinking, dato che era difficile vedere l’effettiva consistenza delle alleanze e condivisioni immaginate, anzitutto proprio nella sinistra europea. In altre parole, si apriva uno scarto vertiginoso tra la coscienza delle sfide globali o sovranazionali e le risposte che sembrava possibile fornire, quali ad esempio la «diplomazia dei popoli», «l’Europa dei popoli», o l’appello a una «fase costituente» nella politica nazionale64.
Il 15 novembre 1990 Occhetto presentò a Gorbačëv l’esito politico della trasformazione del Pci in un «partito democratico della sinistra» dichiarando l’intento di «andare oltre le tradizioni comunista e socialdemocratica» e non di «passare dall’una all’altra». Il senso della richiesta di adesione all’Internazionale socialista non era perciò quello di «accettarne tutto», ma di «portarvi le tradizioni riformatrici dei comunisti italiani». Il sostegno di Gorbačëv fu incondizionato e basato sulla persuasione che «noi e voi percorriamo strade simili, pur nella completa autonomia e responsabilità di ognuno». I suoi riferimenti al passato si erano fatti assai piú essenziali e disincantati dopo la scelta di liquidare il monopartitismo. Il leader riformatore sovietico si disse convinto che «non è vero che gli ultimi settantatre anni sono stati inutili», ma definí il modello sovietico di socialismo come «un sistema che soffocava gli individui, un regime totalitario, un monopolio dello Stato su tutto». La sua speranza era che «forse per la prima volta riusciremo a evitare quello che è sempre accaduto in questo paese: che i tentativi di riforma finissero col portare a regimi ancora piú duri e severi»65. La sua ostinata convinzione era che la perestrojka avesse però un significato universale e che il mondo fosse «alle porte di un’epoca di grande ed effettiva civilizzazione comune»66.
In uno sguardo retrospettivo, Occhetto ha rivendicato le visioni di un «nuovo ordine mondiale» che accomunavano i comunisti italiani a Gorbačëv già prima del crollo del Muro e che rimasero una strada non presa a causa della caduta del leader sovietico67. Quella strada si sarebbe fondata su un’estensione degli accordi di Helsinki, volta a incrementare il ruolo dell’Europa e includere l’Unione Sovietica riformata in ordinamenti economici e politici cooperativi. La visione gorbaceviana di una «casa comune europea» favoriva il riconoscimento del modello di prosperità e democrazia rappresentato dalla Comunità Europea, nello stesso tempo facendo propria un’idea di Europa come civiltà e spazio culturale che non si esauriva nell’esperienza occidentale dell’integrazione e voleva essere piú inclusiva. Poteva essere una visione ingenua, persino in debito con il paneuropeismo di tradizione sovietica, ma assolveva il compito di disabilitare le strutture materiali e mentali della guerra fredda. Senza gli effetti di deterrenza prodotti dalle riforme gorbaceviane su establishment potenzialmente aggressivi, ma ormai privi di self-confidence, la guerra fredda sarebbe potuta finire in modo non pacifico. Sotto questo profilo, il comunismo riformatore fu la forza decisiva in un campo di tensioni contrastanti tra la persistenza della guerra fredda, le sirene dell’integrazione europea e i venti della globalizzazione economica68.
Il «nuovo ordine mondiale» interdipendente immaginato dai comunisti riformatori rifletteva però anche i loro limiti e contraddizioni. Il linguaggio del socialismo umanistico e la visione di un internazionalismo fondato sull’ibridazione delle culture politiche mancavano di consensi non soltanto negli establishment comunisti, compresa la Cina, ma anche nel mondo postcoloniale. Le visioni di una «casa comune europea» si scontrarono con le dure repliche della geopolitica e con la persistenza della mentalità della guerra fredda. I riformatori sovietici, e anche i comunisti italiani, sperarono vanamente in un sostegno dell’Occidente e in un Piano Marshall per l’Unione Sovietica, un’idea sostenuta in Italia da Andreotti e avversata da Craxi. Con l’unificazione della Germania nella Nato, la fine del Patto di Varsavia e la prima guerra del Golfo, tra la fine del 1990 e l’inizio del 1991, si delinearono i tasselli principali di un ordine europeo e mondiale che poteva escludere la Russia o includerla in una posizione di minorità. In questo contesto, l’efficacia delle idee-forza di Gorbačëv si logorò inesorabilmente. Il comunismo riformatore finí per esprimere molto piú una metamorfosi e un punto di arrivo della maggiore tradizione rivoluzionaria del secolo, che non un nuovo inizio.
Nelle sue memorie, Napolitano vede Gorbačëv come un ostacolo, piuttosto che come uno stimolo, per l’evoluzione del Pci verso il socialismo europeo69. In effetti, i comunisti italiani completarono il percorso d’uscita dalla propria tradizione poco prima della fine dell’Unione Sovietica ed entrarono soltanto dopo a far parte dell’Internazionale socialista. Occhetto e i dirigenti piú giovani respinsero l’opzione rappresentata dallo stesso Napolitano e dai moderati, la riunificazione del socialismo in Italia come in Europa, per fuoriuscire dalle tradizioni secolari e cercare una nuova identità. Piú che un freno, Gorbačëv rappresentò lo specchio di una cultura politica che si reinventava tenendo ferma la propria «diversità» morale e politica. La tormentata transizione al nuovo partito si risolse in un confronto di passioni ideali e tensioni esistenziali che rivelavano la rimozione dei fallimenti storici del comunismo e si appuntavano quasi esclusivamente sulla specificità nazionale. Le autorappresentazioni rivolte a esaltare la continuità e unicità dell’esperienza italiana, senza fare i conti fino in fondo con le proprie contraddizioni e con gli estremi tragici e oppressivi del comunismo al potere, presentarono le loro conseguenze. Sebbene la «svolta» implicasse la negazione di una narrazione eccezionalista, questa rimase sottotraccia ed emerse nel dibattito pubblico, integrata dalla disinvolta equiparazione tra la crisi del comunismo e quella della socialdemocrazia. In questo modo, si posero le premesse per privilegiare una ricerca identitaria distinta dalla tradizione socialista, che si doveva riflettere nel nome scelto per il nuovo partito («Partito democratico della sinistra»).
La formazione postcomunista fu paradossalmente, nello stesso tempo, un fattore del ripiegamento della società italiana in un’ottica periferica, contribuendovi con la propria narrazione eccezionalista, da una parte, e l’erede di una cultura politica che manteneva il senso degli ordinamenti internazionali quale elemento sovraordinante e interagente con la dimensione nazionale, dall’altra. L’eredità principale della cultura politica del comunismo italiano fu probabilmente la visione dell’europeismo come legame necessario alla nazione italiana. L’idea d’Europa dei comunisti non aveva mai pienamente coinciso con la Comunità Europea, mantenendo come bussola la sottrazione alla logica dei blocchi, la prospettiva di una costruzione sovranazionale progressista e l’idea di creare ponti con il mondo socialista e con il Terzo Mondo. Ciò non era cosí singolare, data la molteplicità storica dei progetti europei e i loro diversi intrecci con la realtà degli Stati-nazione70. La dimensione europea si era rivelata una sponda di legittimazione, una camera di compensazione per l’emarginazione subita sulla scena nazionale e un vettore per ricollocare la tradizione internazionalista. Alla fine prevalse l’idea dell’Europa come una “comunità di valori”, destinata a rafforzarsi dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica e la nascita dell’Unione Europea. Il sogno di un nuovo ordine mondiale si tramutò nella visione dell’Europa come “potenza civile” e come soggetto politico. Con tutte le aporie che ne dovevano nascere, il consolidamento del nesso europeo come fondamentale interesse nazionale doveva rappresentare il contributo decisivo degli ex comunisti dopo il crollo degli altri partiti di massa. In fin dei conti, i comunisti italiani avevano lungamente perseguito l’obiettivo di porre fine alla guerra fredda in Europa e in Italia, immaginando il proprio paese in diversi contesti transnazionali e globali. Il prezzo da pagare perché ciò si verificasse fu la fine della loro storia e della loro identità.
Note
Introduzione.
1. Documents and conspiratorial addresses from the archives of the Communist Party of Italy (Pci), in Nara, Crest, April 1951.
2. B. STUDER, The Transnational World of the Cominternians, Palgrave Macmillan, London 2015; S. DULLIN e B. STUDER, Communism+transnational. The rediscovered equation of internationalism in the Comintern years, in «Twentieth Century Communism», XIV (2017), pp. 66-95; J. FRIEDMAN, Shadow Cold War. The Sino-Soviet Competition for the Third World, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2015; e T. RUPPRECHT, Soviet internationalism after Stalin. Interaction and Exchange between the USSR and Latin America during the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge 2015.
3. Per esempi recenti dei nuovi approcci alla storia del comunismo in una prospettiva globale si vedano i tre volumi, sotto la direzione di S. PONS, The Cambridge History of Communism, Cambridge University Press, Cambridge 2017.
4. S. PONS, La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale (1917-1991), Einaudi, Torino 2012.
5. R. DUCOULOMBIER e J. VIGREUX (a cura di), Le Pcf, un parti global (1919-1989). Approches transnationales et comparées, Éditions universitaires de Dijon, Dijon 2019.
6. E. J. HOBSBAWM, Interesting Times. A Twentieth-Century Life (2002), Abacus, London 2003, pp. 353-54 [trad. it. Anni interessanti. Autobiografia di uno storico, Rizzoli, Milano 2002, pp. 388-89].
7. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, Q9, §127, Risorgimento, p. 1190.
8. M. MAZOWER, Governing the World. The History of an Idea, Penguin, New York 2012; G. SLUGA, Internationalism in the Age of Nationalism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2013; A. IRIYE, Cultural Internationalism and World Order, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1997; S. CONRAD e D. SACHSENMAIER (a cura di), Competing Visions of World Order. Global Moments and Movements 1880s-1930s, Palgrave Macmillan, London 2007; e T. C. IMLAY, The Practice of Socialist Internationalism. European Socialists and International Politics, 1914-1960, Oxford University Press, Oxford-New York 2018.
9. A. GIARDINA (a cura di), Storia mondiale dell’Italia, Laterza, Bari-Roma 2018; S. PATRIARCA e L. RIALL (a cura di), The Risorgimento Revisited. Nationalism and Culture in Nineteenth Century Italy, Palgrave Macmillan, London 2012; R. FORLENZA e B. THOMASSEN, Italian Modernities. Competing Narratives of Nationhood, Palgrave Macmillan, New York 2016; F. ROMERO e A. VARSORI (a cura di), Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni internazionali dell’Italia (1917-1989), 2 voll., Carocci, Roma 2005; e G. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda (1943-1978), il Mulino, Bologna 2016.
PARTE PRIMA, Genealogie: internazionalismo e cosmopolitismo (1917-1941).
Capitolo primo, Rivoluzione ed egemonia.
1. G. ELEY, Marxism and Socialist Revolution, in S. PONS e S. A. SMITH (a cura di), The Cambridge History of Communism. I. World Revolution and Socialism in One Country, Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. 49-73.
2. G. BERTI, Appunti e ricordi 1919-1926, in I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano. Documenti inediti dell’Archivio Angelo Tasca, a cura di G. Berti, Istituto Giangiacomo Feltrinelli, «Annali», VIII, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 14-17. Si veda anche F. DE FELICE, Serrati, Bordiga, Gramsci e il problema della rivoluzione in Italia 1919-1920, De Donato, Bari 1971.
3. Per una ricostruzione del pensiero di Gramsci nella fase finale della Grande guerra, si veda L. RAPONE, Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo (1914-1919), Carocci, Roma 2011. Sul tema della rivoluzione russa, cfr. anche S. PONS, Gramsci e la Rivoluzione russa: una riconsiderazione (1917-1935), in «Studi Storici», LVIII (2017), n. 4. Su Bordiga, si veda B. BONGIOVANNI, Il socialismo contro la nazione. Il caso di Amadeo Bordiga (1911-1918), in M. CATTARUZZA (a cura di), La nazione in rosso. Socialismo, Comunismo e «questione nazionale» 1889-1953, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 83-106.
4. A. GRAMSCI, La rivoluzione contro «Il Capitale», in «Il Grido del popolo», 1° dicembre 1917 (completamente censurato) e «Avanti!», ed. romana, 22 dicembre 1917, ora in ID., Scritti (1910-1926), vol. II, 1917, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2015, pp. 617-20.
5. A. B., Gli insegnamenti della nuova storia, in «Avanti!», ed. romana, 27 e 28 febbraio 1918, ora in A. BORDIGA, Scritti 1911-1926, vol. II, La guerra, la rivoluzione russa e la nuova Internazionale, Graphos, Genova 1998, pp. 419, 422.
6. A. G., Utopia, in «Avanti!», 25 luglio 1918, ora in A. GRAMSCI, Il nostro Marx 1918-1919, a cura di S. Caprioglio, Einaudi, Torino 1984, pp. 204-11.
7. [ID.], La fortuna di Robespierre, in «Il Grido del popolo», 2 marzo 1918, ora in ID., La città futura 1917-1918, a cura di S. Caprioglio, Einaudi, Torino 1982, pp. 703-5.
8. [ID.], Le opere e i giorni, in «Avanti!», 5 luglio 1918, ora in ID., Il nostro Marx cit., pp. 157-59.
9. B. SETTIS, Tra Wilson e Lenin. America e americanismo nella formazione dei comunisti italiani, 1917-1921, in P. CAPUZZO e S. PONS (a cura di), Gramsci nel movimento comunista internazionale, Carocci, Roma 2019, pp. 33-58.
10. R. GERWARTH, The Vanquished. Why the First World War Failed to End, Farrar, Straus and Giroux, New York 2016, pp. 121-22.
11. RAPONE, Cinque anni che paiono secoli cit., pp. 375-79.
12. [A. GRAMSCI], Wilson e i socialisti, in «Il Grido del popolo», 12 ottobre 1918, ora in ID., Il nostro Marx cit., pp. 313-17.
13. [A. BORDIGA], Wilson?, in «Il Soviet», 1° gennaio 1919, ora in ID., Scritti 1911-1926, vol. III, Lotte sociali e prospettive rivoluzionarie nel dopoguerra, 1918-1919, Fondazione Amadeo Bordiga, Formia 2010, pp. 37-39.
14. A. TOOZE, The Deluge. The Great War and the Remaking of Global Order, 1916-1931, Penguin, New York 2014, pp. 20, 232-34.
15. E. MANELA, The Wilsonian Moment. Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford University Press, Oxford - New York 2007.
16. [A. GRAMSCI], L’armistizio e la pace, in «Avanti!», 11 febbraio 1919, ora in ID., Il nostro Marx cit., pp. 538-41.
17. MAZOWER, Governing the World cit., p. 175.
18. [A. GRAMSCI], Uno sfacelo e una genesi, in «L’Ordine Nuovo», 1° maggio 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo 1919-1920, a cura di V. Gerratana e A. A. Santucci, Einaudi, Torino 1987, pp. 3-6.
19. [ID.], L’Italia, le alleanze e le colonie, in «Avanti!», 10 maggio 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 11-12.
20. [ID.], L’unità del mondo, in «L’Ordine Nuovo», 15 maggio 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 19-20.
21. [ID.], L’Internazionale comunista, in «L’Ordine Nuovo», 15 maggio 1919, in ID., L’Ordine Nuovo cit., p. 35; e [A. BORDIGA], La farsa di Parigi (1919), in ID., Scritti 1911-1926, vol. III cit., pp. 242-44.
22. A. G., La marea rivoluzionaria, in «L’Ordine Nuovo», 7 giugno 1919, ora in GRAMSCI, L’Ordine Nuovo cit., pp. 70-71.
23. [ID.], La Germania e la pace, in «L’Ordine Nuovo», 21 giugno 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 101-2.
24. [ID.], Per l’Internazionale comunista, in «L’Ordine Nuovo», 26 luglio 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., p. 152.
25. [ID.], La Russia e l’Europa, in «L’Ordine Nuovo», 1° novembre 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 267-71.
26. ID., I rivoluzionari e le elezioni, in «L’Ordine Nuovo», 15 novembre 1919, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 315-17; e [A. BORDIGA], I partiti della Terza Internazionale e il metodo elezionista (1919), in ID., Scritti 1911-1926, vol. III cit., pp. 376-78.
27. [A. GRAMSCI], Cercando la verità, in «L’Ordine Nuovo», 4 ottobre 1919.
28. RAPONE, Cinque anni che paiono secoli cit., p. 409.
29. [A. GRAMSCI], L’anno rivoluzionario, in «Avanti!», 1° gennaio 1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 373-75.
30. [ID.], Primo: rinnovare il partito, in «L’Ordine Nuovo», 24-31 gennaio 1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 394-98.
31. [ID.], La rivoluzione tedesca, in «L’Ordine Nuovo», 20 marzo 1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 469-71.
32. [ID.], La relazione Tasca e il Congresso camerale di Torino, in «L’Ordine Nuovo», 5 giugno 1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 538-42.
33. [ID.], Due rivoluzioni, in «L’Ordine Nuovo», 3 luglio 1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 569-74.
34. PONS, La rivoluzione globale cit., pp. 25-28.
35. [A. GRAMSCI], La Russia, potenza mondiale, in «L’Ordine Nuovo», 14 agosto 1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo cit., pp. 616-18.
36. K. H. JARAUSCH, Out of Ashes. A New History of Europe in the Twentieth Century, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2015, pp. 156 sgg.; S. COLARIZI, Novecento d’Europa. L’illusione, l’odio, la speranza, l’incertezza, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 127-31; e S. LUPO, Il fascismo. La politica di un regime totalitario, Donzelli, Roma 2000, pp. 86-98.
37. A. GRAMSCI, Contro il pessimismo, in «L’Ordine Nuovo», 15 marzo 1924, ora in ID., La costruzione del partito comunista, Einaudi, Torino 1971, pp. 16-20.
38. F. ANDREUCCI, Da Gramsci a Occhetto. Nobiltà e miseria del Pci, 1921-1991, Della Porta, Pisa 2014, pp. 58-61; e P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano, vol. I, Da Bordiga a Gramsci, Einaudi, Torino 1967, pp. 152-64.
39. M. TABER (a cura di), The Communist Movement at a Crossroads. Plenums of the Communist International’s Executive Committee, 1922-1923, Brill, Leiden 2018.
40. Sulle attività degli emissari russi in Italia prima del Congresso di Livorno, cfr. A. VENTURI, Rivoluzionari russi in Italia 1917-1921, Feltrinelli, Milano 1979; e V. LOMELLINI, La grande paura rossa. L’Italia delle spie bolsceviche (1917-1922), FrancoAngeli, Milano 2015.
41. P. TOGLIATTI, La formazione del gruppo dirigente del partito comunista italiano nel 1923-1924, Editori Riuniti, Roma 1962, p. 178.
42. Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 69, l. 20.
43. Ivi, d. 155, ll. 43, 50-55.
44. Ivi, d. 180, ll. 132-38. Sulla tensione tra centro e periferia come tratto costante del Comintern, si veda S. WOLIKOW, L’Internationale communiste (1919-1943). Le Komintern ou le rêve déchu du parti mondial de la révolution, Les Éditions de l’Atelier, Paris 2010.
45. G. SAS, Der Faschismus in Italien, C. Hoym, Hamburg 1923; e D. RENTON, Fascism. Theory and Practice, Pluto Press, London 1999, pp. 58-60. Cfr. C. NATOLI, La Terza Internazionale e il fascismo, Editori Riuniti, Roma 1982, pp. 286 sgg.
46. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione. Scritti e discorsi 1917-1964, a cura di M. Ciliberto e G. Vacca, Bompiani, Milano 2014, pp. 43-67.
47. Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 187, ll. 14-17; e ivi, d. 166, ll. 6-11.
48. Riunione della Commissione italiana del 21 giugno 1923, in FG, Pcd’I, scatola Ic 1922-1925.
49. GRAMSCI, La costruzione del partito comunista cit., pp. 456-57.
50. A. TASCA, I primi dieci anni del Pci, Laterza, Roma-Bari 1973, p. 115.
51. G. VACCA, Modernità alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci, Einaudi, Torino 2017, pp. 63-65.
52. TOGLIATTI, La formazione del gruppo dirigente cit., pp. 187-90.
53. Ibid., p. 197.
54. Ibid., p. 263.
55. [A. GRAMSCI], Capo, in «L’Ordine Nuovo», 1° marzo 1924, ora in ID., La costruzione del partito comunista cit., pp. 12-16.
56. ID., Lettere 1908-1926, a cura di A. A. Santucci, Einaudi, Torino 1992, p. 204.
57. V. SERGE, Mémoires d’un révolutionnaire de 1901 à 1941, Éditions du Seuil, Paris 1951, pp. 204-5.
58. Su Gramsci a Vienna, cfr. G. SOMAI, Gramsci a Vienna. Ricerche e documenti 1922-24, Argalia, Urbino 1979; e F. GIASI, Gramsci a Vienna. Annotazioni su quattro lettere inedite, in F. GIASI, R. GUALTIERI e S. PONS (a cura di), Pensare la politica, Carocci, Roma 2009, pp. 185-208.
59. [A. GRAMSCI], Contro il pessimismo, in «L’Ordine Nuovo», 15 marzo 1924, ora in ID., La costruzione del partito comunista cit., pp. 16-20.
60. ID., La costruzione del partito comunista cit., p. 33.
61. Il Ce [Comitato esecutivo] del Pcd’I a Zinov′ev, 15 luglio 1924, in Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 243, l. 96.
62. Lettre ouverte au Parti communiste italien, 23 luglio 1924, FG, Pcd’I, scatola Ic 1922-1925; e Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 244, ll. 6-14.
63. A. GAGLIARDI, Di fronte al fascismo. Gramsci e il dibattito nel movimento comunista internazionale, in CAPUZZO e PONS (a cura di), Gramsci nel movimento comunista internazionale cit., pp. 109-13.
64. Avprf, f. 098, op. 7, p. 107, d. 88, l. 68.
65. Moskva-Rim. Politika i diplomatija Kremlja 1920-1939, Nauka, Moskva 2002, doc. 86, pp. 216-18.
66. E. DUNDOVICH, Bandiera rossa trionferà? L’Italia, la rivoluzione d’Ottobre e i rapporti con Mosca 1917-1927, FrancoAngeli, Milano 2017, pp. 83-92; e G. PETRACCHI, La Russia rivoluzionaria nella politica italiana. Le relazioni italo-sovietiche 1917-25, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 254-57.
67. In una lettera a Zinov′ev del 25 novembre 1924, Manuiłskij rilevò la forte sensazione destata dall’intervento di Trockij tra i comunisti tedeschi, francesi e italiani, cfr. Rgaspi, f. 324, op. 1, d. 551, ll. 87-89.
68. H. WEBER, Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik, Europäische Verlagsanstalt cop., Frankfurt a.M. 1969 [trad. it. La trasformazione del comunismo tedesco. La stalinizzazione della Kpd nella Repubblica di Weimar, Feltrinelli, Milano 1979, p. 102].
69. GRAMSCI, La costruzione del partito comunista cit., pp. 473-74.
70. A. DI BIAGIO, Coesistenza e isolazionismo. Mosca, il Comintern e l’Europa di Versailles (1918-1928), Carocci, Roma 2004, p. 201.
71. Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 285, ll. 31-35.
72. GRAMSCI, La costruzione del partito comunista cit., p. 63.
73. Ibid., pp. 302-3.
74. F. GIASI, La bolscevizzazione tradotta in «linguaggio storico italiano», in CAPUZZO e PONS (a cura di), Gramsci nel movimento comunista internazionale cit., pp. 157-84.
75. P. CAPUZZO, La questione agraria e contadina, ibid., pp. 81-102.
76. Avprf, F. 098, op. 20, p. 159, d. 51329, ll. 31-32.
77. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca, a cura di C. Daniele, Einaudi, Torino 1999, doc. 1, pp. 165, 168-70.
78. Verbale della riunione della delegazione italiana, 23 febbraio 1926, in Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 372, l. 11.
79. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca cit., doc. 18, pp. 296-97.
80. Ibid., doc. 24, pp. 317-18.
81. Ibid., doc. 25, pp. 326-27.
82. P. TOGLIATTI, Opere, vol. II, 1926-1929, a cura di E. Ragionieri, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 47-54.
83. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca cit., doc. 32, pp. 357-65.
84. GRAMSCI, La costruzione del partito comunista cit., pp. 113-24.
85. I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano cit., pp. 296-99.
86. PONS, La rivoluzione globale cit., pp. 75 sgg.
87. DI BIAGIO, Coesistenza e isolazionismo cit., pp. 209-12.
88. TOOZE, The Deluge cit., pp. 472-76.
89. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca cit., doc. 35, p. 376.
90. Ibid., doc. 37, p. 380.
91. [A. GRAMSCI], L’Urss verso il comunismo, in «l’Unità», 7 settembre 1926, ora in ID., La costruzione del partito comunista cit., pp. 315-19; e L. PAGGI, Le strategie del potere in Gramsci, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 353-54.
92. Per una ricostruzione circostanziata, cfr. S. PONS, Gramsci e il “testamento” di Lenin, in G. FRANCIONI e F. GIASI (a cura di), Un nuovo Gramsci. Biografia, temi, interpretazioni, Viella, Roma 2019, pp. 95-111.
93. M. EASTMAN, Since Lenin Died, The Labour Publishing Company Limited, London 1925.
94. Rgaspi, f. 17, op. 2, d. 246; e S. KOTKIN, Stalin, vol. I, Paradoxes of Power 1878-1928, Penguin, New York 2014, p. 607.
95. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca cit., doc. 38, p. 392.
96. M. EASTMAN, Lenin’s “Testament” at Last Revealed, in «The New York Times», 18 ottobre 1926.
97. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca cit., doc. 42, pp. 404-12.
98. Rgaspi, f. 558, op. 11, d. 753, l. 104 r/v.
99. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca cit., doc. 40, pp. 400-1.
100. Ibid., doc. 42, p. 408.
101. Ibid., doc. 45, pp. 420-21, 425.
102. «Corriere della Sera», 19 ottobre 1926.
103. Gramsci a Roma, Togliatti a Mosca, doc. 46, pp. 426-27.
104. Ibid., doc. 47, pp. 428-33.
105. Ibid., doc. 49, pp. 435-39.
106. G. VACCA, Introduzione, ibid. pp. 138-39.
107. KOTKIN, Stalin, vol. I cit., pp. 389-90.
Capitolo secondo, Stalinismo e antifascismo.
1. E. RAGIONIERI, Palmiro Togliatti. Per una biografia politica e intellettuale, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 205-10.
2. P. TOGLIATTI, Le basi sociali del fascismo (1926), in Id., Opere, vol. II cit., pp. 28-38.
3. Ibid., pp. 102, 108-9.
4. ID., Direttiva per lo studio delle questioni russe (1927), ibid., pp. 187-89.
5. ID., L’Italia fascista, focolaio di guerra (1927), ibid., pp. 142-47.
6. A. DI BIAGIO, Togliatti e la lotta per la pace, in R. GUALTIERI, C. SPAGNOLO e E. TAVIANI (a cura di), Togliatti nel suo tempo, Fondazione Istituto Gramsci, «Annali», XV, Carocci, Roma 2007, p. 112.
7. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 155-65.
8. Politbjuro CK Rkp(b) - Vkp(b) i Komintern 1919-1943. Dokumenty, a cura di G. M. Adibekov et al., Rosspen, Moskva 2004, doc. 253, pp. 417-22.
9. PONS, La rivoluzione globale cit., pp. 78-80.
10. Rgaspi, f. 495, op. 166, d. 29, l. 12; e Togliatti negli anni del Comintern (1926-1943). Documenti inediti dagli archivi russi, a cura di A. Agosti, Fondazione Istituto Gramsci, «Annali», X (1998), Carocci, Roma 2000, doc. 5.
11. A. DI BIAGIO, Moscow, the Comintern and the War Scare, in S. PONS e A. ROMANO (a cura di), Russia in the Age of Wars 1914-1945, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, «Annali», XXXIV (1998), Feltrinelli, Milan 2000, pp. 94-97.
12. IMLAY, The Practice of Socialist Internationalism cit., pp. 160-64.
13. IRIYE, Cultural Internationalism and World Order cit., p. 88.
14. DI BIAGIO, Coesistenza e isolazionismo cit., pp. 233 sgg.
15. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 299-303, 322.
16. A. GAGLIARDI, Fascismo, socialismo, capitalismo. Angelo Tasca tra analisi economica e cultura politica, in D. BIDUSSA e G. VACCA (a cura di), Il fascismo in tempo reale. Studi e ricerche di Angelo Tasca sulla genesi e l’evoluzione del fascismo in Europa, 1926-1938, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, «Annali», XLVIII (2012), Feltrinelli, Milano 2014, pp. 3-18.
17. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 427-29.
18. KOTKIN, Stalin, vol. I cit., pp. 550-51.
19. G. VACCA, Introduzione, in P. TOGLIATTI, Sul fascismo, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. XLII-LII.
20. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 551-54.
21. Rgaspi, f. 495, op. 29, d. 23. Cfr. Rossijskaja revoljucija, Komintern i Latinskaja Amerika, Rosspen, Moskva 2019, pp. 329-30.
22. Il Congresso antimperialista di Bruxelles, in «Lo Stato Operaio», I (1927), n. 1.
23. Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 644.
24. RAGIONIERI, Palmiro Togliatti cit., p. 360.
25. IMLAY, The Practice of Socialist Internationalism cit., pp. 202-3. Si veda anche M. GOEBEL, Anti-Imperial Metropolis. Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism, Cambridge University Press, Cambridge 2015.
26. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 472-505.
27. S. DATTA GUPTA, Communism and the Crisis of the Colonial System, in PONS e SMITH (a cura di), The Cambridge History of Communism. I. World Revolution cit., pp. 220-21.
28. TASCA, I primi dieci anni del PCI cit., p. 162.
29. I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano cit., 1928, docc. 16, 21 e 22, specie le pp. 576, 583.
30. Ibid., doc. 23, pp. 588-93.
31. «Pravyj uklon» v KPG i stalinizacija Kominterna. Stenogramma zasedanija Prezidiuma Ikki po germanskomu voprosu 19 dekabrja 1928g., a cura di A. Ju. Vatlin e Ju. T. Tutočkin, Airo-XX, Moskva 1996; e J. HUMBERT-DROZ, De Lénine a Stáline. Dix ans au service de l’Internationale Communiste 1921-1931, Editions de la Baconnière, Neuchâtel 1971, p. 341.
32. I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano cit., 1928, doc. 29, p. 617.
33. Rgaspi, f. 558, op. 11, d. 763, ll. 50-52, 54-56.
34. I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano cit., 1929, doc. 12, p. 670.
35. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 672-73.
36. I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano cit., 1928, doc. 23, p. 592.
37. RAGIONIERI, Palmiro Togliatti cit., p. 389.
38. Rgaspi, f. 558, op. 1, d. 2886.
39. TOGLIATTI, Opere, vol. II cit., pp. 739, 741, 743.
40. Ibid., pp. 796-97. Cfr. RAGIONIERI, Palmiro Togliatti cit., pp. 394-404.
41. Fondazione Feltrinelli, Fondo Tasca, Pci-Psi, faldone 1, 1929 I, 12 luglio 1929.
42. A. AGOSTI, Palmiro Togliatti, Utet, Torino 1996, p. 128.
43. HOBSBAWM, Anni interessanti cit., p. 159. Si veda M. NEUMANN, Communism, Youth and Generation, in PONS e SMITH (a cura di), The Cambridge History of Communism. I. World Revolution cit., pp. 484-87.
44. A. HÖBEL, Luigi Longo, una vita partigiana (1900-1945), Carocci, Roma 2013, pp. 132-47; e M. ALBELTARO, Le rivoluzioni non cadono dal cielo. Pietro Secchia, una vita di parte, Laterza, Bari-Roma 2014, pp. 45-54.
45. Si veda P. CAPUZZO, Identità e storia. La lunga ombra di Togliatti, in ID. (a cura di), Il Pci davanti alla sua storia. Dal massimo consenso all’inizio del declino. Bologna 1976, Viella, Roma 2019, pp. 122-28.
46. ANDREUCCI, Da Gramsci a Occhetto cit., pp. 115-24.
47. U. TERRACINI, Sulla svolta, La Pietra, Milano 1965, pp. 26-27, 38.
48. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 1826/1, ll. 52-56.
49. G. VACCA, Vita e pensieri di Gramsci, Einaudi, Torino 2012, pp. 115, 119-26.
50. Rgaspi, f. 82, op. 2, l. 99 (15 maggio 1931).
51. E. H. CARR, The Twilight of Comintern, Macmillan, London 1982, pp. 42-43, 246-47; e P. TOGLIATTI, La politica del partito comunista tedesco (1931), in ID., Opere, vol. III, 1929-1935, Editori Riuniti, Roma 1973, t. I, pp. 404-9.
52. P. TOGLIATTI, Opere, vol III cit., t. II, pp. 104-28.
53. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 1/1, ll. 322-26.
54. Ivi, d. 33/1.
55. M. BOARELLI, La fabbrica del passato. Autobiografie di militanti comunisti (1945-1956), Feltrinelli, Milano 2007, pp. 63-85; e B. STUDER, Communism as Existential Choice, in PONS e SMITH (a cura di), The Cambridge History of Communism. I. World Revolution cit., pp. 503-25.
56. T. NOCE, Rivoluzionaria professionale, La Pietra, Milano 1974, pp. 122-23.
57. G. AMENDOLA, Una scelta di vita, Rizzoli, Milano 1976, pp. 255-57. Cfr. G. CERCHIA, Giorgio Amendola. Un comunista nazionale. Dall’infanzia alla guerra partigiana (1907-1945), Rubbettino, Soveria Mannelli 2004.
58. S. KOTKIN, Stalin, vol. II, Waiting for Hitler, 1929-1941, Penguin, New York 2017, pp. 352-54.
59. Sulla fede politica tra le élite sovietiche, si veda Y. SLEZKINE, The House of Government. A saga of the Russian Revolution, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2017.
60. PONS, Gramsci e la Rivoluzione russa cit.
61. RAGIONIERI, Palmiro Togliatti cit., p. 444.
62. CARR, The Twilight of Comintern cit., p. 389.
63. P. TOGLIATTI, Sulla situazione tedesca (1933), in ID., Opere, vol. III cit., t. II, p. 177.
64. ID., La marcia del fascismo in Francia (1934), ibid., pp. 370-71.
65. G. DIMITROV, Diario. Gli anni di Mosca (1934-1945), a cura di S. Pons, Einaudi, Torino 2002, pp. 11-14.
66. Ibid., p. 26; e Politbjuro CK Rkp(b) - Vkp(b) i Komintern 1919-1943. Dokumenty, doc. 438, pp. 701-3.
67. Togliatti negli anni del Comintern cit., p. 108.
68. AGOSTI, Palmiro Togliatti cit., pp. 180 sgg.; e WOLIKOW, L’Internationale communiste cit., pp. 89-91.
69. STUDER, The Transnational World of the Cominternians cit., pp. 104-7.
70. BIDUSSA e VACCA (a cura di), Il fascismo in tempo reale cit., pp. 424-34, 435-39, 469-72.
71. GAGLIARDI, Di fronte al fascismo cit., pp. 122 sgg.
72. VACCA, Introduzione, in TOGLIATTI, Sul fascismo cit., pp. LXXXIX sgg.
73. P. TOGLIATTI, Corso sugli avversari. Le lezioni sul fascismo, a cura di F. M. Biscione, Einaudi, Torino 2010, pp. 72-74.
74. Si veda il giudizio di Giuliano Procacci citato da F. M. BISCIONE, Togliatti, il fascismo, la guerra civile europea, ibid., p. 323.
75. Si vedano le considerazioni sulle «dittature dinamiche» di I. KERSHAW, To Hell and Back. Europe 1914-1949, Penguin, London 2015, pp. 290-93 [trad. it. All’inferno e ritorno. Europa 1914-1949, Laterza, Roma-Bari 2016, pp. 303 sgg.]. Sul dispotismo dello Stato staliniano e gli aspetti regressivi della modernizzazione sovietica dei primi anni Trenta, cfr. A. GRAZIOSI, L’URSS di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945, il Mulino, Bologna 2007, pp. 363 sgg.
76. TOGLIATTI, Corso sugli avversari cit., pp. 179-84.
77. Sulla nozione di «rivoluzione passiva» e il suo nesso con la politica internazionale nei Quaderni del carcere di Gramsci, si veda VACCA, Modernità alternative cit., pp. 135-49.
78. Tra i molti esempi che si potrebbero fare, si veda P. SPRIANO, Il compagno Ercoli. Togliatti segretario dell’Internazionale, Editori Riuniti, Roma 1980.
79. U. TERRACINI, Al bando del partito. Carteggio clandestino dall’Isola e dall’esilio 1938-45, La Pietra, Milano 1976, pp. 13-36.
80. Posetiteli kremlevskogo kabineta I. V. Stalina, in «Istoričeskij Archiv», 1998, n. 4, p. 199; e Pis′ma I. V. Stalina V. M. Molotovu 1925-1936gg. Sbornik dokumentov, Rossija Molodaja, Moskva 1995, p. 252.
81. Dimitrov and Stalin, 1934-1943. Letters from the Soviet Archives, a cura di A. Dallin e F. I. Firsov, Yale University Press, New Haven - London 2000, doc. 1, pp. 13-14.
82. F. DE FELICE, Fascismo, democrazia, fronte popolare. Il movimento comunista alla svolta del VII Congresso dell’Internazionale, De Donato, Bari 1973, p. 21.
83. P. TOGLIATTI, La preparazione di una nuova guerra mondiale da parte degli imperialisti e i compiti dell’Internazionale comunista (1935), in ID., Opere, vol. III cit., t. II, pp. 732-39. Cfr. G. SAPELLI, L’analisi economica dei comunisti italiani durante il fascismo, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 71-72.
84. TOGLIATTI, Opere, vol. III cit., t. II, pp. 799, 812-14.
85. S. PONS, Stalin e la guerra inevitabile (1936-1941), Einaudi, Torino 1995.
86. Rgaspi, f. 558, op. 11, d. 89, l. 1.
87. G. PROCACCI, Il socialismo internazionale e la guerra d’Etiopia, Editori Riuniti, Roma 1978.
88. R. GRIECO, I compiti del popolo italiano nella lotta contro la guerra, in «Lo Stato Operaio», IX (1935), n. 10.
89. P. TOGLIATTI, Opere, vol. IV, 1935-1944, a cura di F. Andreucci e P. Spriano, Editori Riuniti, Roma 1979, t. I, pp. 23-28, 33-35.
90. G. CANDREVA, Nazionalismo e comunismo di fronte alla guerra d’Etiopia, in «História. Debates e Tendências», XIII (2013), n. 1, pp. 150-66; e A. MATTONE, Velio Spano. Vita di un rivoluzionario di professione, Della Torre, Cagliari 1978.
91. Rgaspi, f. 527, op. 1, d. 14, ll. 1-58, specie ll. 42, 44, 56-57.
92. G. PROCACCI, Dalla parte dell’Etiopia, Feltrinelli, Milano 1984; e N. SRIVASTAVA, Italian Colonialism and Resistances to Empire, 1930-1970, Palgrave Macmillan, London 2018.
93. L. P. D’ALESSANDRO, «Per la salvezza dell’Italia». I comunisti italiani, il problema del fronte popolare e l’appello ai «fratelli in camicia nera», in «Studi Storici», LIV (2013), n. 4, pp. 951-88.
94. STUDER, The Transnational World of the Cominternians cit., pp. 128-35.
95. AGOSTI, Palmiro Togliatti cit., pp. 197-98.
96. Rgaspi, f. 531, op. 1, d. 72, ll. 21-32.
97. Ivi, f. 495, op. 73, d. 12, l. 63. Per una ricostruzione del dibattito del marzo-aprile 1936 nel Comintern, si veda PONS, Stalin e la guerra inevitabile cit., pp. 39-60.
98. Rgaspi, f. 495, op. 2, d. 222, ll. 20-24.
99. Dimitrov and Stalin cit., doc. 8.
100. P. TOGLIATTI, Sulle particolarità della rivoluzione spagnola (1936), in ID., Opere, vol. IV cit., t. I, pp. 139-54.
101. E. J. HOBSBAWM, Gli intellettuali e l’antifascismo, in Storia del marxismo, vol. III, Il marxismo nell’età della Terza Internazionale, t. II, Dalla crisi del ’29 al XX Congresso, Einaudi, Torino 1981, p. 485.
102. G. PROCACCI, La «lotta per la pace» nel socialismo internazionale, in Storia del marxismo, vol. III cit., pp. 578 sgg. Si veda anche WOLIKOW, L’Internationale communiste cit., pp. 193-95.
103. L. A. KIRSCHENBAUM, International Communism and the Spanish Civil War. Solidarity and Suspicion, Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 111-12.
104. L. P. D’ALESSANDRO, Guadalajara 1937. I volontari italiani fascisti e antifascisti nella guerra di Spagna, Carocci, Roma 2017.
105. DIMITROV, Diario cit., pp. 71-72.
106. F. I. FIRSOV, H. KLEHR e J. E. HAYNES, Secret cables of the Comintern 1933-1943, Yale University Press, New Haven - London 2014, pp. 72-74.
107. P. KARLSEN, Vittorio Vidali. Vita di uno stalinista (1916-56), il Mulino, Bologna 2019, pp. 173-98.
108. HÖBEL, Luigi Longo, una vita partigiana cit., pp. 237 sgg.
109. FG, Apci, Manoscritti di Togliatti durante la sua permanenza in Spagna, b. 2010/4. Si veda il giudizio di G. RANZATO, L’eclissi della democrazia. La guerra civile spagnola e le sue origini, Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 579.
110. R. RADOSH, M. R. HABECK e G. SEVOSTIANOV (a cura di), Spain Betrayed. The Soviet Union in the Spanish Civil War, Yale University Press, New Haven 2001.
111. PONS, Stalin e la guerra inevitabile cit., pp. 92-93.
112. W. J. CHASE, Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934-1939, Yale University Press, New Haven - London 2001.
113. KARLSEN, Vittorio Vidali cit., p. 199.
114. A. ELORZA e M. BIZCARRONDO, Queridos camaradas. La Internacional comunista y España, 1919-1939, Planeta, Barcelona 1999, specie le pp. 398 sgg.
115. DIMITROV, Diario cit., p. 87 (17 febbraio 1938); e FIRSOV, KLEHR e HAYNES, Secret cables of the Comintern cit., pp. 78-79.
116. DIMITROV, Diario cit., p. 91 (27 agosto 1938).
117. Rgaspi, f. 495, op. 74, d. 250.
118. Ivi, op. 10a, d. 182.
119. E. DUNDOVICH, F. GORI e E. GUERCETTI, Italian Emigration in the USSR. History of a Repression, in IDD. (a cura di), Reflections on the Gulag. With a Documentary Appendix on the Italian Victims of Repression in the Ussr, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, «Annali», XXXVII (2001), Feltrinelli, Milan 2003, pp. 139-86; ed E. DUNDOVICH, Tra esilio e castigo. La repressione degli antifascisti italiani in URSS (1936-1938), Carocci, Roma 1998. Sulle origini della comunità italiana in Unione Sovietica, si veda F. LUSSANA, In Russia prima del Gulag. Emigrati italiani a scuola di comunismo, Carocci, Roma 2007.
120. Rgaspi, f. 495, op. 10a, d. 182.
121. P. TOGLIATTI, Antonio Gramsci, capo della classe operaia italiana (1937), in ID., Opere, vol. IV cit., t. I, pp. 199-231.
122. Rgaspi, f. 495, op. 74, d. 250, ll. 130-40.
123. Verbale della segreteria, 16 settembre 1938, ivi, f. 513, op. 1, d. 1494.
124. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., p. 444.
125. Rgaspi, f. 513, op. 1, d. 1494.
126. Ivi, f. 495, op. 74, d. 254, l. 35.
127. DIMITROV, Diario cit., pp. 128-29 (17 ottobre 1938).
128. Ibid., pp. 134-36.
129. FIRSOV, KLEHR e HAYNES, Secret cables of the Comintern cit., pp. 82-83; e TOGLIATTI, Opere, vol. IV cit., t. I cit., pp. 325-32. Sulla vicenda conclusiva della guerra civile in Spagna e il ruolo di Togliatti, cfr. RANZATO, L’eclissi della democrazia cit., pp. 647 sgg.
130. DIMITROV, Diario cit., pp. 166-67.
131. Rgaspi, f. 495, op. 10a, d. 409a, ll. 49-50.
132. Si veda DUNDOVICH, GORI e GUERCETTI (a cura di), Reflections on the Gulag cit., Appendice, pp. 528-52. Cfr. P. ROBOTTI, Scelto dalla vita, Napoleone, Roma 1980.
133. S. PONS, L’«affare Gramsci-Togliatti» a Mosca (1938-1941), in «Studi Storici», XLV (2004), n. 1, pp. 83-117.
134. DIMITROV, Diario cit., pp. 194-95.
135. C. NEGARVILLE, Clandestino a Parigi. Diario di un comunista italiano nella Francia in guerra (1940-1943), a cura e con un’introduzione di A. Agosti, Donzelli, Roma 2020, p. 123.
136. G. AMENDOLA, Intervista sull’antifascismo, Laterza, Bari-Roma 1976, p. 157.
137. TERRACINI, Al bando del partito cit., pp. 49-50.
138. U. TERRACINI, Intervista sul comunismo difficile, a cura di A. Gismondi, Laterza, Bari-Roma 1978, pp. 123-24; e C. RAVERA, Diario di trent’anni 1913-1943, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 637. Cfr. S. BERTELLI, Il gruppo. La formazione del gruppo dirigente del PCI 1936-1948, Rizzoli, Milano 1980, pp. 90-92; P. SPRIANO, I comunisti europei e Stalin, Einaudi, Torino 1983, p. 103; e HÖBEL, Luigi Longo, una vita partigiana cit., pp. 296-97.
139. AGOSTI, Palmiro Togliatti cit., p. 254.
140. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 2, l. 73.
141. E. FISCHER, Erinnerungen und Reflexionen, Rowohlt, Hamburg 1969, pp. 423-24 [trad. it. Ricordi e riflessioni, Editori Riuniti, Roma 1973, pp. 510-11].
142. PONS, L’«affare Gramsci-Togliatti» a Mosca cit.
143. Rgaspi, f. 495, op. 74, d. 253, l. 53.
144. P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano, vol. IV, La fine del fascismo. Dalla riscossa operaia alla lotta armata, Einaudi, Torino 1973, p. 30.
145. DIMITROV, Diario cit., pp. 243 (16 novembre 1940), 271 (11 febbraio 1941).
146. Ibid., pp. 302-3 (20 e 21 aprile 1941).
147. M. LAZAR, The French Communist Party, in N. NAIMARK, S. PONS e S. QUINN-JUDGE (a cura di), The Cambridge History of Communism. II. The Socialist Camp and World Power 1941-1960s, Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. 631-32.
148. DIMITROV, Diario, p. 321 (23 giugno 1941).
149. Ibid., pp. 330 (12 luglio 1941), 333 (19 luglio 1941).
150. A. ROASIO, Figlio della classe operaia, Vangelista, Milano 1977, p. 173.
151. NEGARVILLE, Clandestino a Parigi cit.
152. Rgaspi, f. 519, op. 1, d. 114, ll. 9-10.
PARTE SECONDA, Influenze: internazionalismo e nazione (1943-1964).
Capitolo terzo, «Partito nuovo» e guerra fredda.
1. PONS, La rivoluzione globale cit., pp. 150-52. Cfr. DIMITROV, Diario cit., p. 618.
2. Per una ricostruzione delle vicende di Togliatti tra il 1941 e il 1943 si veda G. FIOCCO, Togliatti, il realismo della politica, Carocci, Roma 2018, pp. 159-64. Per un’analisi circostanziata della questione dei prigionieri di guerra, cfr. M. T. GIUSTI, I prigionieri italiani in Russia, il Mulino, Bologna 2014.
3. C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 26.
4. R. FORLENZA, On the Edge of Democracy. Italy, 1943-48, Oxford University Press, Oxford-New York 2019; E. AGA ROSSI, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, il Mulino, Bologna 2003; e M. FIORAVANZO e C. FUMIAN (a cura di), 1943. Strategie militari, collaborazionismi, Resistenze, Viella, Roma 2015.
5. Dagli archivi di Mosca. L’URSS, il Cominform e il PCI, a cura di F. Gori e S. Pons, Fondazione Istituto Gramsci, «Annali», VII (1995), Carocci, Roma 1998, docc. 1 e 2, pp. 223-25.
6. Ibid., doc. 4, pp. 227-29.
7. Avprf, f. 07. op. 4, p. 30, d. 37, ll. 12-16.
8. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 6, p. 231.
9. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 1, č. 1, l. 256.
10. TERRACINI, Intervista sul comunismo difficile cit., p. 148; e BERTELLI, Il gruppo cit., p. 215.
11. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 2, ll. 47-48ob.
12. HÖBEL, Luigi Longo, una vita partigiana cit., pp. 303-21; e ALBELTARO, Le rivoluzioni non cadono dal cielo cit., pp. 93, 110-11.
13. P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano, vol. V, La Resistenza, Togliatti e il partito nuovo, Einaudi, Torino 1975, pp. 110 sgg.; e G. AMENDOLA, Lettere a Milano 1939-1945, Editori Riuniti, Roma 1974.
14. A. J. RIEBER, Anti-Fascist Resistance Movements in Europe and Asia, in NAIMARK, PONS e QUINN-JUDGE (a cura di), The Cambridge History of Communism. II. The Socialist Camp cit., pp. 38-46.
15. Avprf, f. 07. op. 5, p. 53, d. 230a, ll. 1-2.
16. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 8, p. 233; e DIMITROV, Diario cit., p. 681.
17. Rgaspi, f. 82, d. 1231, ll. 1-2.
18. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 9, pp. 234-38; e DIMITROV, Diario cit., p. 689.
19. Per la tesi dell’influenza giocata sin dal dicembre 1943 dalla diplomazia italiana su Vyšinskij in favore dell’accordo tra Unione Sovietica e Italia concluso nel marzo 1944, si vedano E. DI NOLFO e M. SERRA, La gabbia infranta. Gli Alleati e l’Italia dal 1943 al 1945, Laterza, Bari-Roma 2010; e M. CLEMENTI, L’alleato Stalin. L’ombra sovietica sull’Italia di Togliatti e De Gasperi, Rizzoli, Milano 2011.
20. Rgaspi, f. 495, op. 74, d. 259, l. 7.
21. DIMITROV, Diario cit., pp. 691-93; e Rgaspi, f. 495, op. 74, d. 259, l. 8.
22. Per una ricostruzione dell’intera vicenda basata sugli archivi sovietici, si veda S. PONS, L’impossibile egemonia. L’URSS, il PCI e le origini della guerra fredda (1943-1948), Carocci, Roma 1999, cap. III. Cfr. anche ID., Togliatti e Stalin, in GUALTIERI, SPAGNOLO e TAVIANI (a cura di), Togliatti nel suo tempo cit., pp. 195-214.
23. Per questa interpretazione, si veda E. AGA ROSSI e V. ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca, il Mulino, Bologna 1997. Cfr. anche E. AGA ROSSI, L’Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda, il Mulino, Bologna 2019, pp. 325 sgg.
24. B. CROCE, Taccuini di guerra 1943-1945, a cura di C. Cassani, Adelphi, Milano 2004, p. 109.
25. Rgaspi, f. 495, op. 10a, d. 433b, ll. 143-46.
26. Avprf, f. 098, op. 27, p. 159, d. 11, ll. 103-8.
27. E. COLLOTTI, Introduzione, in Archivio Pietro Secchia 1945-1973, a cura di E. Collotti, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, «Annali», XIX (1978), Feltrinelli, Milano 1979, p. 74.
28. Rgaspi, f. 558, op. 11, d. 283, ll. 12-13.
29. E. KARDELJ, Memorie degli anni di ferro, Editori Riuniti, Roma 1980, pp. 39-40.
30. PONS, L’impossibile egemonia cit., pp. 73, 77-78.
31. FG, Apci, Direzione, Verbali, 16-18 dicembre 1944. Si veda R. GUALTIERI, Togliatti e la politica estera italiana. Dalla Resistenza al Trattato di pace 1943-1947, Editori Riuniti, Roma 1995, pp. 50 sgg.
32. IRIYE, Cultural Internationalism and World Order cit., pp. 138-39; e G. SLUGA, Internationalism in the Age of Nationalism cit., pp. 81 sgg.
33. DIMITROV, Diario cit., p. 696.
34. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., pp. 567, 574-75, 578 (11 aprile 1944).
35. DIMITROV, Diario cit., pp. 725-26.
36. D. FORGACS e S. GUNDLE, Mass Culture and Italian Society from Fascism to the Cold War, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 2007, p. 260.
37. M. TAMBOR, The Lost Wave. Women and Democracy in Postwar Italy, Oxford University Press, Oxford 2014.
38. G. PAJETTA, Il ragazzo rosso, Mondadori, Milano 1983.
39. Rgaspi, f. 17, op. 128, d. 799, l. 282.
40. Avprf, f. 098, op. 27, p. 159, d. 9, l. 3.
41. Ivi, f. 06, op. 7, p. 34, d. 480, l. 69.
42. Sui comunisti italiani e la questione di Trieste, si veda la sintesi di FIOCCO, Togliatti, il realismo della politica cit., pp. 195-201. Piú dettagliatamente, L. GIBIANSKIJ, Mosca, il PCI e la questione di Trieste, in Dagli archivi di Mosca cit., pp. 85-133.
43. Avprf, f. 098, op. 26, p. 152, d. 8, ll. 266-67.
44. Ivi, l. 370.
45. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 272, 13 maggio 1945.
46. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 11, pp. 240-41.
47. DIMITROV, Diario cit., p. 838.
48. Avprf, f. 098, op. 26, p. 152, d. 8, l. 403.
49. Intervento alla Direzione, 5 agosto 1945, p. 22, in FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte Ferri Amadesi, 1945, Discorsi.
50. Dagli archivi di Mosca cit., docc. 12, 13 e 14, specie le pp. 256, 260-61, 264.
51. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., p. 679.
52. A. BROGI, Confronting America. The Cold War Between the United States and the Communists in France and Italy, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2011, pp. 38-39.
53. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda (1943-1978) cit., p. 59.
54. P. TOGLIATTI, La guerra di posizione in Italia. Epistolario 1944-1964, a cura di G. Fiocco e M. L. Righi, Einaudi, Torino 2014, doc. 22, pp. 76-78.
55. FORLENZA, On the Edge of Democracy cit., p. 59.
56. G. CERCHIA, Giorgio Amendola. Gli anni della Repubblica (1945-1980), Cerabona, Torino 2009, pp. 86-90.
57. La politica del Partito comunista italiano nel periodo costituente. I verbali della Direzione tra il V e il VI Congresso 1946-1948, a cura di R. Martinelli e M. L. Righi, Fondazione Istituto Gramsci, «Annali», II (1990), Editori Riuniti, Roma 1992, p. 573.
58. «Cold War International History Project Bullettin», X (1998), pp. 113-15, 127, 135; e V. A. NEVEŽIN, Zastol′nye reči Stalina, Airo-XX, Moskva - St Petersburg 2003, p. 484.
59. Avprf, f. 098, op. 29, p. 165, d. 10, l. 126.
60. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 222, pacco II, 29 giugno 1946.
61. Ivi, Palmiro Togliatti, Carte della scrivania, 19 giugno 1946.
62. PONS, L’impossibile egemonia cit., pp. 173-74.
63. Sulla nozione della «democrazia popolare» e i suoi limiti, cfr. N. NAIMARK, Stalin e la lotta degli europei per la sovranità, in S. PONS (a cura di), Globalizzazioni rosse. Studi sul comunismo nel mondo del Novecento, Carocci, Roma 2020, pp. 91-108. Si veda anche F. BETTANIN, Stalin e l’Europa. La formazione dell’impero esterno sovietico (1941-1953), Carocci, Roma 2006, pp. 169-81.
64. FG, Apci, Comitato Centrale, Verbali, 18 settembre 1946.
65. DIMITROV, Diario cit., p. 802.
66. PONS, L’impossibile egemonia cit., p. 89.
67. D. SASSOON, Togliatti e il partito di massa. Il PCI dal 1944 al 1964, Castelvecchi, Roma 2014.
68. G. VACCA, Togliatti e la storia d’Italia, in GUALTIERI, SPAGNOLO e TAVIANI (a cura di), Togliatti nel suo tempo cit., pp. 3-21; ed E. GENTILE, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel Ventesimo secolo, Mondadori, Milano 1997, pp. 328-35.
69. PAVONE, Una guerra civile cit., pp. 179-80; R. FORLENZA e B. THOMASSEN, Italian Modernities. Competing Narratives of Nationhood, Palgrave, New York 2016, pp. 193-201; e R. COLOZZA, Repubbliche comuniste. I simboli nazionali del Pci e del Pcf (1944-1953), Clueb, Bologna 2009. Sulle implicazioni piú generali nella storia della Repubblica, si veda F. FOCARDI, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Laterza, Bari-Roma 2005; e P. CRAVERI e G. QUAGLIARIELLO (a cura di), La Seconda guerra mondiale e la sua memoria, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
70. ANDREUCCI, Da Gramsci a Occhetto cit., pp. 254 sgg.; e M. DEGL’INNOCENTI, Il mito di Stalin. Comunisti e socialisti nell’Italia del dopoguerra, Lacaita, Manduria 2005.
71. G. FORMIGONI, La Democrazia cristiana e l’Alleanza occidentale (1943-1953), il Mulino, Bologna 1996, p. 48.
72. A. J. MCADAMS, Vanguard of the Revolution. The Global Idea of the Communist Party, Princeton University Press, Princeton 2017, pp. 245-58.
73. F. ROMERO e A. VARSORI (a cura di), Nazione, interdipendenza, integrazione. Le relazioni internazionali dell’Italia (1917-1989), 2 voll., Carocci, Roma 2005.
74. Si vedano, ad esempio, E. GALLI DELLA LOGGIA, Credere tradire vivere. Un viaggio negli anni della Repubblica, il Mulino, Bologna 2016; e G. CRAINZ, Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale, Donzelli, Roma 2009.
75. T. JUDT, Postwar. A History of Europe Since 1945, Penguin, London 2005, pp. 63-67 [trad. it. Dopoguerra. Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, Mondadori, Milano 2007, pp. 82-88]; KERSHAW, To Hell and Back cit., pp. 488-89 [trad. it. All’inferno e ritorno cit., pp. 561-63]; e JARAUSCH, Out of the Ashes cit., pp. 411-12.
76. GUALTIERI, Togliatti e la politica estera italiana cit., pp. 198-201.
77. La politica del Partito comunista italiano nel periodo costituente cit., p. 465.
78. Rgaspi, f. 17, op. 128, d. 1101, l. 142. Cfr. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 17, pp. 273-75.
79. FG, Apci, Comitato Centrale, Verbali, 1° luglio 1947.
80. Rgaspi, f. 82, op. 2, d. 1231, ll. 2627.
81. BROGI, Confronting America cit., pp. 82-83.
82. M. GILAS [ĐILAS], Se la memoria non m’inganna, il Mulino, Bologna 1987, p. 144.
83. FG, Apci, Comitato Centrale, Verbali, 1° luglio 1947.
84. P. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. I, 1946-1951, Camera dei Deputati, Roma 1984, p. 167.
85. G. DIMITROV, Dnevnik 9 mart 1933- 6 februari 1949, Universitetsko izdatelstvo «Sv. Kliment Okhridski», Sofiia 1997, p. 556.
86. Archivio Pietro Secchia cit., p. 208.
87. E. REALE, Nascita del Cominform, Mondadori, Milano 1958, p. 17.
88. The Cominform. Minutes of the three conferences 1947/1948/1949, a cura di G. Procacci, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, «Annali», XXX (1994), Feltrinelli, Milano 1994, pp. 217-51.
89. Rgaspi, f. 77, op. 3, d. 92, ll. 48-49.
90. The Cominform cit., pp. 299-301, 313-26.
91. REALE, Nascita del Cominform cit., p. 39.
92. La politica del Partito comunista italiano nel periodo costituente cit., pp. 498, 500.
93. Ibid., pp. 499-500, 507, 520.
94. Ibid., pp. 525-26.
95. Avprf, f. 098, op. 30, p. 170, d. 13, ll. 158-59.
96. A. AGOSTI (a cura di), La coerenza della ragione. Per una biografia politica di Umberto Terracini, Carocci, Roma 1998.
97. Si vedano la breve nota in prima pagina, in «l’Unità», 23 ottobre 1947; e Terracini precisa e rettifica le sue affermazioni, ivi, 24 ottobre 1947.
98. FG, Apci, Comitato Centrale, Verbali, 11 novembre 1947.
99. Avprf, f. 098, op. 30, p. 170, d. 13, l. 187.
100. E. BERNARDI, La Democrazia cristiana e la guerra fredda, in «Ventunesimo secolo», V (2006), n. 10, pp. 127-66; e FORMIGONI, La Democrazia cristiana e l’Alleanza occidentale cit., pp. 166 sgg.
101. Rgaspi, f. 17, op. 128, d. 1101, l. 184; ivi, f. 77, op. 3, d. 90, ll. 86-90; e Dagli archivi di Mosca cit., docc. 18 e 19, pp. 276-88.
102. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 20, pp. 289-93.
103. COLLOTTI, Introduzione cit., p. 102.
104. Rgaspi, f. 17, op. 128, d. 1101, l. 189; e Dagli archivi di Mosca cit., doc. 22.
105. Rgaspi, f. 17, op. 128, d. 1074; Dagli archivi di Mosca cit., doc. 21, pp. 294-307; e Archivio Pietro Secchia cit., pp. 618-27.
106. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 20, p. 292.
107. «Istoričeskij Archiv», 1996, n. 1, p. 11.
108. Per una ricostruzione della missione di Secchia a Mosca, cfr. PONS, L’impossibile egemonia, cit. cap. IV.
109. Rgaspi, f. 17, op. 128, d. 1159, l. 54.
110. Avprf, f. 098, op. 31, p. 179, d. 15, l. 124. Matteo Secchia riferí a Kostylev queste parole di Togliatti, pronunciate in sede riservata durante il VI Congresso del Pci, subito dopo la scomunica di Tito emessa dal Cominform, il 30 giugno 1948, facendo ammenda per aver guardato alla Iugoslavia «come la nostra retrovia in caso di scontro con gli americani».
111. N. NAIMARK, Stalin and the Fate of Europe. The Postwar Struggle for Sovereignty, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) - London 2019, pp. 136-39; BROGI, Confronting America cit., pp. 101-10; e J. L. GADDIS, George F. Kennan. An American Life, Penguin, New York 2011, p. 305.
112. Avprf, f. 098, op. 31, p. 180, d. 17, ll. 24-25.
113. AGA ROSSI e ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin cit., pp. 232-33.
114. Avprf, f. 098, op. 31, p. 179, d. 14, ll. 197-99.
115. Ivi, l. 162.
116. PONS, L’impossibile egemonia cit., p. 233, n. 157.
117. Sulla condotta moderata di De Gasperi nel 1948, si veda P. CRAVERI, De Gasperi, il Mulino, Bologna 2006, pp. 343-44, 365-66.
118. K. MISTRY, The United States, Italy, and the Origins of the Cold War. Waging Political Warfare, 1945-1950, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
119. Avprf, f. 098, op. 31, p. 179, d. 15, l. 48.
120. M. DEL PERO, L’alleato scomodo. Gli USA e la DC negli anni del centrismo (1948-1955), Carocci, Roma 2001, pp. 57-59.
121. Rgaspi, f. 77, op. 3, d. 106, l. 18.
122. The Cominform cit., p. 585.
123. G. GOZZINI e R. MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII, Dall’attentato a Togliatti all’VIII Congresso, Einaudi, Torino 1998, pp. 36-37; ed E. MACALUSO, 50 anni nel PCI, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 58-59.
124. Avprf, f. 098, op. 31, pap. 180, d. 16, l. 7. Si veda anche Archivio Pietro Secchia cit., pp. 217-18, 427.
125. FG, Apci, Comitato Centrale, Verbali, 24-29 settembre 1948.
126. NAIMARK, Stalin and the Fate of Europe cit., p. 268.
127. DEL PERO, L’alleato scomodo cit.
128. F. ROMERO, Storia della guerra fredda. L’ultimo conflitto per l’Europa, Einaudi, Torino 2009, pp. 70-72; e M. ANTONIOLI, M. BERGAMASCHI e F. ROMERO (a cura di), Le scissioni sindacali. Italia e Europa, Bfs edizioni, Pisa 1999.
129. AGA ROSSI e ZASLAVSKY, Togliatti e Stalin cit., pp. 217 sgg.; V. ZASLAVSKY, Lo stalinismo e la sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo (1945-1991), Mondadori, Milano 2004; M. CAPRARA, Lavoro riservato. I cassetti segreti del PCI, Feltrinelli, Milano 1997; e G. PACINI, Le altre Gladio, Einaudi, Torino 2014.
130. PH. COOKE, Red Spring. Italian Political Emigration to Czechoslovakia, in «The Journal of Modern History», LXXXIV (2012), n. 4, pp. 861-96.
131. M. CAPRARA, Quando le botteghe erano oscure. Uomini e storie del comunismo italiano, 1944-1969, il Saggiatore, Milano 1997, pp. 105-7; e GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., p. 153.
132. V. RIVA, Oro da Mosca. I finanziamenti sovietici al PCI dalla Rivoluzione d’Ottobre al crollo dell’URSS, Mondadori, Milano 1999.
133. A. TONELLI, A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (1944-1993), Laterza, Bari-Roma 2017.
134. BROGI, Confronting America cit., pp. 162 sgg.
135. N. NAIMARK, The Sovietization of East Central Europe 1945-1989, in NAIMARK, PONS e QUINN-JUDGE (a cura di), The Cambridge History of Communism. II. The Socialist Camp cit., pp. 66-74.
136. A. GUISO, La colomba e la spada. «Lotta per la pace» e antiamericanismo nella politica del Partito comunista italiano (1949-1954), Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
137. Archives of the Hoover Institution, Dmitrii A. Volkogonov papers, box 27, reel 18, 6 gennaio 1949.
138. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. I cit., 15 marzo 1949, p. 416.
139. FG, Apci, Direzione, Verbali, 29 marzo 1949.
140. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 142-52; e CRAVERI, De Gasperi cit., pp. 368-84.
141. M. DE NICOLÒ, Emilio Sereni, la guerra fredda e la «pace partigiana». Movimenti sociali e ideologie politiche in Italia (1948-1955), Carocci, Roma 2019, specie le pp. 54 sgg.
142. BROGI, Confronting America cit., pp. 123-36.
143. F. ANDREUCCI, Falce e martello. Identità e linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda, Bononia University Press, Bologna 2006.
144. FORLENZA, On the Edge of Democracy cit., pp. 110-11. Si veda M. FINCARDI, C’era una volta il mondo nuovo. La metafora sovietica nello sviluppo emiliano, Carocci, Roma 2007.
145. BOARELLI, La fabbrica del passato cit. La memorialistica comunista converge largamente su questo punto. Si vedano, in particolare, P. INGRAO, Volevo la luna, Einaudi, Torino 2006; e G. NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo. Un’autobiografia politica, Laterza, Bari-Roma 2005.
146. P. P. D’ATTORRE (a cura di), Nemici per la pelle. Sogno americano e mito sovietico nell’Italia contemporanea, FrancoAngeli, Milano 1991; GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., pp. 456-68; e D. SARESELLA, Catholics and Communists in Twentieth-Century Italy. Between Conflict and Dialogue, Bloomsbury Academic, London 2019.
147. FORGACS e GUNDLE, Mass Culture and Italian Society from Fascism to the Cold War cit., p. 262.
148. A. VITTORIA, Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani (1944-1964), Carocci, Roma 2014.
149. A. MARIUZZO, Communism and Anti-Communism in Early Cold War Italy. Language, symbols and myths, Manchester University Press, Manchester 2018, pp. 113-19.
150. GUISO, La colomba e la spada cit., pp. 455 sgg.
151. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., pp. 1565-611.
152. FORLENZA, On the Edge of Democracy cit., p. 109.
153. K. MORGAN, International Communism and the Cult of the Individual. Leaders, Tribunes and Martyrs under Lenin and Stalin, Palgrave Macmillan, London 2017, p. 237.
154. The Cominform cit., pp. 783-803.
155. S. BIANCHINI (a cura di), Valdo Magnani e l’antistalinismo comunista, Unicopli, Bologna 2013.
156. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte della scrivania, 26 dicembre 1949. Cfr. Posetiteli kremlevskogo kabineta I. V. Stalina cit., p. 173.
157. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte della scrivania, 26 dicembre 1949.
158. Ivi, Comitato Centrale, Verbali, 12-14 aprile 1950.
159. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 34, pp. 378-87.
160. GUISO, La colomba e la spada cit., pp. 322-25.
161. FIOCCO, Togliatti, il realismo della politica cit., pp. 238-39.
162. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 167-71; e DEL PERO, L’alleato scomodo cit., pp. 103-6.
163. GUISO, La colomba e la spada cit., pp. 328-30.
164. Dagli archivi di Mosca cit., docc. 36 e 37, pp. 394-414; e FG, Apci, Direzione, Verbali, 6 dicembre 1950.
165. Gli incontri registrati tra Togliatti e Stalin si svolsero il 13 e il 18 gennaio e il 12 febbraio 1951, cfr. Posetiteli kremlevskogo kabineta I. V. Stalina cit., p. 173. Due di questi incontri furono tenuti con due successive delegazioni del Pci, cfr. Archivio Pietro Secchia cit., pp. 229-32. Non possediamo alcun verbale degli incontri, né sovietico né italiano.
166. Dagli archivi di Mosca cit., doc. 39, pp. 417-20.
167. Ibid., doc. 40, pp. 421-22.
168. Archivio Pietro Secchia cit., pp. 229-31, 445.
169. L. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I, Con Togliatti e Longo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 270-72.
170. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Archivio Pietro Secchia, Serie documenti, contenitore 14, fasc. 7.
171. GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., pp. 193-99; e ALBELTARO, Le rivoluzioni non cadono dal cielo cit., p. 145.
172. BROGI, Confronting America cit., pp. 136 sgg.; e DEL PERO, L’alleato scomodo cit., pp. 130-34.
173. GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., pp. 222 sgg.
174. M. DEL PERO, Containing Containment. Rethinking Italy’s Experience during the Cold War, in «Journal of Modern Italian Studies», VIII (2003), n. 4, pp. 532-55.
175. HOBSBAWM, Anni interessanti cit., p. 227.
176. P. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. II, 1952-1964, Camera dei Deputati, Roma 1984, pp. 776-78.
177. G. ORSINA e G. PANVINI (a cura di), La delegittimazione politica nell’età contemporanea. I. Nemici e avversari politici nell’Italia repubblicana, Viella, Roma 2016; IDD., Delegitimizing political opponents in republican Italy, in F. CAMMARANO (a cura di), Praxis, language, and theory of political delegitimization in contemporary Europe, Viella, Roma 2017, pp. 103-20; A. VENTRONE, Il nemico interno. Immagini, parole e simboli della lotta politica nell’Italia del Novecento, Donzelli, Roma 2005; e MARIUZZO, Communism and Anti-Communism in Early Cold War Italy cit.
Capitolo quarto, Policentrismo e decolonizzazione.
1. P. TOGLIATTI, Opere, vol. V, 1944-1955, a cura di L. Gruppi, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 832-46.
2. G. AMENDOLA, Il rinnovamento del Pci, Editori Riuniti, Roma 1978, p. 54.
3. TOGLIATTI, La guerra di posizione in Italia cit., doc. 66, p. 204.
4. G. VACCA, L’Italia contesa. Comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra (1943-1978), Marsilio, Venezia 2018, pp. 170-78.
5. FIOCCO, Togliatti, il realismo della politica cit., p. 264. Sul ruolo di Amendola nel 1954, si veda CERCHIA, Giorgio Amendola. Gli anni della Repubblica cit., pp. 192 sgg.
6. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del Pci, vol. I cit., p. 124; GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., pp. 347 sgg.; e ALBELTARO, Le rivoluzioni non cadono dal cielo cit., cap. VII.
7. DEL PERO, L’alleato scomodo cit., pp. 239-41.
8. Prezidium CK KPSS, 1954-1964, vol. I, Černovye protokol′nye zapisi zasedanij. Stenogrammy, Rosspen, Moskva 2003, p. 205.
9. Nasledniki Kominterna. Meždunarodnye soveščanija predstavitelej kommunističeskich i rabočich partij v Moskve. Dokumenty (nojabr′ 1957g.), Rosspen, Moskva 2013, pp. 16-20.
10. Quel terribile 1956. I verbali della direzione comunista tra il XX Congresso del PCUS e l’VIII Congresso del PCI, a cura di M. L. Righi, Editori Riuniti, Roma 1996, 20 giugno 1956, p. 59.
11. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I cit., p. 143.
12. GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., p. 521.
13. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 124.
14. 9 domande sullo stalinismo. Risposte di Palmiro Togliatti, in «Nuovi Argomenti», XX (1956), pp. 1-2, 110-39, ora in Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., pp. 1612-40.
15. Quel terribile 1956 cit., 20 giugno 1956, p. 60.
16. Ibid., pp. 75, 81.
17. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 124. Cfr. Quel terribile 1956 cit., 18 luglio 1956, pp. 138-42, 149; e G. PAJETTA, Le crisi che ho vissuto. Budapest Praga Varsavia, Editori Riuniti, Roma 1982, pp. 63-68.
18. Quel terribile 1956 cit., 18 luglio 1956, pp. 117 sgg.
19. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. II cit., 13 giugno 1956, pp. 928-29.
20. O. A. WESTAD, The Cold War. A World History, Allen Lane, London 2017, pp. 270-71; e MAZOWER, Governing the World cit., p. 261.
21. Quel terribile 1956 cit., 20 giugno 1956, p. 54.
22. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 124.
23. P. TOGLIATTI, Opere, vol. VI, 1956-1964, a cura di L. Gruppi, Editori Riuniti, Roma 1984, p. 154.
24. Sovetskij Sojuz i vengerskij krizis 1956 goda. Dokumenty, Rosspen, Moskva 1998, docc. 123 e 128. Per il dibattito nel gruppo dirigente del Pci, si veda Quel terribile 1956 cit.
25. Quel terribile 1956 cit., 30 ottobre 1956, pp. 221, 239.
26. Ibid., pp. 222-24.
27. GOZZINI e MARTINELLI, Storia del Partito comunista italiano, vol. VII cit., pp. 588 sgg.
28. G. SCROCCU, Alla ricerca di un socialismo possibile. Antonio Giolitti dal PCI al PSI, Carocci, Roma 2012, pp. 116-20.
29. A. CARIOTI (a cura di), Eugenio Reale, l’uomo che sfidò Togliatti, Liberal libri, Firenze 1998.
30. J. HASLAM, I dilemmi della destalinizzazione: Togliatti, il XX Congresso del PCUS e le sue conseguenze, in GUALTIERI, SPAGNOLO e TAVIANI (a cura di), Togliatti nel suo tempo cit., pp. 215-38.
31. S. RADCHENKO, Il 1956 globale. Gli effetti internazionali della destalinizzazione, in PONS (a cura di), Globalizzazioni rosse cit., pp. 109-30.
32. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., p. 813.
33. Ibid., p. 792.
34. P. TOGLIATTI, Attualità del pensiero e dell’azione di Gramsci, in «Rinascita», XIV (1957), n. 4, ora ibid., pp. 1102-20; e ID., Il leninismo nel pensiero e nell’azione di A. Gramsci (1958), ibid., pp. 1121-141.
35. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., p. 827.
36. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 198.
37. A. GUISO, «Il lungo ’56». I rapporti tra «partito adulto» e gioventú comunista dalla destalinizzazione al Sessantotto: modello organizzativo, generazioni, cultura politica, in G. QUAGLIARIELLO (a cura di), La politica dei giovani in Italia (1945-1968), Luiss University Press, 2005, pp. 69-118; e G. SORGONÀ, La svolta incompiuta. Il gruppo dirigente del PCI dall’VII all’XI Congresso (1956-1965), Aracne, Roma 2011, pp. 62-71.
38. Rgani, f. 81, op. 1, d. 306.
39. FG, Apci, Direzione, Verbali, 30 gennaio 1957.
40. Z. SHEN e Y. XIA, The wirlwind of China. Zhou Enlai’s shuttle diplomacy in 1957 and its effects, in «Cold War History», X (2010), n. 4, pp. 513-35; e RADCHENKO, Il 1956 globale cit.
41. Nasledniki Kominterna cit., pp. 61-72; Prezidium CK KPSS cit., vol. I, docc. 138 e 139, pp. 280-81, 1022; ibid., vol. II, doc. 138, pp. 720-30; e Z. SHEN e Y. XIA, Hidden Currents During the Honeymoon. Mao, Khrushchev, and the 1957 Moscow Conference, in «Journal of Cold War Studies», XI (2009), n. 4, pp. 74-117.
42. Nasledniki Kominterna cit., pp. 222-26.
43. FG, Apci, Fondo Mosca, mf 252; e Nasledniki Kominterna cit., pp. 325-41.
44. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte Botteghe Oscure, Pci, fasc. 27.
45. Nasledniki Kominterna, pp. 367-77, 566-74.
46. L. M. LÜTHI, The Sino-Soviet Split. Cold War in the Communist World, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2008, pp. 74-79; e CH. JIAN, Mao’s China and the Cold War, The University of North Carolina Press, Chapel Hill - London 2001.
47. Togliatti annotò, tra l’altro, i passaggi del discorso di Mao sulla guerra termonucleare come segue: «Vi sono dei maniaci della guerra / bisogna sempre calcolare il peggio / può morire per la guerra atomica un terzo del genere umano, anche la metà e piú». Egli non annotò le parole di Mao sul fatto che il mondo sarebbe divenuto socialista all’indomani di una guerra termonucleare, cfr. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte Botteghe Oscure, Pci, fasc. 26, p. 6.
48. INGRAO, Volevo la luna cit., p. 255.
49. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte Botteghe Oscure, Pci, fasc. 27, p. 12.
50. SHEN e XIA, Hidden Currents During the Honeymoon cit., p. 91.
51. Nasledniki Kominterna cit., p. 222.
52. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte Botteghe Oscure, Pci, fasc. 27.
53. V. VIDALI, Diario del XX Congresso, Vangelista, Milano 1974, p. 162.
54. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 106, c. 1, ll. 161-70. Nei suoi ricordi dell’incontro con Chruščëv del 1958, Amendola non fa cenno alla questione, cfr. AMENDOLA, Il rinnovamento del PCI cit., pp. 150-51.
55. C. SPAGNOLO, Sul Memoriale di Yalta. Togliatti e la crisi del movimento comunista internazionale (1956-1964), Carocci, Roma 2007, pp. 192-94.
56. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte Botteghe Oscure, Pci, fasc. 34, pp. 1-24.
57. Conferenza degli 81 partiti comunisti e operai, Mosca 1960, ivi, Archivio Berlinguer, Movimento operaio internazionale, 1.3.
58. L. LONGO, Opinione sulla Cina, La Pietra, Milano 1977, pp. 27, 36, 47-48; e Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 1, c. 22, ll. 66-90.
59. FG, Apci, Conferenza di Mosca dei PC e operai, novembre 1960, mf 0474, 2628-43.
60. Ivi, Direzione, Verbali, 9 dicembre 1960.
61. AGOSTI, Palmiro Togliatti cit., p. 517.
62. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I cit., pp. 265, 269.
63. M. L. RIGHI (a cura di), Il PCI e lo stalinismo. Un dibattito del 1961, Editori Riuniti, Roma 2007, pp. 29-32.
64. M. CONGIU, Gli appunti di Imre Nagy a Snagov (1956-57), in «Studi Storici», LII (2011), n. 1, pp. 127-54.
65. RIGHI (a cura di), Il PCI e lo stalinismo cit., pp. 105-20; e BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I cit., pp. 276-79.
66. RIGHI (a cura di), Il PCI e lo stalinismo cit., pp. 280-99.
67. Sul tema del linguaggio comunista, si veda ANDREUCCI, Da Gramsci a Occhetto cit., pp. 303-9; e G. BASSI (a cura di), Words of Power, the Power of Words. The Twentieth-Century Communist Discourse in International Perspective, Eut, Trieste 2019.
68. L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del Comitato Centrale del Pcus, 1953-1970, a cura di F. Bettanin e M. Prozumenščikov, A. Roccucci e A. Salacone, Viella, Roma 2015, doc. 28, pp. 160-69.
69. FG, Apci, Direzione, Verbali, 7 dicembre 1961.
70. Ivi, Estero, Urss, 1962, mf 0503, 481-82.
71. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 29, pp. 169-71.
72. Sulla conquista dello spazio come ultimo mito sovietico, cfr. S. PIVATO e M. PIVATO, I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa, il Mulino, Bologna 2017.
73. P. TOGLIATTI, Alcuni problemi della storia dell’Internazionale comunista (1959), in Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., p. 1756.
74. ID., Il partito comunista italiano (1958), ibid., pp. 1700-1.
75. ID., Lenin e il nostro partito (1960), ibid., p. 1781.
76. M. MAGGIORANI, L’Europa degli altri. Comunisti italiani e integrazione europea (1957-1969), Carocci, Roma 1998.
77. G. CALCHI NOVATI, Mediterraneo e questione araba nella politica estera italiana, in F. BARBAGALLO (a cura di), Storia dell’Italia Repubblicana, vol. II, La trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri, t. I, Politica, economia, società, Einaudi, Torino 1994, pp. 195-251; e A. VARSORI, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Laterza, Bari-Roma 1998, pp. 117-29.
78. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 221-23; e G. MONINA, Lelio Basso, leader globale. Un socialista nel secondo Novecento, Carocci, Roma 2016, pp. 124-25.
79. G. SCIROCCO, Politique d’abord. Il PSI, la guerra fredda e la politica internazionale (1948-1957), Unicopli, Milano 2010, pp. 224-25.
80. WESTAD, The Cold War cit., p. 281; e A. FURSENKO e T. NAFTALI, Khrushchev’s Cold War. The Inside Story of an American Adversary, Norton, New York - London 2006, pp. 138 sgg.
81. A. BROGI, L’Italia e l’egemonia americana nel Mediterraneo, La Nuova Italia, Firenze 1996; E. BINI, La potente benzina italiana. Guerra fredda e consumi di massa tra Italia, Stati Uniti e Terzo Mondo (1945-1973), Carocci, Roma 2013; e ID., Fueling Modernization from the Atlantic to the Third World. Oil and Economic Development in ENI’s International Policies, 1950s-1960s, in A. BELTRAN, E. BOUSSIÈRE e G. GARAVINI (a cura di), Europe and Energy from the 1960s to the 1980s, Peter Lang, Brussels 2016, pp. 41-59.
82. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. II cit., 13 giugno 1956, pp. 928-29.
83. Ibid., 5 giugno 1957, p. 960; e ibid., 15 ottobre 1957, p. 988.
84. Ibid., 15 ottobre 1957, p. 994.
85. S. SE[GRE], Italia atlantica o mediterranea?, in «Rinascita», XIV (1957), n. 12.
86. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. II cit., 29 gennaio 1958, p. 1006.
87. BROGI, Confronting America cit., p. 226.
88. IMLAY, The Practice of Socialist Internationalism cit., pp. 417-22, 440-44; e G. GARAVINI, Dopo gli imperi. L’integrazione europea nello scontro Nord-Sud, Le Monnier, Firenze 2009, pp. 68-70.
89. Crepuscolo del colonialismo è il titolo del fascicolo doppio di «Rinascita», XV (1958), n. 11-12.
90. A. GIOVAGNOLI, Pio XII e la decolonizzazione, in A. RICCARDI (a cura di), Pio XII, Laterza, Roma-Bari 1984, pp. 179-209.
91. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., p. 251; e R. GUALTIERI, L’Italia dal 1943 al 1992. DC e PCI nella storia della Repubblica, Carocci, Roma 2006, pp. 141-42.
92. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. II cit., 15 ottobre 1959, pp. 1099-101.
93. Sulla dimensione ideale di Fanfani nella politica internazionale, ma anche sui suoi evidenti limiti, si vedano i saggi di A. GIOVAGNOLI, L’impegno internazionale di Fanfani, e A. RICCARDI, Radici storiche e prospettive ideali di una politica estera, in A. GIOVAGNOLI e L. TOSI (a cura di), Amintore Fanfani e la politica estera italiana, Marsilio, Venezia 2010.
94. A. ROCCUCCI, Coesistenza pacifica tra diseguali. Italia e Unione Sovietica dalla morte di Stalin alla visita di Gronchi a Mosca, in L’Italia vista dal Cremlino cit., pp. 30-31.
95. I diari di Luca Pietromarchi. Ambasciatore italiano a Mosca (1958-1961), a cura di B. Bagnato, Olschki, Firenze 2002, pp. 260-61.
96. IX Congresso del Partito comunista italiano. Atti e risoluzioni, Editori Riuniti, Roma 1960, pp. 39-40.
97. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 20. Sui colloqui di Gronchi e Pella a Mosca, si veda A. SALACONE, La diplomazia del dialogo. Italia e URSS tra coesistenza pacifica e distensione (1958-1968), Viella, Roma 2017, pp. 93-105.
98. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 24.
99. Nota per la segreteria, 28 luglio 1961, in FG, Apci, mf 477, 283-85.
100. SPAGNOLO, Sul Memoriale di Yalta cit., p. 81.
101. F. DE FELICE, Nazione e sviluppo. Un nodo non sciolto, in BARBAGALLO (a cura di), Storia dell’Italia Repubblicana, vol. II cit., t. I cit., p. 118; e L. MAGRI, Il sarto di Ulm. Una possibile storia del Pci, il Saggiatore, Milano 2009, pp. 188-90.
102. BROGI, Confronting America cit., pp. 253-54; e FORGACS e GUNDLE, Mass Culture and Italian Society from Fascism to the Cold War cit.
103. G. CORSINI, L’elezione di Kennedy e l’inquietudine americana, in «Rinascita», XVII (1960), n. 12; e ID., I cento giorni del Presidente Kennedy, ivi, XVIII (1961), n. 7-8.
104. D. W. ELLWOOD, Una sfida per la modernità. Europa e America nel lungo Novecento, Carocci, Roma 2012, pp. 198, 202.
105. M. CONNELLY, A Diplomatic Revolution. Algeria’s Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era, Oxford University Press, Oxford - New York 2002.
106. O. A. WESTAD, The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge University Press, Cambridge 2005, pp. 66 sgg.; A. HILGER, Communism, Decolonization and the Third World, in NAIMARK, PONS e QUINN-JUDGE (a cura di), The Cambridge History of Communism. II. The Socialist Camp cit., pp. 322-31; e S. PONS, Mondi diversi, storie intrecciate. Gli Stati socialisti e il Terzo Mondo durante la guerra fredda, in ID. (a cura di), Globalizzazioni rosse cit., pp. 133-54.
107. RUPPRECHT, Soviet Internationalism after Stalin cit.
108. TONELLI, A scuola di politica cit., pp. 175 sgg. Per una ricostruzione autobiografica, si veda G. CERVETTI, Compagno del secolo scorso. Una storia politica, Bompiani, Milano 2016.
109. J. LILL, Völkerfreundschaft im Kalten Krieg? Die politischen, kulturellen und ökonomischen Beziehungen der DDR zu Italien 1949-1973, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2001; M. MARTINI, La Cultura all’ombra del Muro. Relazioni culturali tra Italia e Ddr (1949-1989), il Mulino, Bologna 2007; e T. MALICE, Transnational Imaginations of Socialism. Political Town Twinning Between Italy and the German Democratic Republic in the 1960s and 1970s, Dottorato di ricerca in Storia Culture Civiltà, ciclo XXXI, Università di Bologna, 2019.
110. D. BERNARDINI, Scampoli rossi. Ricordi di un comunista impenitente, Slavia, Roma 2017, pp. 72-79.
111. T. DRAGOSTINOVA e M. FIDELIS, Introduction. Beyond the Iron Curtain. Eastern Europe and the Global Cold War, in «Slavic Review», LXXVII (2018), n. 3, pp. 577-87.
112. S. LORENZINI, The Socialist Camp and Economic Modernization in the Third World, in NAIMARK, PONS e QUINN-JUDGE (a cura di), The Cambridge History of Communism. II. The Socialist Camp cit., pp. 343-51; S. LORENZINI, Una strana guerra fredda. Lo sviluppo e le relazioni Nord-Sud, il Mulino, Bologna 2017, pp. 81-84; e PH. MUEHLENBECK, Czechoslovakia in Africa, 1945-1968, Palgrave Macmillan, London 2016.
113. FRIEDMAN, Shadow Cold War cit., pp. 71-73.
114. Rgani, f. 81, op. 1, d. 306.
115. M. GALEAZZI, Il Pci e il movimento dei paesi non allineati (1955-1975), FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 41-49.
116. Nasledniki Kominterna cit., p. 450.
117. FG, Apci, Direzione, Verbali, mf 22, 3 ottobre 1958.
118. Rgani, f. 81, op. 1, d. 306, ll. 47-50.
119. G. SIRACUSANO, Il Pci e il processo d’indipendenza dell’Africa nera francese (1958-1961), in «Studi Storici», LVII (2016), n. 1, pp. 189-218; e ID., La fine di un miraggio politico: lo sguardo del PCI e del PCF sull’Africa subsahariana francofona indipendente (1960-1984). Nuove visioni e prospettive africane dei comunisti occidentali, Dottorato di Ricerca in Storia e Scienze filosofiche e sociali, ciclo XXXII, Università di Roma «Tor Vergata», 2019, pp. 127-30, 140-41.
120. Riunione del primo marzo 1960 per discutere sulla politica del Pci verso i paesi arabi, in FG, Apci, Esteri, mf 468, 2295, 2299, 2301.
121. S. MAZOV, A Distant Front in the Cold War. The USSR in West Africa and the Congo 1956-1964, Stanford University Press, Stanford 2010; R. LEDDA, Unità dell’Africa e lotta anticoloniale, in «Rinascita», XVII (1960), n. 11; e G. C. P[AJETTA], L’assassinio di Lumumba, ivi, XVIII (1961), n. 2.
122. Riunione del primo marzo 1960 per discutere sulla politica del Pci verso i paesi arabi, in FG, Apci, Esteri, mf 468.
123. TOGLIATTI, Discorsi parlamentari, vol. II cit., 27 settembre 1961, p. 1216.
124. R. LEDDA, Posta al Cairo l’esigenza di riassestare l’economia mondiale, in «Rinascita», XIX (1962), n. 13; e ID., I sottosviluppati rifiutano la vocazione «agricola», ivi, XIX (1962), n. 14. Cfr. GARAVINI, Dopo gli imperi cit., p. 39.
125. G. CALCHI NOVATI, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma 2011, pp. 355-69; e N. LABANCA, La guerra d’Etiopia, 1935-1941, il Mulino, Bologna 2015, pp. 219-30.
126. Sulle posizioni dei comunisti francesi e algerini nella guerra d’Algeria, cfr. A. RUSCIO, Les communistes et l’Algérie. Des origines à la guerre d’indépendance, La Découverte, Paris 2019; e A. DREW, We are no longer in France. Communists in colonial Algeria, Manchester University Press, Manchester 2014.
127. Sul Fln e sul Pca [Partito comunista algerino]. Appunti sui precedenti storici, in FG, Apci, Estero, Algeria, 1961, mf 483, 2387-8, 2391.
128. P. BORRUSO, Il PCI e l’Africa indipendente. Apogeo e crisi di un’utopia socialista (1956-1989), Le Monnier, Firenze 2009, p. 70.
129. FRIEDMAN, Shadow Cold War cit., pp. 134-38.
130. P. TOGLIATTI, Algeria indipendente, in «Rinascita», XIX (1962), n. 10.
131. CH. KALTER, The Discovery of the Third World. Decolonization and the Rise of the New Left in France, 1950-1976, Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 90-99; e A. BRAZZODURO, Algeria, Antifascism, and Thirdworldism: An Anticolonial Genealogy of the Western European New Left (Algeria, France, Italy 1957-1975), in «The Journal of Imperial and Commonwealth History», XLVIII (2020), n. 5, pp. 958-78.
132. SRIVASTAVA, Italian colonialism and resistances to Empire cit., pp. 213 sgg.
133. P. GOEDDE, The Politics of Peace. A Global Cold War History, Oxford University Press, Oxford - New York 2019, pp. 60, 162-67.
134. J.-P. SARTRE, La guerra fredda e l’unità della cultura, in «Rinascita», XIX (1962), n. 23.
135. R. ROSSANDA, Problemi e prospettive dell’Algeria indipendente, ivi, XX (1963), n. 28; N. MANDELA, J’accuse, ivi, XX (1963), n. 26; e K. N’KRUMAH [NKRUMAH], La ricchezza dell’Africa, ivi, XX (1963), n. 32.
136. Appunti di Maurizio Valenzi per una discussione sulla politica dell’Italia verso il Terzo Mondo, in FG, Apci, Esteri, 1963, mf 489, 2766-69.
137. Ivi, Direzione, Verbali, 31 ottobre 1962.
138. SPAGNOLO, Sul Memoriale di Yalta cit., p. 232.
139. X Congresso del partito comunista italiano cit., pp. 38-45.
140. P. T[OGLIATTI], Riconduciamo la discussione ai suoi termini reali, in «Rinascita», XX (1963), n. 2.
141. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., pp. 930-31, 935.
142. FRIEDMAN, Shadow Cold War, pp. 103-4.
143. P. TOGLIATTI, Sull’accordo pel divieto delle esplosioni atomiche, in «Rinascita», XX (1963), n. 33.
144. FG, Apci, Direzione, Verbali, 12 settembre 1963.
145. Ivi, 11 ottobre 1963.
146. P. TOGLIATTI, Verso il socialismo in Occidente?, in «Rinascita», XX (1963), n. 42; e ID., L’imperialismo e la socialdemocrazia (1928), ibid.
147. FG, Apci, Comitato Centrale, registrazione audio, 24 ottobre 1963; Per una nuova avanzata e per l’unità del movimento comunista internazionale. Documento del comitato centrale del Partito Comunista Italiano, in «l’Unità», 26 ottobre 1963; e P. BUFALINI, L. GRUPPI e A. NATTA (a cura di), Il Partito comunista italiano e il movimento operaio internazionale 1956-1968, Editori Riuniti, Roma 1968, pp. 168-98.
148. FRIEDMAN, Shadow Cold War cit., pp. 117-18.
149. FG, Apci, Estero, Iugoslavia, 1964, mf 520, 1393-401, 15-21 gennaio 1964.
150. Viaggio in Iugoslavia (14 gennaio - 1° febbraio 1964), pp. 7-15, 16-25, ivi, Palmiro Togliatti, Carte Marisa Malagoli; e ivi, Estero, Iugoslavia, 1964, mf 520, 1402-14, 15-21 gennaio 1964. Per il resoconto di parte iugoslava, cfr. GALEAZZI, Il Pci e il movimento dei paesi non allineati cit., pp. 102-3.
151. J. J. BYRNES, Mecca of Revolution. Algeria, Decolonization, and the Third World Order, Oxford University Press, Oxford - New York 2016.
152. BORRUSO, Il PCI e l’Africa indipendente cit., pp. 84-89.
153. Informazione della compagna Maria Antonietta Macciocchi sul viaggio della delegazione del Pci in Algeria, in FG, Apci, Estero, Algeria, 1964, mf 520, 124-56.
154. FRIEDMAN, Shadow Cold War cit., pp. 137-38.
155. FG, Apci, Estero, Cuba, 1964, mf 492, 2555-66, 12 agosto 1963.
156. Il compagno Ingrao è tornato da Cuba, in «l’Unità», 19 gennaio 1964; e O. PAPPAGALLO, Il PCI e la rivoluzione cubana. La «via latino-americana al socialismo» tra Mosca e Pechino (1959-1965), Carocci, Roma 2009, pp. 206-11.
157. FG, Apci, Palmiro Togliatti, Carte della scrivania, agosto 1964.
158. P. TOGLIATTI, Viaggio in Iugoslavia, in «Rinascita», XXI (1964), n. 5.
159. FG, Apci, Estero, Urss, 1964, mf 0520, 2435-39.
160. Ivi, Direzione, Verbali, 1964, mf 028, 490-98, 26 febbraio 1964.
161. Ivi, 2 aprile 1964.
162. Ivi, Estero, Urss, 1964, mf 0520, 2514-20.
163. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 46, p. 235.
164. FG, Apci, Direzione, Verbali, 9 aprile 1964
165. Ivi, Comitato Centrale, Verbali, mf 28, 22 aprile 1964.
166. Ivi, Direzione, Verbali, 12 maggio 1964.
167. Ivi, Estero, Urss, 1964, mf 0520, 22 maggio 1964.
168. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 1, č 2, l. 164.
169. FG, Apci, Direzione, Verbali, 2 luglio 1964.
170. Ivi, Estero, Urss, 1964, mf 0520, 2621-26.
171. Ivi, 2649-65. Per una ricostruzione dettagliata, si veda A. HÖBEL, Il Pci nella crisi del movimento comunista internazionale tra Pcus e Pcc (1960-1964), in «Studi Storici», XLVI (2005), n. 2, pp. 515-72.
172. Rgaspi, f. 495, op. 221, d. 106, c. 1, ll. 139-40.
173. SPAGNOLO, Sul Memoriale di Yalta cit., pp. 27-46.
174. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., pp. 1842-54.
175. SPAGNOLO, Sul Memoriale di Yalta cit., pp. 240-43; e FIOCCO, Togliatti, il realismo della politica cit., pp. 431-36.
176. MAGGIORANI, L’Europa degli altri cit., pp. 165 sgg.
177. Palmiro Togliatti. La politica nel pensiero e nell’azione cit., p. 1854.
178. L’accostamento tra i due documenti è ben presente nella memoria comunista: cfr. G. BOFFA, Memorie dal comunismo. Storia confidenziale di quarant’anni che hanno cambiato il volto all’Europa, Ponte alle Grazie, Firenze 1998, p. 128. La lettera di Gramsci del 14 ottobre 1926 fu pubblicata in «Rinascita», XXI, 1964, n. 22.
179. P. TOGLIATTI, Promemoria sulle questioni del movimento operaio internazionale e della sua unità, in «Rinascita», XXI (1964), n. 35. Cfr. A. HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo (1964-1969), Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2010, pp. 54-57.
180. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 48, p. 241.
181. A. COSSUTTA, Una storia comunista, Rizzoli, Milano 2004, pp. 93 sgg.
182. N. PEDRAZZI, L’Italia che sognava Enver. Partigiani, comunisti, marxisti-leninisti: gli amici italiani dell’Albania popolare (1943-1976), Besa, Nardò 2017, pp. 252-70.
183. Nella numerosa memorialistica, si vedano G. PAJETTA, La lunga marcia dell’internazionalismo, Editori Riuniti, Roma 1978, pp. 135-41; E. MACALUSO, Togliatti e i suoi eredi, Rubbettino, Soveria Mannelli 1988; e BOFFA, Memorie dal comunismo cit., p. 133.
PARTE TERZA, Trasformazioni: il tramonto dell’internazionalismo (1964-1984).
Capitolo quinto, Socialismo umanistico e «lungo Sessantotto».
1. WESTAD, The Cold War cit., pp. 325-38.
2. Tra le memorie che restituiscono lo smarrimento del gruppo dirigente del Pci dopo la morte di Togliatti, si veda soprattutto R. ROSSANDA, La ragazza del secolo scorso, Einaudi, Torino 2005.
3. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Movimento operaio internazionale, fasc. 15, 29 ottobre 1964.
4. Ivi, Direzione, Verbali, 12 febbraio 1965.
5. HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo cit., pp. 161-62.
6. FG, Apci, Direzione, Verbali, 21 maggio 1965.
7. O. PAPPAGALLO, Verso il nuovo mondo. Il PCI e l’America Latina (1945-1973), FrancoAngeli, Milano 2017, p. 149.
8. FG, Apci, Direzione, Verbali, 25 giugno 1965.
9. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I cit., pp. 369-70.
10. FG, Apci, Direzione, Verbali, 23 dicembre 1965.
11. BROGI, Confronting America cit., pp. 256-67.
12. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I cit., p. 368; INGRAO, Volevo la luna cit., pp. 312-15; e HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo cit., pp. 179-80, 195.
13. CERCHIA, Giorgio Amendola. Gli anni della Repubblica cit., pp. 300-1.
14. M. DI MAGGIO, Alla ricerca della terza via al socialismo. I PC italiano e francese nella crisi del comunismo (1964-1984), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp. 76-79.
15. M. B. YOUNG e S. QUINN-JUDGE, The Vietnam War as a World Event, in J. FÜRST, S. PONS e M. SELDEN (a cura di), The Cambridge History of Communism. III. Endgames? Late Communism in Global Perspective, 1968 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. 50-71; e WESTAD, The Global Cold War cit., pp. 192-94.
16. FG, Apci, Estero, Incontri internazionali, 1966, mf 537, 1016-24; e ivi, 1044-48. Si veda C. GALLUZZI, La svolta. Gli anni cruciali del partito comunista italiano, Sperling&Kupfer, Milano 1983, pp. 79-83.
17. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 332-41.
18. L. BREŽNEV, Rabočie i dnevnikovye zapisi, vol. I, 1964-1982, IstLit, Moskva 2016, doc. 35, pp. 151-53.
19. FG, Apci, Direzione, Verbali, 27 dicembre 1966; ivi, Estero, Urss, 1966, mf 537, 555-57; e GALLUZZI, La svolta cit., p. 98.
20. J. HERSHBERG, Marigold. The Lost Chance for Peace in Vietnam, Woodrow Wilson Center Press - Stanford University Press, Washington DC - Stanford 2012. Cfr. A. MELLONI, La politica internazionale della Santa Sede negli anni Sessanta, in ID. (a cura di), Il filo sottile. L’Ostpolitik vaticana di Agostino Casaroli, il Mulino, Bologna 2006, pp. 26-32.
21. GALLUZZI, La svolta cit., pp. 93, 128-29, 159 sgg.
22. HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo cit., pp. 398, 446; FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 349-50; e V. LOMELLINI, Prove di pacifismo all’italiana. La critica alla Guerra del Vietnam e la genesi dell’«altra America». Un punto di incontro tra Pci e Dc?, in «Ricerche di storia politica», XXII (2019), n. 1, pp. 37-48.
23. FG, Apci, Estero, Iugoslavia, 1967, mf 545, 2106-14.
24. Ivi, Direzione, Verbali, 24 gennaio 1967.
25. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 57, p. 286.
26. FG, Apci, Estero, Urss, 1967, mf 546, 154-65.
27. La lotta per la pace e la libertà nel Vietnam e l’impegno del PCI per l’Unità del movimento comunista internazionale, in «l’Unità», 24 febbraio 1967.
28. MAGGIORANI, L’Europa degli altri cit., pp. 249 sgg.
29. GALLUZZI, La svolta cit., p. 154.
30. Lettera di W. Brandt, Nota su colloqui di Galluzzi e Segre con Leo Bauer, in FG, Apci, 1967, Partiti esteri (Rft), mf 058, 1157-60; Relazioni sull’incontro tra la delegazione del Pci e la delegazione della Spd, ivi, 1161-72; e GALLUZZI, La svolta cit., pp. 171-74.
31. M. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea (1964-1984), Carocci, Roma 2015, pp. 56-66.
32. SIRACUSANO, La fine di un miraggio politico cit., pp. 424-25, 478. Cfr. A. IANDOLO, The Rise and Fall of the «Soviet Model of Development» in West Africa, 1957-1964, in «Cold War History», XXII (2012), n. 4, pp. 683-704.
33. I pericoli per la pace restano gravi s’impone una nuova politica estera, in «l’Unità», 11 luglio 1967. Cfr. L. RICCARDI, Il «problema Israele». Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato ebraico, Guerini studio, Milano 2006, pp. 253 sgg.; e C. BRILLANTI, Le sinistre italiane e il conflitto arabo-israelo-palestinese 1948-1973, Sapienza Università editrice, Roma 2018, pp. 190-92, 222-23.
34. R. LEDDA, La Resistenza palestinese, in «Rinascita», XXV (1968), n. 18.
35. GALEAZZI, Il Pci e il movimento dei paesi non allineati cit., pp. 173-74; e BORRUSO, Il PCI e l’Africa indipendente cit., pp. 100-4.
36. A. GETACHEW, Worldmaking after Empire. The Rise and Fall of Self-Determination, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2019, cap. V.
37. HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo cit., pp. 440-41.
38. L. LONGO, I tre fronti della lotta antimperialista, in «Rinascita», XXIV (1967), n. 46.
39. R. ROSSANDA, Il punto di vista di Cuba, ivi, XXIV (1967), n. 38; L. PAVOLINI, Cultura e rivoluzione nel Terzo mondo, ivi, XXV (1968), n. 4; e L. FOA, Le attese deluse del «terzo mondo», ivi, XXV (1968), n. 8.
40. Una politica di pace e di indipendenza per dare all’Italia e all’Europa una nuova prospettiva, in «l’Unità», 27 marzo 1968; e Intervista con Dubček, ivi, 31 marzo 1968.
41. M. BRACKE, Quale socialismo, quale distensione? Il comunismo europeo e la crisi cecoslovacca del ’68, Carocci, Roma 2008, p. 142. Il resoconto dei colloqui di parte cecoslovacca è pubblicato in J. NAVRÁTIL (a cura di), The Prague Spring 1968, Central European University Press, Budapest - New York 1998, doc. 29, pp. 126-28. Cfr. BOFFA, Memorie dal comunismo cit., p. 151.
42. Prager Frühling. Das internationale Krisenjahr 1968. Dokumente, a cura di S. Karner, N. Tomilina e A. Tschubarjan, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2008, doc. 77, p. 531.
43. FG, Apci, Direzione, Verbali, 10 maggio 1968.
44. Ivi, Estero, Urss, 1968, mf 553, 216-37; ivi, Direzione, Verbali, 17 e 26 luglio 1968; NAVRÁTIL (a cura di), The Prague Spring 1968 cit., doc. 56, p. 257; e PAJETTA, Le crisi che ho vissuto cit., pp. 124-27.
45. GALLUZZI, La svolta cit., pp. 202-4.
46. FG, Apci, Direzione, Verbali, 23 agosto 1968.
47. Longo: siamo stati e saremo solidali con il nuovo corso cecoslovacco, in «l’Unità», 28 agosto 1968.
48. T. BARIS, La «Primavera di Praga» e il Partito comunista italiano, in F. ANGHELONE e L. SCOPPOLA IACOPINI (a cura di), Praga 1968. La «Primavera» e la sinistra italiana, Bordeaux, Roma 2014, pp. 180-82; e BOFFA, Memorie dal comunismo cit., p. 154.
49. A. COSSUTTA, «Note sul viaggio a Mosca», 12 settembre 1968, in FG, Apci, Direzione, Verbali, 18 settembre 1968. Cfr. HÖBEL, Il PCI di Luigi Longo cit., pp. 536-37.
50. FG, Apci, Direzione, Verbali, 18 settembre 1968.
51. G. AMENDOLA, Il nostro internazionalismo, in «Rinascita», XXV (1968), n. 35.
52. P. INGRAO, La democrazia socialista è forza della rivoluzione, ivi, XXV (1968), n. 36.
53. FG, Apci, Direzione, Verbali, 4 ottobre 1968.
54. Ivi, 31 ottobre 1968.
55. Ivi, Estero, Urss, 1968, mf 058, 1015-45; e ivi, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 59. La delegazione italiana era composta da Berlinguer, Cossutta, Bufalini, Galluzzi e Colombi. Il resoconto di parte sovietica dell’incontro è pubblicato in «Istočnik», maggio 1994, pp. 77-86.
56. FG, Apci, Direzione, Verbali, 16 novembre 1968.
57. Ivi, 30 gennaio 1969; ivi, Estero, Urss, 1969, mf 58, 839-46; e L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 69, pp. 346-51.
58. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. I cit., p. 432; e F. BARBAGALLO, Enrico Berlinguer, Carocci, Roma 2006, pp. 23-24, 103.
59. XII Congresso del Partito comunista italiano. Atti e risoluzioni, Editori Riuniti, Roma 1969, p. 82.
60. BRACKE, Quale socialismo, quale distensione? cit., pp. 192-97.
61. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 78-79.
62. FG, Apci, Direzione, Verbali, 16 aprile 1969.
63. Ivi, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 81.
64. A. S. ČERNJAEV, Moja žizn′ i moe vremja, Meždunarodnye otnošenija, Moskva 1995, p. 271.
65. FG, Apci, Direzione, Verbali, 20 giugno 1969.
66. Ivi, 31 ottobre 1968.
67. XII Congresso del Partito comunista italiano cit., pp. 749, 758.
68. Si vedano i saggi di L. BALDISSARA, Tra governo e opposizione : il ruolo del PCI nella costruzione della democrazia in Italia, e di E. TAVIANI, Il PCI nella società dei consumi, in R. GUALTIERI (a cura di), Il PCI nell’Italia repubblicana, 1943-1991, Fondazione Istituto Gramsci, «Annali», XI (1999), Carocci, Roma 2001.
69. ROMERO, Storia della guerra fredda cit., pp. 196-98.
70. HOBSBAWM, Anni interessanti cit., p. 277.
71. L’Italia vista dal Cremlino cit., doc. 72, p. 361.
72. XII Congresso del Partito comunista italiano cit., pp. 423-24.
73. Sulla vicenda del «manifesto», si veda BRACKE, Quale socialismo, quale distensione? cit., pp. 230-33; e V. CASINI, Gli anni della contestazione. Il Sessantotto e la questione del «manifesto», in G. SORGONÀ (a cura di), Alessandro Natta intellettuale e politico. Ricerche e testimonianze, Ediesse, Roma 2019, pp. 63-80.
74. L. COMINELLI, L’Italia sotto tutela. Stati Uniti, Europa e crisi italiana degli anni Settanta, Le Monnier, Firenze 2014, pp. 126 sgg.
75. L. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. II, Con Berlinguer, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 493.
76. «Nota su nostra politica europeistica», in FG, Apci, Estero, Urss, mf 058, 891.
77. «Gli attuali sviluppi della lotta contro la Nato e per il superamento dei blocchi militari» [1969], ivi, Commissioni del Comitato centrale, mf 305, 403-33.
78. Ivi, Direzione, Verbali, 31 marzo - 1° aprile 1970.
79. Ivi, 8 gennaio 1971.
80. G. PANVINI, Thirdworldism in Italy, in S. BERGER e CH. CORNELISSEN (a cura di), Marxist Historical Cultures and Social Movements During the Cold War, Palgrave Macmillan, London 2019, pp. 289-308.
81. FG, Apci, Estero, Medio Oriente, 1970, mf 071, 281-88.
82. Ivi, Algeria, 1971, mf 162, 18-22, 26-36.
83. Ivi, Medio Oriente, 1970, mf 071, 302-5.
84. Ivi, 1971, mf 162, 1151-58.
85. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 388-91.
86. A. SANTONI, Il PCI e i giorni del Cile. Alle origini di un mito politico, Carocci, Roma 2008.
87. Nota di Sandri per il Presidente Allende, in FG, Apci, Estero, Cile, 1970, mf 70, 1445-58.
88. Ivi, 1971, mf 53, 1284-90.
89. Ivi, Direzione, Verbali, 8 settembre 1971.
90. Ivi, 29-30 settembre 1971.
91. G. AMENDOLA, I comunisti italiani e l’Europa, Editori Riuniti, Roma 1971.
92. FG, Apci, Direzione, Verbali, 31 gennaio - 1° febbraio 1973.
93. Ivi, Fondo Berlinguer, Movimento operaio internazionale, fasc. 109; ivi, Direzione, Allegati, 28 marzo 1973; e BARCA, Cronache dall’interno del vertice del Pci, vol. II cit., p. 547.
94. FG, Apci, Direzione, Verbali, 18 marzo 1973.
95. Si veda A. RUBBI, Il mondo di Berlinguer, Napoleone, Roma 1994, pp. 32-33; FG, Apci, Scritti e discorsi di Berlinguer, 26 gennaio 1974, mf 073, 384-99; e DI MAGGIO, Alla ricerca della terza via al socialismo cit., pp. 246-52.
96. FG, Apci, Direzione, Verbali, 19 febbraio 1974.
97. Ivi, Estero, Cile, 1973, mf 48, p. 304.
98. E. BERLINGUER, La proposta del compromesso storico, 12 ottobre 1973, in ID., La passione non è finita, a cura di M. Gotor, Einaudi, Torino 2013, pp. 42-54.
99. SANTONI, Il Pci e i giorni del Cile cit.
100. E. BERLINGUER, Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni, 28 settembre 1973, in ID., La passione non è finita cit., pp. 25-33.
101. ROMERO, Storia della guerra fredda cit., pp. 221-23.
102. CH. M. MAIER, «Malaise». The Crisis of Capitalism in the 1970s, in N. FERGUSON, CH. S. MAIER, E. MANELA e D. J. SARGENT (a cura di), The Shock of the Global. The 1970s in Perspective, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) - London 2010, pp. 25-48.
103. COMINELLI, L’Italia sotto tutela cit., pp. 171-72.
104. G. AMENDOLA, L’Europa nel ciclone, in «Rinascita», XXX (1973), n. 47.
105. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., pp. 451, 460.
106. MAZOWER, Governing the World cit., pp. 303-4.
107. GETACHEW, Worldmaking after Empire cit., pp. 170-71.
108. Gromiko: ogni paese ha diritto di disporre delle sue ricchezze, in «l’Unità», 12 aprile 1974.
109. FG, Apci, Estero, 1974, mf 080, 441-68.
110. Sull’analisi comunista della crisi del 1973 in Medio Oriente, si veda L. RICCARDI, L’internazionalismo difficile. La «Diplomazia» del Pci e il Medio Oriente dalla crisi petrolifera alla caduta del muro di Berlino (1973-1989), Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 36-77.
111. FG, Apci, Estero, 1974, mf 080, 441-68. Si veda G. CERVETTI, L’oro di Mosca. La testimonianza di un protagonista, Dalai, Milano 1993.
112. E. BERLINGUER, La proposta comunista. Relazione al Comitato centrale e alla Commissione centrale di controllo del partito comunista italiano in preparazione del XIV Congresso, Einaudi, Torino 1975.
113. GARAVINI, Dopo gli imperi cit., pp. 222-24.
114. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del Pci, vol. II cit., p. 583.
115. Ibid., p. 591.
116. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 18-19.
117. FG, Apci, Direzione, Verbali, 4 marzo 1975.
118. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 125-27.
119. Il dibattito al Comitato centrale, in «l’Unità», 5 luglio 1975.
120. FG, Apci, Estero, Iugoslavia, 1975, mf 204, 424.
121. Tendenze e problemi della vita internazionale, in «Rinascita», XXXII (1975), n. 6.
122. M. DEL PERO, La transizione portoghese, in M. DEL PERO, V. GAVÍN, F. GUIRAO e A. VARSORI, Democrazie. L’Europa meridionale e la fine delle dittature, Le Monnier, Firenze 2010, pp. 95-171.
123. N. P. LUDLOW, The Real Years of Europe? US-West European Relations during the Ford Administration, in «Journal of Cold War Studies» XV (2013), n. 3, pp. 136-61; e A. VARSORI, La cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 291-96.
124. FG, Apci, Note alla segreteria, 1975, mf 206, 262. Sul Pci e la Rivoluzione dei garofani in Portogallo, si veda S. PONS, Berlinguer e la fine del comunismo, Einaudi, Torino 2006, pp. 52-55.
125. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 125.
126. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., p. 174.
127. BORRUSO, Il Pci e l’Africa indipendente cit., pp. 136-54; e SIRACUSANO, La fine di un miraggio politico cit., pp. 557-67.
128. E. BERLINGUER, Il mondo è piú libero, in «l’Unità», 9 maggio 1975.
129. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 132; RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., p. 236; e SIRACUSANO, La fine di un miraggio politico cit., pp. 661-64.
130. Sulla Convenzione di Lomé, cfr. LORENZINI, Una strana guerra fredda cit., pp. 250-57; e K. K. PATEL, Project Europe. A History, Cambridge University Press, Cambridge 2018, pp. 253-55.
131. LORENZINI, The Socialist Camp and Economic Modernization in the Third World cit., pp. 355-56.
132. PONS, Berlinguer e la fine del comunismo cit., pp. 61-65.
133. FG, Apci, Direzione, Verbali, 23 aprile, 24 luglio, 26 settembre 1975.
134. Ivi, Fondo Berlinguer, Movimento operaio internazionale, fasc. 129.
135. Ivi, Direzione, Verbali, 21 novembre 1975.
136. Nara, RG 59, Kissinger’s Staff Meetings, 12 January 1975.
137. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., p. 471.
138. Nara, RG 59, Records of Henry A. Kissinger, 12 December 1975.
139. FG, Apci, Note alla segreteria, mf 201, 779-83, 10 gennaio 1975; e S. PONS, L’Italia e il Pci nella politica estera dell’Urss di Brezhnev, in A. GIOVAGNOLI e S. PONS (a cura di), L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta, vol. I, Tra guerra fredda e distensione, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 78-81.
140. Berlinguer: «We Are Not in a Hurry», in «Time Magazine», giugno 1975.
141. FG, Apci, Estero, Iugoslavia, 1975, b. 308, fasc. 195.
142. Ivi, Direzione, Verbali, 26 settembre 1975.
143. Ivi, 23 ottobre 1975.
144. FORMIGONI, Storia d’Italia nella guerra fredda cit., p. 471; e G. BARBERINI, Pagine di storia contemporanea. La Santa Sede alla Conferenza di Helsinki, Cantagalli, Siena 2010.
Capitolo sesto, Europeismo e globalismi.
1. BROGI, Confronting America, citato in F. HEURTEBIZE, Le péril rouge. Washington face à l’eurocommunisme, Puf, Paris 2014; e U. GENTILONI SILVERI, L’Italia sospesa. La crisi degli anni Settanta vista da Washington, Einaudi, Torino 2009.
2. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 131-34; S. PONS, The Rise and Fall of Eurocommunism, in M. P. LEFFLER e O. A. WESTAD (a cura di), The Cambridge History of the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge 2010, pp. 45-65; e L. FASANARO, Neither in One Bloc, Nor in the Other. Berlinguer’s Vision of the End of the Cold War, in F. BOZO, M.-P. REY, N. P. LUDLOW e B. ROTHER (a cura di), Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-1990, Berghahn, New York - Oxford 2012, pp. 163-76.
3. S. PONS e M. DI DONATO, Reform Communism, in FÜRST, PONS e SELDEN (a cura di), The Cambridge History of Communism. III. Endgames? cit., pp. 178-202; e V. STRAZZERI, Forging socialism through democracy. A critical survey of literature on Eurocommunism, in «Twentieth Century Communism», 2019, n. 17, pp. 26-66.
4. E. J. HOBSBAWM, The Great Gramsci, in «The New York Review of Books», XXI (1974), n. 5. Si veda R. J. EVANS, Eric Hobsbawm. A Life in History, Little Brown, London 2019, pp. 498-99.
5. Lottiamo per la costruzione di una società socialista nella libertà, nella democrazia, nella pace, Mosca, XXV Congresso del Pcus, 27 febbraio 1976, in BERLINGUER, La passione non è finita cit., pp. 77-82.
6. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 136; ivi, Direzione, Verbali, 5 marzo 1976; RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., p. 102; e M. PH. BRADLEY, Human Rights and Communism, in FÜRST, PONS e SELDEN (a cura di), The Cambridge History of Communism. III. Endgames? cit., pp. 160-62.
7. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Varie, fasc. 28.
8. G. NAPOLITANO, Intervista sul Pci, a cura di E. J. Hobsbawm, Laterza, Roma-Bari 1976.
9. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 175-77; RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., p. 125; e Il Pci, l’Europa, il socialismo, in «Rinascita», XXX (1976), n. 11.
10. Berlinguer conta “anche” sulla Nato per mantenere l’autonomia da Mosca, in «Corriere della Sera», 15 giugno 1976, ora in BERLINGUER, La passione non è finita cit., pp. 83-93.
11. A. VARSORI, Puerto Rico (1976). Le potenze occidentali e il problema comunista in Italia, in «Ventunesimo secolo», VII (2008), pp. 89-121; e D. BASOSI e G. BERNARDINI, The Puerto Rico Summit of 1976 and the End of Eurocommunism, in L. NUTI (a cura di), The Crisis of Détente in Europe. From Helsinki to Gorbachev, 1975-1985, Routledge, London 2009.
12. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 140.
13. PONS, Berlinguer e la fine del comunismo cit., pp. 84-90; e ČERNJAEV, Moja žizn′ i moe vremja cit., p. 345.
14. D. J. SARGENT, Superpower Transformed. The Remaking of American Foreign Relations in the 1970s, Oxford University Press, New York 2015, pp. 233-36. Si veda anche U. TULLI, Tra diritti umani e distensione. L’amministrazione Carter e il dissenso in Urss, FrancoAngeli, Milano 2013.
15. FG, Apci, Note alla segreteria, mf 0243, 24 settembre 1976.
16. A. CIULLA, L’Amministrazione Carter e la «questione comunista» in Italia: elaborazione e azione politica, 1976-1978, in «Italia contemporanea», 2020, n. 293, pp. 254-79.
17. R. N. GARDNER, Mission Italy. On the Front Lines of the Cold War, Rowman & Littlefield, Oxford 2005, p. 68.
18. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del Pci, vol. II cit., pp. 601-3.
19. F. CALAMANDREI, Le occasioni di vivere. Diari e scritti 1975-1982, La Nuova Italia, Firenze 1995, p. 78.
20. A. S. ČERNJAEV, Sovmestnyj ischod. Dnevnik dvuch epoch 1972-1991, Rosspen, Moskva 2008, p. 269.
21. S. SEGRE, A chi fa paura l’eurocomunismo?, Guaraldi, Rimini-Firenze 1977.
22. «Nota sull’incontro Ceaușescu-Berlinguer», 19 gennaio 1977, in FG, Apci, Note alla segreteria, 1977, mf 0288.
23. Ivi, mf 0309, 565-66.
24. Dichiarazione di intellettuali comunisti sulla Cecoslovacchia, in «l’Unità», 13 gennaio 1977.
25. FG, Apci, Direzione, Verbali, 26 gennaio 1977, mf 0288, 69.
26. Ivi, Estero, Urss, 1977, mf 0297, 1494-95.
27. Ivi, Direzione, Verbali, 16 febbraio 1977; e BARCA, Cronache dall’interno del vertice del Pci, vol. II cit., pp. 670-71.
28. FG, Apci, Estero, Urss, 1977, mf 0297, 1494-95; ČERNJAEV, Moja žizn′ i moe vremja cit., p. 349; e CH. ANDREW e V. N. MITROKHIN [MITROCHIN], L’archivio Mitrokhin. Le attività segrete del Kgb in occidente, Rizzoli, Milano 2000, p. 372.
29. L. FASANARO, La DDR e l’Italia. Politica, commercio e ideologia nell’Europa del cambiamento (1973-1985), Carocci, Roma 2016, pp. 170-72.
30. Rgani, f. 81, op. 1, d. 311; e FG, Apci, Note alla segreteria, 1977, mf 0299, 235-48.
31. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 149; e ivi, Note alla segreteria, 1977, mf 0304, 480-95.
32. Ivi, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 151.
33. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 108-14.
34. E. BERLINGUER, Austerità. Occasione per trasformare l’Italia. Conclusioni al convegno degli intellettuali, Roma, Teatro Eliseo, 15 gennaio 1977, ora in ID., La passione non è finita cit., pp. 7-22.
35. SARESELLA, Catholics and Communists in Twentieth-Century Italy cit., pp. 112-13.
36. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 192-93.
37. P. CRAVERI, L’arte del non governo. L’inesorabile declino della Repubblica italiana, Marsilio, Venezia 2016, pp. 324-27.
38. P. FERRARI, In cammino verso Occidente. Berlinguer, il PCI e la comunità europea negli anni ’70, Clueb, Bologna 2007, p. 230.
39. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. II cit., pp. 708-10.
40. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 148.
41. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 194-205.
42. «Nota riservata per Berlinguer e Pajetta», 4 novembre 1977, in FG, Apci, Note alla segreteria, 1977, mf 0309, 220-21.
43. GARDNER, Mission Italy cit., pp. 114-17, 143-44.
44. BROGI, Confronting America cit., pp. 338-45; e HEURTEBIZE, Le péril rouge cit., pp. 270-76.
45. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. II cit., pp. 716-17.
46. G. FORMIGONI, Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma, il Mulino, Bologna 2016, pp. 346-73.
47. M. GOTOR, Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano, Einaudi, Torino 2011.
48. G. M. CECI, Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito, Carocci, Roma 2013; e G. PANVINI, Cattolici e violenza politica. L’altro album di famiglia del terrorismo, Marsilio, Venezia 2014.
49. A. MORO, Lettere dalla prigionia, a cura di M. Gotor, Einaudi, Torino 2008, pp. 7-8, 29, 41, 171.
50. U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità. Storia di una democrazia incompiuta, Baldini&Castoldi, Milano 1995; e ANDREW e MITROKHIN, L’archivio Mitrokhin cit., p. 373.
51. S. PONS, Cold War Republic. The «External Constraint» in Italy During the 1970s, in A. VARSORI e B. ZACCARIA, Italy in the International System from Détente to the End of the Cold War. The Underrated Ally, Palgrave Macmillan, London 2018, pp. 34-67.
52. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Politica interna, fasc. 525.
53. Abbiamo aiutato il Paese a superare prove durissime. Dobbiamo rilanciare la nostra politica in tutto il suo significato rinnovatore, in «l’Unità», 25 luglio 1978.
54. Caro Berlinguer. Note e appunti riservati di Antonio Tatò a Enrico Berlinguer. 1969-1984, Einaudi, Torino 2003, p. 80.
55. V. LOMELLINI, L’appuntamento mancato. La sinistra italiana e il dissenso nei regimi comunisti (1968-1989), Le Monnier, Firenze 2010, pp. 113 sgg.
56. BERLINGUER, La passione non è finita cit., pp. 94-109.
57. NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo cit., pp. 158-59.
58. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 122-23.
59. FG, Apci, Direzione, Allegati, 19 ottobre 1978, 67-72, 78-82; ivi, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 157.2; RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 141-57; e S. PONS, Meetings between the Italian Communist Party and the Communist Party of the Soviet Union, Moscow and Rome, 1978-1980, in «Cold War History», III (2002), n. 1, pp. 157-66.
60. BARCA, Cronache dall’interno del vertice del PCI, vol. II cit., pp. 752-53. Cfr. PONS, Berlinguer e la fine del comunismo cit., pp. 135-40.
61. L’impegno del PCI per l’Europa, in «l’Unità», 5 dicembre 1978.
62. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., p. 220.
63. XV Congresso del Partito comunista italiano. Atti e risoluzioni, Editori Riuniti, Roma 1979, vol. I, p. 552.
64. Una riflessione critica seria e appassionata, in «l’Unità», 4 luglio 1979; e I capisaldi d’una strategia di rinnovamento, ivi, 7 luglio 1979.
65. SARGENT, Superpower Transformed cit., pp. 261 sgg.
66. MAIER, «Malaise» cit., pp. 42-44.
67. Nota di Sandri alla Direzione del Pci, 22 giugno 1977, in FG, Apc, Estero, 1977, b. 406, fasc. 203.
68. Relazione di Sandri alla Commissione per la cooperazione internazionale, 19 aprile 1978, ivi, 1978, b. 486, fasc. 83.
69. Relazione di Sandri sul rinnovo della Convenzione di Lomé, 12 giugno 1978, ivi, b. 468, fasc. 166.
70. Ivi, Note alla segreteria, 1978, mf 7808, 25-28.
71. WESTAD, The Global Cold War cit., pp. 203-6.
72. BORRUSO, Il PCI e l’Africa indipendente cit., pp. 235-39.
73. «Incontro a Mosca del 24.2.1978 con Ponomarëv», in FG, Apci, Estero, Urss, 1978, mf 7803, 213-16.
74. Ivi, Estero, Cuba, 1978, mf 7807, 64-66.
75. Ivi, Direzione, Allegati, 19 ottobre 1978, mf 7812, 79.
76. Caro Berlinguer cit., pp. 100-5.
77. XV Congresso del Partito comunista italiano cit., vol. I, pp. 31-34.
78. FG, Apci, Direzione, Verbali, 20 febbraio 1979.
79. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., p. 160.
80. FG, Apci, Direzione, Verbali, 16 ottobre 1979.
81. STRAZZERI, Forging Socialism Through Democracy cit., vol. I; e I. BALAMPANIDIS, Eurocommunism. From the Communist to the Radical European Left, Routledge, London - New York 2019.
82. CALAMANDREI, Le occasioni di vivere cit., p. 161.
83. FG, Apci, Direzione, Verbali, 4 gennaio 1980.
84. E. BERLINGUER, Discorsi parlamentari (1968-1984), a cura di M. L. Righi, Camera dei Deputati, Roma 2001, pp. 348-50.
85. FG, Apci, Estero, Urss, 1980, mf 8003, 394-408; e WESTAD, The Global Cold War cit., p. 286.
86. FG, Apci, Direzione, Verbali, 27 marzo 1980.
87. Nota di Rubbi per Berlinguer, Pajetta, Bufalini, 12 ottobre 1979, ivi, Estero, Iugoslavia, 1979, mf 7911, 0285-88; e Resoconto di una conversazione di Ottavio Cecchi con Grličkov, ivi, Note alla segreteria, 1980, mf 8102, 128-30.
88. «Nota sull’incontro Berlinguer-Brandt del 12 marzo 1980 a Strasburgo», ivi, Estero, Germania-Rft, 1980, mf 8005, 252-59; RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 244-45; e A. PANCALDI, Brandt e Berlinguer: ampio colloquio sulla crisi internazionale, in «l’Unità», 14 marzo 1980.
89. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 182-83; e ID., Appunti cinesi, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 101-50.
90. FG, Apci, Estero, Cina, 1980, mf 8005, 200-7.
91. Ivi, Direzione, Verbali, 6 maggio 1980.
92. Ivi, 9 settembre 1980.
93. A. ROCCUCCI, Il Concilio Vaticano II e l’elezione di Giovanni Paolo II. Mosca di fronte a due svolte dell’Ostpolitik, in MELLONI (a cura di), Il filo sottile cit., pp. 262-91.
94. FG, Apci, Estero, Polonia, 1980, mf 8012, 97-98; e ČERNJAEV, Sovmestnyj ischod cit., p. 429.
95. LOMELLINI, L’appuntamento mancato cit., p. 187.
96. FG, Apci, Estero, Urss, 1980, mf 8101, 137-48; e PONS, Meetings between the Italian Communist Party and the Communist Party of the Soviet Union cit.
97. E. SERVENTI LONGHI, Solidarity and Italian Labor Movement Culture: CGIL Intellectuals and Revision of the CGIL’s International Relations (1980-1982), in A. GUISO e A. TARQUINI (a cura di), Italian Intellectuals and International Politics, 1945-1992, Palgrave Macmillan, London 2019, pp. 243-47. Cfr. PAJETTA, Le crisi che ho vissuto cit., pp. 169-70.
98. FG, Apci, Direzione, Verbali, 5 febbraio 1981.
99. E. SCALFARI, Dove va il Pci? Intervista a Berlinguer, in «la Repubblica», 28 luglio 1981, ora con il titolo Che cos’è la questione morale, in BERLINGUER, La passione non è finita cit., pp. 133-55; FG, Apci, Direzione, Verbali, 10 settembre 1981; e NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo cit., pp. 166-69.
100. Caro Berlinguer cit., pp. 187-92.
101. FG, Apci, Direzione, Verbali, 5 febbraio 1981.
102. Ivi, Centro Studi di Politica Internazionale, b. 2630.
103. Pace e sviluppo cardini della lotta per un nuovo assetto mondiale, in «l’Unità», 6 ottobre 1981.
104. FG, Apci, Direzione, Verbali, 26 novembre 1981, mf 8205.
105. Conversazioni con Berlinguer cit., p. 271.
106. J. FÜRST e S. V. BITTNER, The Aging Pioneer. Late Soviet Socialist Society, Its Challenges and Challengers, in PONS (a cura di), The Cambridge History of Communism. III. Endgames? cit., pp. 295 sgg.
107. Caro Berlinguer cit., pp. 227-41
108. FG, Apci, Direzione, Verbali, 22 dicembre 1981.
109. Aprire una nuova fase della lotta per il socialismo, in «l’Unità», 30 dicembre 1981.
110. La critica, la ricerca, l’azione del PCI nascono dall’impegno di aprire in Europa una fase nuova nella lotta per il socialismo, in «l’Unità», 12 gennaio 1982.
111. FG, Apci, Direzione, Verbali, 18 gennaio 1982. Per una ricostruzione dello «strappo» tra il PCI e Mosca, si veda PONS, Berlinguer e la fine del comunismo cit.
112. ČERNJAEV, Moja žizn′ i moe vremja cit., pp. 431-32.
113. ID., Sovmestnyj ischod cit., pp. 468-69.
114. Fond Gorbačëva, f. 3, op. 1, k. 15064.
115. La critica, la ricerca, l’azione del PCI cit.
116. BROGI, Confronting America cit., pp. 367 sgg.
117. FG, Apci, Estero, Francia, 1982, mf 8210, 183-86; e ivi, Direzione, Verbali, 2 aprile 1982.
118. DI DONATO, I comunisti italiani e la sinistra europea cit., pp. 265 sgg.
119. XVI Congresso del Partito comunista italiano. Atti risoluzioni documenti, Editori Riuniti, Roma 1983, pp. 24-25. Cfr. GUALTIERI, L’Italia dal 1943 al 1992 cit., pp. 224-25.
120. «Nota sulle esposizioni di Grličkov, Minić e Mojsov (Belgrado, 18-19 febbraio 1981)», in FG, Apci, Note alla segreteria, mf 8103, 39-49.
121. Ivi, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 174; e RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 247-71.
122. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 281-95.
123. GARAVINI, Dopo gli imperi cit., p. 308.
124. FG, Apci, Fondo Berlinguer, Serie Movimento operaio internazionale, fasc. 174.
125. Ivi, Note alla segreteria, 1980, mf 8012, 64-73.
126. Salati alla segreteria, ivi, Estero, Algeria, 1981, mf 507, 3166-73; e BORRUSO, Il PCI e l’Africa indipendente cit., pp. 118-19.
127. FG, Apci, Note alla segreteria, mf 8207, 200-206, 5 luglio 1982.
128. LORENZINI, Una strana guerra fredda cit., pp. 262-66.
129. RICCARDI, L’internazionalismo difficile cit., pp. 503-7.
130. RUBBI, Il mondo di Berlinguer cit., pp. 295-308.
131. A. REICHLIN, Begin non Israele, in «Rinascita», XXXIX (1982), n. 37. Cfr. RICCARDI, L’internazionalismo difficile cit., pp. 534-35.
132. FG, Apci, Estero, Algeria, 1983, mf 8301, 22-30.
133. Ivi, Note alla segreteria, 1983, mf 8302, 26-34.
134. Ivi, mf 8303, 18 febbraio 1983.
135. Ivi, Allegati ai verbali di Direzione, 1983, mf 8403, 115-22, 16 agosto 1983; e RUBBI, Appunti cinesi cit., pp. 169-203.
136. COSSUTTA, Una storia comunista cit., pp. 124-25.
137. BERLINGUER, Discorsi parlamentari cit., pp. 298-304.
138. FG, Apci, Note alla segreteria, 1983, mf 8311, 103-15.
139. Acuta tensione tra Usa e Urss. Berlinguer: una piú forte iniziativa di pace per fermare la terribile spirale dei missili, in «l’Unità», 26 novembre 1983.
140. FG, Apci, Direzione, Verbali, 5 gennaio 1984.
141. Obiettivi: pace, sviluppo, riforme. Cosí il PCI affronta l’appuntamento delle elezioni europee. L’intervento del compagno Berlinguer, in «l’Unità», 12 gennaio 1984.
142. FG, Apci, Note alla segreteria, 1983, mf 8405, 22-42.
143. E. DI NOLFO (a cura di), La politica estera italiana negli anni ottanta, Marsilio, Venezia 2003.
144. FG, Apci, Note alla segreteria, 1983, mf 8405, 1-21, 12 dicembre 1983; e FASANARO, La DDR e l’Italia cit., pp. 190-94.
145. FG, Apci, Direzione, Verbali, 15 dicembre 1983.
146. M. D’ALEMA, A Mosca l’ultima volta. Enrico Berlinguer e il 1984, Donzelli, Roma 2004.
147. L’intervento di Enrico Berlinguer, in «l’Unità», 28 aprile 1984.
148. L’Europa, la pace, lo sviluppo. Intervista a Critica marxista di Enrico Berlinguer, in «Critica marxista», XXII (1984), nn. 1-2, pp. 5-19.
149. PONS, La rivoluzione globale cit., pp. 384-87.
150. CH. S. MAIER, Thirty Years After. The End of European Communism in Historical Perspective, in PONS (a cura di), The Cambridge History of Communism. III. Endgames? cit., pp. 600-21; e JUDT, Postwar cit., pp. 535-58 [trad. it. cit., pp. 661-90].
Epilogo, Il sogno di un nuovo ordine mondiale (1985-1991).
1. M. S. GORBAČËV, Žizn′ i reformy, 2 voll., Novosti, Moskva 1995, vol. I, pp. 255-56.
2. A. S. ČERNJAEV, Šest′ let s Gorbačëvym, Progress-Kultura, Moskva 1993, pp. 15-16.
3. A. RUBBI, Incontri con Gorbaciov. I colloqui di Natta e Occhetto con il leader sovietico, Editori Riuniti, Roma 1990, p. 26.
4. A. BROWN, The Gorbachev Factor, Oxford University Press, Oxford 1996, p. 75; e J. LÉVESQUE, The Enigma of 1989. The USSR and the Liberation of Eastern Europe, University of California Press, Berkeley 1997, pp. 19-21.
5. FG, Apci, Segreteria, 1985, mf 8505, 150-156.
6. Ivi, Direzione, Verbali, 20 marzo 1985.
7. BOFFA, Memorie dal comunismo cit., pp. 222-23.
8. CERVETTI, Compagno del secolo scorso cit., pp. 303-4.
9. G. PETRACCHI, L’Italia e la Ostpolitik, in DI NOLFO (a cura di), La politica estera italiana negli anni ottanta cit., pp. 271-93; e S. TAVANI, L’Ostpolitik italiana nella politica estera di Andreotti, in M. BARONE e E. DI NOLFO (a cura di), Giulio Andreotti. L’uomo, il cattolico, lo statista, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 243-304.
10. RUBBI, Incontri con Gorbaciov cit., pp. 78 sgg.
11. FG, Apci, Segreteria, 1986, mf 8605, 132-157.
12. Ivi, Direzione, Verbali, 4 febbraio 1986.
13. Sul significato della catastrofe di Černobyl′ per la scelta riformatrice di Gorbačëv e la nozione di glasnost′, si veda GORBAČËV, Žizn′ i reformy, vol. I cit.
14. FG, Apci, Esteri, 1986, mf 8905, 9-15.
15. R. SERVICE, The End of the Cold War 1985-1991, Macmillan, London 2015, pp. 209-18; e R. ENGLISH, Russia and the Idea of the West. Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War, Columbia University Press, New York 2000, p. 223.
16. La gente chiede: «Non fermate la perestrojka». Il colloquio di Gorbaciov con Gerardo Chiaromonte, Renzo Foa e Giulietto Chiesa, in «l’Unità», 20 maggio 1987; e RUBBI, Incontri con Gorbaciov cit., pp. 120-21.
17. Verbale degli incontri di Natta con Vidoje Žarković, Chérif Messaadia del Flna e Al-Qaddoumi dell’Olp, 27 giugno 1986, in FG, Apci, mf 8607, 45-49.
18. Resoconto della visita di Natta in Cina (13-18 ottobre 1985), ivi, mf 0579, 1425-42; e RUBBI, Appunti cinesi cit., 205-39.
19. Verbale dell’incontro della delegazione del Pci con Hu Yaobang, Roma, 21 giugno 1986, in FG, Apci, mf 8607, 23-29; e RUBBI, Appunti cinesi cit., pp. 241-57.
20. CH. JIAN, China’s Changing Policies toward the Third World and the End of the Global Cold War, in A. M. KALINOVSKY e S. RADCHENKO (a cura di), The End of the Cold War and the Third World. New Perspectives on regional conflict, Routledge, London - New York 2011, pp. 101-21.
21. NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo cit., pp. 220-23; e CERVETTI, Compagno del secolo scorso cit., p. 274.
22. Nota di Segre per la segreteria, 26 marzo 1986, in FG, Apci, mf 8603, 166-68.
23. Verbale degli incontri di Natta con Kádár e Szűrös, 3 ottobre 1986, ivi, mf 8610, 211-26.
24. Verbale dell’incontro di Natta con Jaruzelski, 13 gennaio 1987, ivi, mf 8702, 27-29; e Rendiconto del viaggio di Natta in Rdt, Finlandia e Svezia, febbraio 1987, ivi, Antonio Rubbi, mf 8704, 73-112.
25. ČERNJAEV, Šest′ let s Gorbačëvym cit., p. 141.
26. FG, Apci, Direzione, Verbali, 22 ottobre 1987.
27. V Politbjuro TsK KPSS. Po zapisami Anatolija Černjaeva, Vadima Medvedeva, Georgija Šachnazarova (1985-1991), Al′pina Biznes Books, Moskva 2006, p. 273.
28. A. POSSIERI, Il peso della storia. Memoria, identità, rimozione dal Pci al Pds 1970-1991, il Mulino, Bologna 2007, pp. 173-74, 198.
29. FG, Apci, Direzione, Verbali, 16-17 novembre 1987.
30. NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo cit., p. 233.
31. Fond Gorbačëva, f. 3, op. 1, k. 7125.
32. RUBBI, Incontri con Gorbaciov cit., p. 196; e NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo cit., p. 230.
33. Verbale di Renato Sandri dell’incontro tra la delegazione del Pcus e la delegazione del Pci, Mosca 29 marzo 1988, in FG, Apci, Estero, Urss.
34. V Politbjuro CK KPSS cit., p. 312.
35. SERVICE, The End of the Cold War cit., pp. 298-300.
36. BOFFA, Memorie dal comunismo cit., p. 224.
37. Fond Gorbačëva, f. 2, op. 1, k. 1163.
38. FG, Apci, Esteri, 19 luglio 1988; e ivi, 23 dicembre 1988.
39. Ivi, Direzione, Verbali, 13-14 ottobre 1988.
40. V Politbjuro CK KPSS cit., p. 420; e SERVICE, The End of the Cold War cit., pp. 356-57.
41. V Politbjuro CK KPSS cit., p. 375.
42. WESTAD, The Global Cold War cit., pp. 364 sgg.; e S. SAVRANSKAYA, Gorbachev and the Third World, in KALINOVSKY e RADCHENKO (a cura di), The End of the Cold War and the Third World cit., pp. 21-45.
43. J. MARK, B. C. IACOB, T. RUPPRECHT e L. SPASKOVSKA, 1989. A Global History of Eastern Europe, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2019, pp. 40-41.
44. PATEL, Project Europe cit., pp. 166 sgg.
45. FG, Apci, Estero, Urss, 11 gennaio 1989.
46. F. DI PALMA (a cura di), Perestrojka and the Party. National and Transnational Perspectives on European Communist Parties in the Era of Soviet Reform, Berghahn, New York - Oxford 2019.
47. Colloquio con Brandt, gennaio 1989, in FG, Apci, Giorgio Napolitano, mf 8904, 284-89; e Nota sugli incontri di Bonn con la delegazione della Spd, 23 febbraio 1989, ivi, Antonio Rubbi, mf 8904, 243-47.
48. Verbale dell’incontro di Occhetto con Gorbačëv, Mosca 28 febbraio 1989, ivi, Estero, Urss.
49. ČERNJAEV, Šest′ let s Gorbačëvym cit., p. 282.
50. FG, Apci, Direzione, Verbali, 6 marzo 1989.
51. Ivi, 28 aprile 1989.
52. Ivi, 5 luglio 1989.
53. S. KOTKIN, Armageddon Averted. The Soviet Collapse 1970-2000, Oxford University Press, Oxford - New York 2008. Cfr. anche S. PONS e F. ROMERO (a cura di), Reinterpreting the End of the Cold War. Issues, interpretations, periodizations, Frank Cass, London 2005.
54. S. KOTKIN, Uncivil Society. 1989 and the Implosion of the Communist Establishment, Modern Library, New York 2010.
55. P. FASSINO, Per passione, Rizzoli, Milano 2003, pp. 183-88.
56. FG, Apci, Direzione, Verbali, 14-15 novembre 1989.
57. ČERNJAEV, Sovmestnyj ischod cit., p. 818.
58. A. VARSORI, L’Italia e la fine della guerra fredda. La politica estera dei governi Andreotti (1989-1992), il Mulino, Bologna 2013.
59. RUBBI, Incontri con Gorbaciov cit., pp. 284-86.
60. Ibid., p. 295.
61. Fond Gorbačëva, f. 2, op. 1, k. 8161.
62. LÉVESQUE, The Enigma of 1989 cit., pp. 210-11.
63. BOFFA, Memorie dal comunismo cit., p. 233.
64. La relazione di Occhetto al Comitato centrale, in «l’Unità», 24 luglio 1990.
65. Nota di Giuseppe Boffa sull’incontro con Gorbačëv, 15 novembre 1990, in FG, Apci, Estero, Urss.
66. ČERNJAEV, Šest′ let s Gorbačëvym cit., p. 379.
67. A. OCCHETTO, La lunga eclissi. Passato e presente del dramma della sinistra, Sellerio, Palermo 2018. Per una lettura risalente all’epoca, si veda G. VACCA, La sfida di Gorbaciov. Guerra e pace nell’era globale, con la collaborazione di G. Fiocco, Salerno, Roma 2019.
68. PONS e DI DONATO, Reform Communism cit., pp. 178-202.
69. NAPOLITANO, Dal Pci al socialismo europeo cit., p. 228.
70. PATEL, Project Europe cit., pp. 271-72.
Indice dei nomi
- Adenauer, Konrad Hermann Joseph.
- Adibekov, Grant Mkrtyčevič.
- Aga Rossi, Elena.
- Agosti, Aldo.
- Albeltaro, Marco.
- Alicata, Mario.
- Ali Yata.
- Allende Gossens, Salvador Guillermo.
- Amendola, Giorgio.
- Andreotti, Giulio.
- Andreucci, Franco.
- Andrew, Christopher.
- Andropov, Jurij Vladimirovič.
- Anghelone, Francesco.
- Antonioli, Maurizio.
- Aquila, Giulio (Gyula Sas, pseudonimo di Julius Spitz).
- ʿArafāt, Yāsser.
- Badoglio, Pietro.
- Bagnato, Bruna.
- Bahr, Egon Karl-Heinz.
- Balampanidis, Ioannis.
- Baldissara, Luca.
- Barbagallo, Francesco.
- Barberini, Giovanni.
- Barbusse, Henri.
- Barca, Luciano.
- Baris, Tommaso.
- Barone, Mario.
- Basosi, Duccio.
- Bassi, Giulia.
- Basso, Lelio.
- Bauer, Leo.
- Bauer, Otto.
- Begin, Menahem Wolfovitch.
- Beltran, Alain.
- Ben Bella, Ahmed.
- Bendjedid, Chadli.
- Bergamaschi, Myriam.
- Berger, Stefan.
- Berija, Lavrentij Pavlovič.
- Berlinguer, Enrico.
- Bernardi, Emanuele.
- Bernardini, Dino.
- Bernardini, Giovanni.
- Bertelli, Sergio.
- Berti, Giuseppe.
- Bettanin, Fabio.
- Bianchini, Stefano.
- Bianco, Vincenzo.
- Bidussa, David.
- Bierut, Bolesław.
- Bini, Elisabetta.
- Biscione, Francesco M.
- Bittner, Stephen V.
- Bizcarrondo, Marta.
- Blackmer, Donald.
- Blagoeva, Stella.
- Boarelli, Mauro.
- Boffa, Giuseppe.
- Bogomolov, Aleksandr Efremovič.
- Bongiovanni, Bruno.
- Bordiga, Amadeo.
- Borruso, Paolo.
- Boumedienne, Houari (Mohammed Ben Brahim Boukharouba).
- Boussière, Eric.
- Bozo, Frédéric.
- Bracke, Maud.
- Bradley, Mark Philip.
- Brandt, Willy (Herbert Ernst Karl Frahm).
- Brazzoduro, Andrea.
- Brežnev, Leonid Il′íč.
- Briand, Aristide.
- Brillanti, Claudio.
- Brogi, Alessandro.
- Browder, Earl.
- Brown, Archie.
- Brutens, Karen.
- Brzezinski, Zbigniew.
- Bucharin, Nikolaj Ivanovič.
- Bufalini, Paolo.
- Byrnes, Jeffrey James.
- Cabral, Amílcar Lopes da Costa.
- Calamandrei, Franco.
- Calchi Novati, Giampaolo.
- Cammarano, Fulvio.
- Candreva, Gino.
- Caprara, Maurizio.
- Caprioglio, Sergio.
- Capuzzo, Paolo.
- Carioti, Antonio.
- Carr, Edward Hallett.
- Carrillo Solares, Santiago José.
- Carter, James Earl Carter jr, detto Jimmy.
- Casaroli, Agostino.
- Casini, Valentina.
- Cassani, Cinzia.
- Castro Ruz, Fidel Alejandro.
- Cattaruzza, Marina.
- Ceauşescu, Nicolae.
- Ceci, Giovanni Mario.
- Cerchia, Giovanni.
- Černenko, Konstantin Ustinovič.
- Černjaev, Anatolij Sergeevič.
- Cervetti, Giovanni.
- Chase, William J.
- Cheysson, Claude.
- Chiang Kai-shek.
- Chiaromonte, Gerardo.
- Chruščëv, Nikita Sergeevič.
- Cicalini, Antonio.
- Ciliberto, Michele.
- Ciulla, Alice.
- Clementi, Marco.
- Cocchi, Armando.
- Codovilla, Victorio.
- Colarizi, Simona.
- Collotti, Enzo.
- Colombi, Arturo Raffaello.
- Colozza, Roberto.
- Cominelli, Lucrezia.
- Congiu, Massimo.
- Connelly, Matthew.
- Conrad, Sebastian.
- Cooke, Philip.
- Cornelissen, Christoph.
- Corsini, Gianfranco.
- Corvalán Lepe, Luis Nicolás.
- Cossutta, Armando.
- Crainz, Guido.
- Craveri, Piero.
- Craxi, Benedetto, detto Bettino.
- Croce, Benedetto.
- Churchill, Winston Leonard Spencer.
- Cucchi, Aldo.
- Cunhal, Álvaro.
- D’Alema, Massimo.
- D’Alessandro, Leonardo Pompeo.
- Dallin, Alexander.
- Daniele, Chiara.
- Datta Gupta, Sobhanlal.
- D’Attorre, Pier Paolo.
- De Felice, Franco.
- De Gasperi, Alcide.
- De Gaulle, Charles-André-Joseph-Marie.
- Degl’Innocenti, Maurizio.
- Del Pero, Mario.
- De Martino, Francesco.
- Deng Xiaoping.
- De Nicolò, Marco.
- Díaz Ramos, José.
- Di Biagio, Anna.
- Di Donato, Michele.
- Đilas, Milovan.
- Di Maggio, Marco.
- Dimitrov, Georgi Mihajlov.
- Di Nolfo, Ennio.
- Di Palma, Francesco.
- Di Vittorio, Giuseppe.
- Dobrynin, Anatolij Fëdorovič.
- Donini, Ambrogio.
- D’Onofrio, Edoardo.
- Dos Santos, Marcelino.
- Dozza, Giuseppe.
- Dragostinova, Theodora.
- Drew, Allison.
- Dubček, Alexander.
- Duclos, Jacques.
- Ducoulombier, Romain.
- Dullin, Sabine.
- Dundovich, Elena.
- Dunn, James Clement.
- Eastman, Max F.
- Ebert, Friedrich.
- Ehmke, Horst Paul August.
- Eisenhower, Dwight D.
- Eley, Geoff.
- Ellwood, David W.
- Elorza, Antonio.
- Engels, Friedrich.
- English, Robert.
- Ercoli, vedi Togliatti, Palmiro.
- Evans, Richard J.
- Fanfani, Amintore.
- Fanon, Frantz.
- Fasanaro, Laura.
- Fassino, Piero.
- Ferrari, Paolo.
- Fidelis, Malgorzata.
- Fincardi, Marco.
- Fiocco, Gianluca.
- Fioravanzo, Monica.
- Firsov, Fridrikh Igorevich.
- Fischer, Ernst.
- Foa, Lisa.
- Focardi, Filippo.
- Ford, Gerald Rudolph jr (Leslie Lynch King jr).
- Forgacs, David.
- Forlani, Arnaldo.
- Forlenza, Rosario.
- Formigoni, Guido.
- Fortichiari, Bruno.
- Francioni, Gianni.
- Franco Bahamonde, Francisco.
- Franke, Egon.
- Friedman, Jeremy.
- Fumian, Carlo.
- Fursenko, Aleksandr.
- Fürst, Juliane.
- Gaddis, John Lewis.
- Gagliardi, Alessio.
- Galeazzi, Marco.
- Galli Della Loggia, Ernesto.
- Galluzzi, Carlo.
- Garavini, Giuliano.
- Gardner, Richard N.
- Gavín, Víctor.
- Gentile, Emilio.
- Gentiloni Silveri, Umberto.
- Gerratana, Valentino.
- Gerwarth, Robert.
- Getachew, Adom.
- Giardina, Andrea.
- Giasi, Francesco.
- Gibianskij, Leonid.
- Gierek, Edward.
- Giolitti, Antonio.
- Giolitti, Giovanni.
- Giovagnoli, Agostino.
- Giovanni XXIII, papa (Angelo Giuseppe Roncalli).
- Giovanni Paolo II, papa (Karol Józef Wojtyła).
- Gismondi, Arturo.
- Giusti, Maria Teresa.
- Goebel, Michael.
- Goedde, Petra.
- Gomułka, Władysław.
- Gorbačëv, Michail Sergeevič.
- Gori, Francesca.
- Gotor, Miguel.
- Gozzini, Giovanni.
- Gramsci, Antonio.
- Gramsci, Gennaro.
- Graziosi, Andrea.
- Grieco, Ruggero.
- Gromyko, Andrej Andreevič.
- Gronchi, Giovanni.
- Gruppi, Luciano.
- Gualtieri, Roberto.
- Guercetti, Emanuela.
- Guevara, Ernesto, detto il Che.
- Guirao, Fernando.
- Guiso, Andrea.
- Gundle, Stephen.
- Habeck, Mary R.
- Haslam, Jonathan.
- Haynes, John Earl.
- Hershberg, James.
- Heurtebize, Frédéric.
- Hilferding, Rudolf.
- Hilger, Andreas.
- Hitler, Adolf.
- Höbel, Alexander.
- Hobsbawm, Eric J.
- Hoffmann, Stanley.
- Honecker, Erich Ernst Paul.
- Hoxha, Enver Halil.
- Hua Guofeng.
- Humbert-Droz, Jules.
- Hu Yaobang.
- Iacob, Bogdan C.
- Iandolo, Alessandro.
- Ibárruri Gómez, Dolores.
- Imlay, Talbot C.
- Ingrao, Pietro.
- Iotti, Leonilde, detta Nilde.
- Iriye, Akira.
- Jarausch, Konrad H.
- Jaruzelski, Wojciech Witold.
- Jaurès, Jean.
- Jian, Chen.
- Johnson, Lyndon B.
- Jospin, Lionel.
- Judin, Pavel Fëdorovič.
- Judt, Tony.
- Jurenev, Konstantin Konstantinovič.
- Kádár, János (János József Czermanik).
- Kaganovič, Lazar′ Moiseevič.
- Kalinovsky, Artemy M.
- Kalter, Christoph.
- Kamenev, Lev Borisovič (Lev Borisovič Rozenfel′d).
- Kania, Stanisław.
- Kapp, Wolfgang.
- Kardelj, Edvard.
- Karlsen, Patrick.
- Karner, Stefan.
- Katayama, Sen.
- Kautsky, Karl Johann.
- Kellogg, Frank B.
- Kennan, George Frost.
- Kennedy, John Fitzgerald.
- Kershaw, Ian.
- Keržencev, Platon Michajlovič (Platon Michajlovič Lebedev).
- Kirilenko, Andrej Pavlovič.
- Kirov, Sergej Mironovič.
- Kirschenbaum, Lisa A.
- Kissinger, Henry (Heinz) Alfred.
- Klehr, Harvey.
- Knorin, Vilhelms.
- Kolarov, Vasil Petrov.
- Kostov, Trajčo.
- Kostylev, Michail Alekseevič.
- Kosygin, Aleksej Nikolaevič.
- Kotkin, Stephen.
- Kozlov, Frol Romanovič.
- Kozyrev, Semën Pavlovič.
- Kreisky, Bruno.
- Kun, Béla (Ábel Kohn).
- Kuusinen, Otto Wilhelm.
- Labanca, Nicola.
- Lange, Peter.
- LaPalombara, Joseph.
- La Pira, Giorgio.
- Lazar, Marc.
- Ledda, Romano.
- Le Duan.
- Leffler, Melvyn P.
- Lenin, Vladimir (Vladimir Il′ič Ul′janov).
- Leonetti, Alfonso.
- Lévesque, Jacques.
- Lill, Johannes.
- Litvinov, Maksim Maksimovič.
- Liu Shaoqui.
- Lomellini, Valentine.
- Longo, Luigi.
- Lorenzini, Sara.
- Löwenthal, Richard.
- Ludlow, N. Piers.
- Lumumba, Patrice Émery.
- Lupo, Salvatore.
- Lussana, Fiamma.
- Lüthi, Lorenz M.
- Macaluso, Emanuele.
- Macciocchi, Maria Antonietta.
- Maggiorani, Mauro.
- Magnani, Valdo.
- Magri, Lucio.
- Maier, Charles S.
- Makar, Aleksandr.
- Malenkov, Georgij Maksimilianovič.
- Malice, Teresa.
- Mandela, Nelson Rolihlahla.
- Manela, Erez.
- Manuiłskij, Dmitrij Zacharovič.
- Mao Zedong.
- Marchais, Georges.
- Mariuzzo, Andrea.
- Mark, James.
- Marković, Ante.
- Martinelli, Renzo.
- Martini, Magda.
- Martini, Rigoletto.
- Marty, André.
- Marx, Karl.
- Mattei, Enrico.
- Matteotti, Giacomo.
- Mattone, Antonello.
- Mazov, Sergey.
- Mazower, Mark.
- Mazowiecki, Tadeusz.
- McAdams, A. James.
- Melloni, Alberto.
- Mènghistu, Hailé Mariam.
- Mistry, Kaeten.
- Mitrochin, Vasilij Nikitič.
- Mitterrand, François.
- Mlynář, Zdeněk.
- Mollet, Guy.
- Molotov, Vjačeslav Michajlovič.
- Mondini, Teresa.
- Monina, Giancarlo.
- Montagnana, Rita.
- Morgan, Kevin.
- Moro, Aldo.
- Moskvin, Michail, vedi Trilisser, Michail Abramovič.
- Muehlenbeck, Philip.
- Münzenberg, Wilhelm, detto Willi.
- Mussolini, Benito.
- Naftali, Timothy.
- Nagy, Imre.
- Naimark, Norman.
- Napolitano, Giorgio.
- Nasser (Jamāl ʿAbd al-Nāṣir Ḥusayn).
- Natoli, Claudio.
- Natta, Alessandro.
- Navrátil, Jaromíl.
- Negarville, Celeste.
- Negrín López, Juan.
- Nehru, Jawāharlāl.
- Nenni, Pietro.
- Neumann, Matthias.
- Nevežin, Vladimir Aleksandrovič.
- Nin Pérez, Andrés.
- Nixon, Richard Milhous.
- Nkrumah, Kwame (Francis Nwia-Kofi Ngonloma).
- Noce, Teresa.
- Nuti, Leopoldo.
- Occhetto, Achille.
- Orlov, Aleksandr Michajlovič.
- Orsina, Giovanni.
- Ortega Saavedra, Daniel José.
- Pacini, Giacomo.
- Paggi, Leonardo.
- Pajetta, Giancarlo.
- Pajetta, Giuliano.
- Palme, Sven Olof Joachim.
- Pancaldi, Augusto.
- Pankhurst, Sylvia.
- Panvini, Guido.
- Papandreou, Andreas Georgios.
- Pappagallo, Onofrio.
- Patel, Kiran Klaus.
- Patriarca, Silvana.
- Pavolini, Luca.
- Pavone, Claudio.
- Pecchioli, Ugo.
- Pedrazzi, Nicola.
- Pella, Giuseppe.
- Pertini, Alessandro, detto Sandro.
- Petracchi, Giorgio.
- Pieck, Wilhelm.
- Pietromarchi, Luca.
- Piłsudski, Józef Klemens.
- Pinochet Ugarte, Augusto José Ramón.
- Pintor, Luigi.
- Pivato, Marco.
- Pivato, Stefano.
- Pjatnickij, Osip Aronovič.
- Podgornyj, Nikolaj Viktorovič.
- Pollitt, Harry.
- Ponomarëv, Boris Nikolaevič.
- Pons, Silvio.
- Portillo y Pacheco, José López.
- Possieri, Andrea.
- Procacci, Giuliano.
- Prozumenščikov, Michail.
- Prunas, Renato.
- Purman, Leon.
- Quagliariello, Gaetano.
- Quinn-Judge, Sophie.
- Radchenko, Sergey.
- Radek, Karl Berngardovič (Karol Sobelsohn).
- Radosh, Ronald.
- Ragionieri, Ernesto.
- Rajk, László.
- Rákosi, Mátyás (Mátyás Rosenfeld).
- Ranzato, Gabriele.
- Rapone, Leonardo.
- Ravazzoli, Paolo.
- Ravera, Camilla.
- Reagan, Ronald Wilson.
- Reale, Eugenio.
- Reichlin, Alfredo.
- Renton, David.
- Rey, Marie-Pierre.
- Riall, Lucy.
- Riccardi, Andrea.
- Riccardi, Luca.
- Rieber, Alfred J.
- Righi, Maria Luisa.
- Riva, Valerio.
- Roasio, Antonio.
- Robotti, Paolo.
- Roccucci, Adriano.
- Rochet, Waldeck.
- Rockefeller, David.
- Rodano, Franco.
- Rolland, Romain.
- Romano, Andrea.
- Romero, Federico.
- Roosevelt, Franklin Delano.
- Rossanda, Rossana.
- Rother, Bernd.
- Roy, M. N. (Manabendra Nath Bhattacharya).
- Rubbi, Antonio.
- Ruivo, Mário João de Oliveira.
- Rupprecht, Tobias.
- Ruscio, Alain.
- Sacharov, Andrej Dmitrievič.
- Sachsenmaier, Dominic.
- Sadat, Muḥammad Anwar al-.
- Salacone, Alessandro.
- Salati, Remo.
- Sandri, Renato.
- Santoni, Alessandro.
- Santucci, Antonio A.
- Sapelli, Giulio.
- Saresella, Daniela.
- Sargent, Daniel J.
- Sartre, Jean-Paul.
- Sas, Gyula, vedi Aquila, Giulio.
- Sassoon, Donald.
- Savranskaya, Svetlana.
- Scalfari, Eugenio.
- Scelba, Mario.
- Schlesinger, Arthur.
- Schmidt, Helmut Heinrich Waldemar.
- Schucht, famiglia.
- Schucht, Julija.
- Scirocco, Giovanni.
- Scoccimarro, Mauro.
- Scoppola Iacopini, Luigi.
- Scroccu, Gianluca.
- Secchia, Matteo.
- Secchia, Pietro.
- Segre, Sergio.
- Selden, Mark.
- Senghor, Léopold Sédar.
- Seniga, Giulio.
- Sereni, Emilio.
- Serge, Victor.
- Serra, Maurizio.
- Serrati, Giacinto Menotti.
- Serventi Longhi, Enrico.
- Service, Robert.
- Settis, Bruno.
- Ševljagin, Dmitrij.
- Sevostianov, Grigory.
- Sforza, Carlo.
- Shen, Zhihua.
- Siad Barre, Moḥammed.
- Silone, Ignazio (Secondo Tranquilli).
- Siracusano, Gabriele.
- Slezkine, Yuri.
- Sluga, Glenda.
- Smith, Stephen A.
- Somai, Giovanni.
- Sorgonà, Gregorio.
- Souvarine, Boris (Boris Lifschitz).
- Spadolini, Giovanni.
- Spagnolo, Carlo.
- Spano, Velio.
- Spaskovska, Ljubica.
- Spinelli, Altiero.
- Spriano, Paolo.
- Srivastava, Neelam.
- Stalin, Iosif (Iosif Vissarionovič Džugašvili).
- Strazzeri, Victor.
- Studer, Brigitte.
- Sukarno, Akmed (Kusno Sosrodihardjo).
- Suslov, Michail Andreevič.
- Taber, Mike.
- Tambor, Molly.
- Tarquini, Alessandra.
- Tarrow, Sidney G.
- Tasca, Angelo.
- Tatò, Antonio.
- Tavani, Sara.
- Taviani, Ermanno.
- Terracini, Umberto.
- Thälmann, Ernst.
- Thomassen, Bjørn.
- Thorez, Maurice.
- Tito, Josip Broz, detto.
- Togliatti, Palmiro.
- Tomilina, Natalja.
- Tonelli, Anna.
- Tooze, Adam.
- Tortorella, Aldo.
- Tosi, Luciano.
- Touré, Ahmed Sékou.
- Trentin, Bruno.
- Tresso, Pietro.
- Treves, Claudio.
- Trilisser, Michail Abramovič.
- Trockij, Lev (Lev Davidovič Bronštein).
- Truman, Harry S.
- Tschubarjan, Alexander.
- Tulli, Umberto.
- Turati, Filippo.
- Tutočkin, Jurij Tichonovič.
- Vacca, Giuseppe.
- Valenzi, Maurizio.
- Varga, Evgenij Samuilovič.
- Varsori, Antonio.
- Vatlin, Aleksandr Jur′evič.
- Ventrone, Angelo.
- Venturi, Antonello.
- Vidali, Vittorio.
- Vidic, Dobrivoje.
- Vigreux, Jean.
- Vittoria, Albertina.
- Vyšinskij, Andrej Januar′evič.
- Wałęsa, Lech.
- Wang Ming.
- Weber, Hermann.
- Westad, Odd Arne.
- Wilson, Thomas Woodrow.
- Wollemborg, Leo J.
- Wojtyła, Karol Józef, vedi Giovanni Paolo II.
- Wolikow, Serge.
- Xia, Yafeng.
- Young, Marilyn B.
- Zaccaria, Benedetto.
- Zagladin, Vadim Valentinovič.
- Zaslavsky, Victor.
- Ždanov, Andrej Aleksandrovič.
- Zetkin, Clara Eissner.
- Zhou Enlai.
- Zinov′ev, Grigorij Evseevič (Hirsch Apfelbaum).
- Živkov, Todor Hristov.
Il libro
Silvio Pons rilegge visioni, legami, protagonisti e momenti principali nella storia del comunismo italiano come un particolare caso di studio del comunismo globale. La cultura politica espressa da gruppi dirigenti a forte vocazione intellettuale e da personalità come Gramsci, Togliatti, Berlinguer viene analizzata nelle visioni dell’ordine europeo e mondiale, nella costruzione di senso dei nessi tra identità nazionali e appartenenze internazionali, nell’approccio ai temi della pace e della guerra. L’internazionalismo fu una genealogia rivoluzionaria, un fondamento simbolico, un complesso di pratiche e una cultura condivisa. I comunisti italiani si ritagliarono un posto specifico nel progetto globale nato nel 1917, dando vita al principale partito comunista in Occidente e proponendosi come coscienza critica di una «comunità immaginata» su scala mondiale. Piú di ogni altra cultura politica italiana, si legarono a influenze e connessioni transnazionali, con il risultato controverso di contribuire alla frattura della comunità nazionale nella guerra fredda e di esercitare un’opera di mediazione oltre i confini e le rappresentazioni dell’ordine bipolare. Il loro internazionalismo si trasformò nel corso del tempo, sebbene senza mai recidere del tutto il legame esistenziale con la matrice originaria, fino a confluire nella visione dell’Europa come soggetto della politica mondiale. Un’eredità che ha senso rivisitare oggi, in un tempo che registra il declino degli internazionalismi del secolo scorso mentre il mondo transnazionale stenta a emergere.
I comunisti italiani si rappresentarono sempre come una forza nazionale e internazionale, seppure declinando i due termini in modi assai diversi tra loro nel corso del tempo. Silvio Pons ricostruisce le loro visioni, i legami e le strategie come un particolare caso di studio del comunismo globale. Tramite l’intera parabola del Pci, è possibile vedere i nessi e le interazioni molteplici tra la storia italiana e questioni cruciali del Novecento quali l’impatto della rivoluzione bolscevica nel 1917, le esperienze dell’antifascismo e dello stalinismo, la guerra fredda e la divisione dell’Europa, la decolonizzazione e la nascita del mondo postcoloniale, il «Sessantotto globale», il ruolo della Comunità Europea, la fine del comunismo in Europa.
A cent’anni dalla scissione di Livorno del gennaio 1921, questo libro rilegge protagonisti e momenti principali della storia del comunismo italiano in un’ottica internazionale, fino alla sua conclusione dopo la caduta del Muro di Berlino nel novembre 1989.
L’autore
SILVIO PONS insegna Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. È presidente della Fondazione Gramsci. Tra le sue pubblicazioni con Einaudi ricordiamo: Berlinguer e la fine del comunismo (2006), La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991 (2012) e la cura (con Robert Service) del Dizionario del comunismo nel XX secolo (2006-2007). È General Editor della Cambridge History of Communism (Cambridge University Press 2017).
Dello stesso autore
- Berlinguer e la fine del comunismo
- La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991
- Dizionario del comunismo nel XX secolo (con Robert Service, a cura di)
© 2021 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
In sopracoperta: Renato Guttuso, I funerali di Togliatti, acrilici e collage di carta stampata bloccato su pannelli di compensato, 1972, particolare. Bologna, MaMbo, in comodato su gentile concessione dell’Associazione Enrico Berlinguer. (© Renato Guttuso, by SIAE 2021 / Foto © Enzo Brai / Electa / Mondadori Portfolio).
ISBN 9788858435816
martedì 23 marzo 2021 (revisione: 7 febbraio 2022 alle ore 11:32:17)
Pons vs. Berlinguer, 3
Qualche pagina da Silvio Pons, «Berlinguer e la fine del Comunismo», Einaudi, Torino, 2006
Le scansioni, con qualche passaggio evidenziato, del capitolo «Lo 'strappo' riluttante» di Silvio Pons, «Berlinguer e la fine del Comunismo», Einaudi, Torino, 2006 (vedi post), capitolo dedicato ai dibattiti nel PCI nei giorni successivi al colpo di Stato militare in Polonia, 1980. Segue qualche ulteriore brevissimo commento.
Clicca sulla scansione per ingrandirla. Puoi scorrere le scansioni. 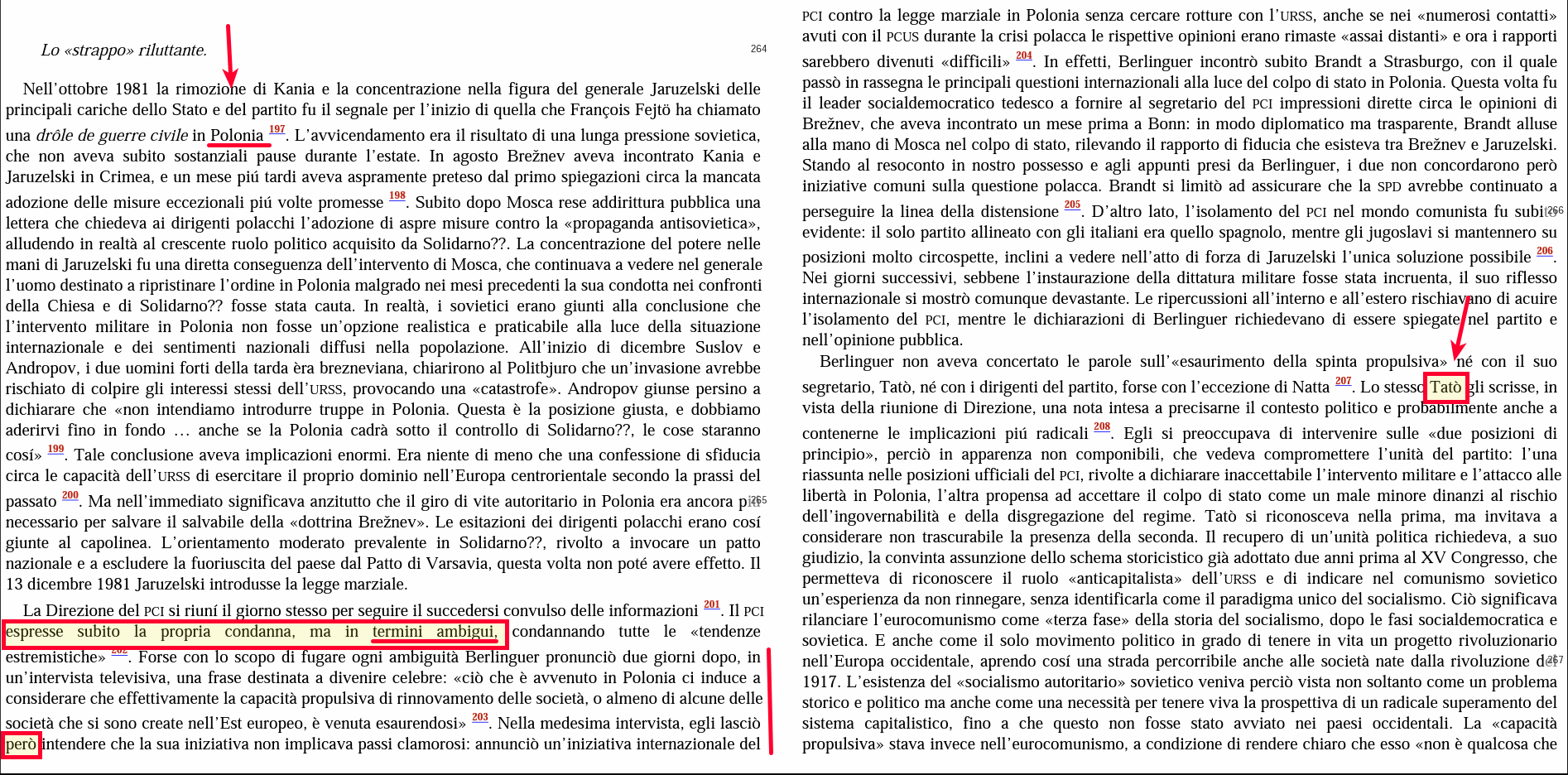
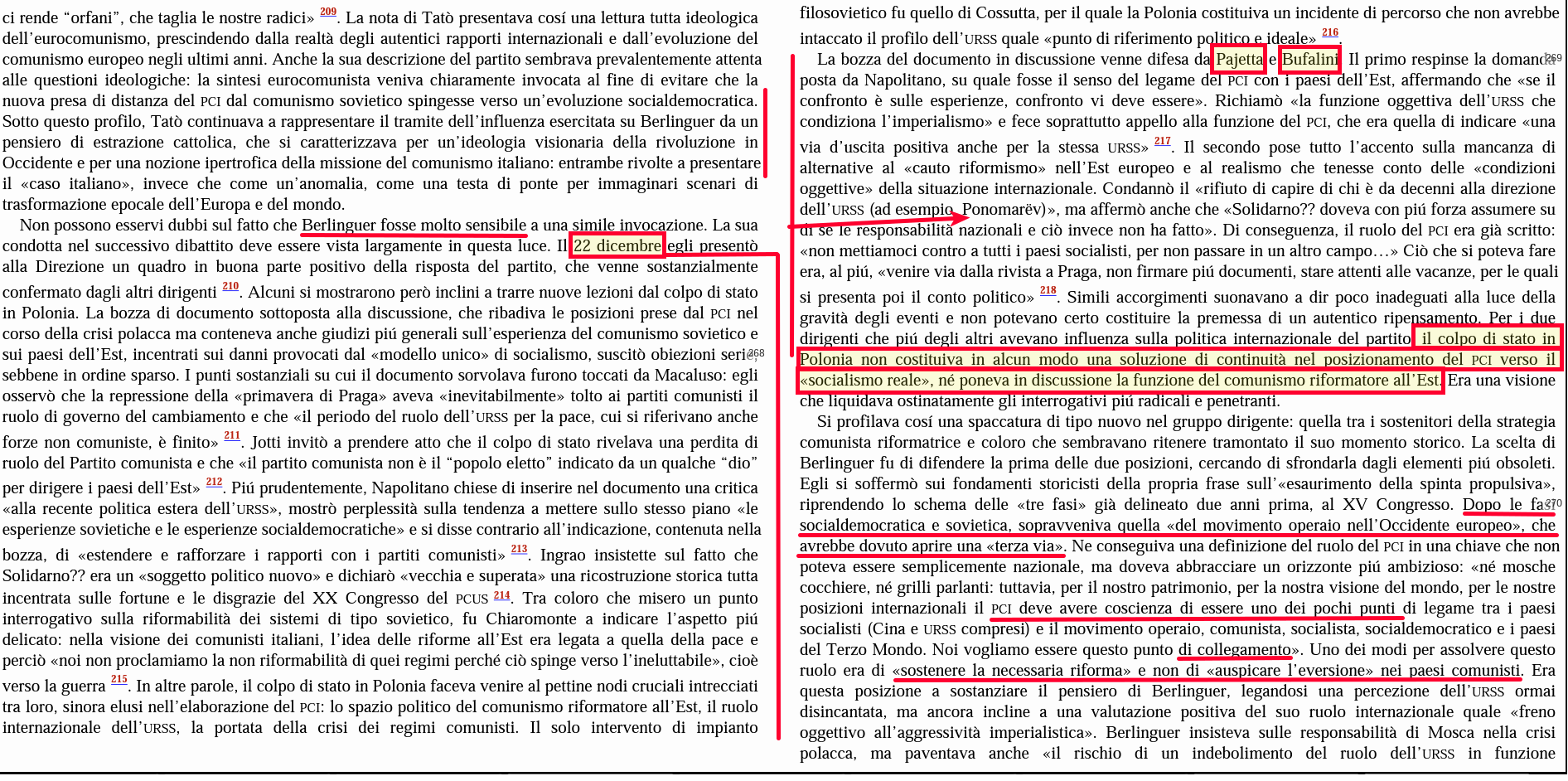
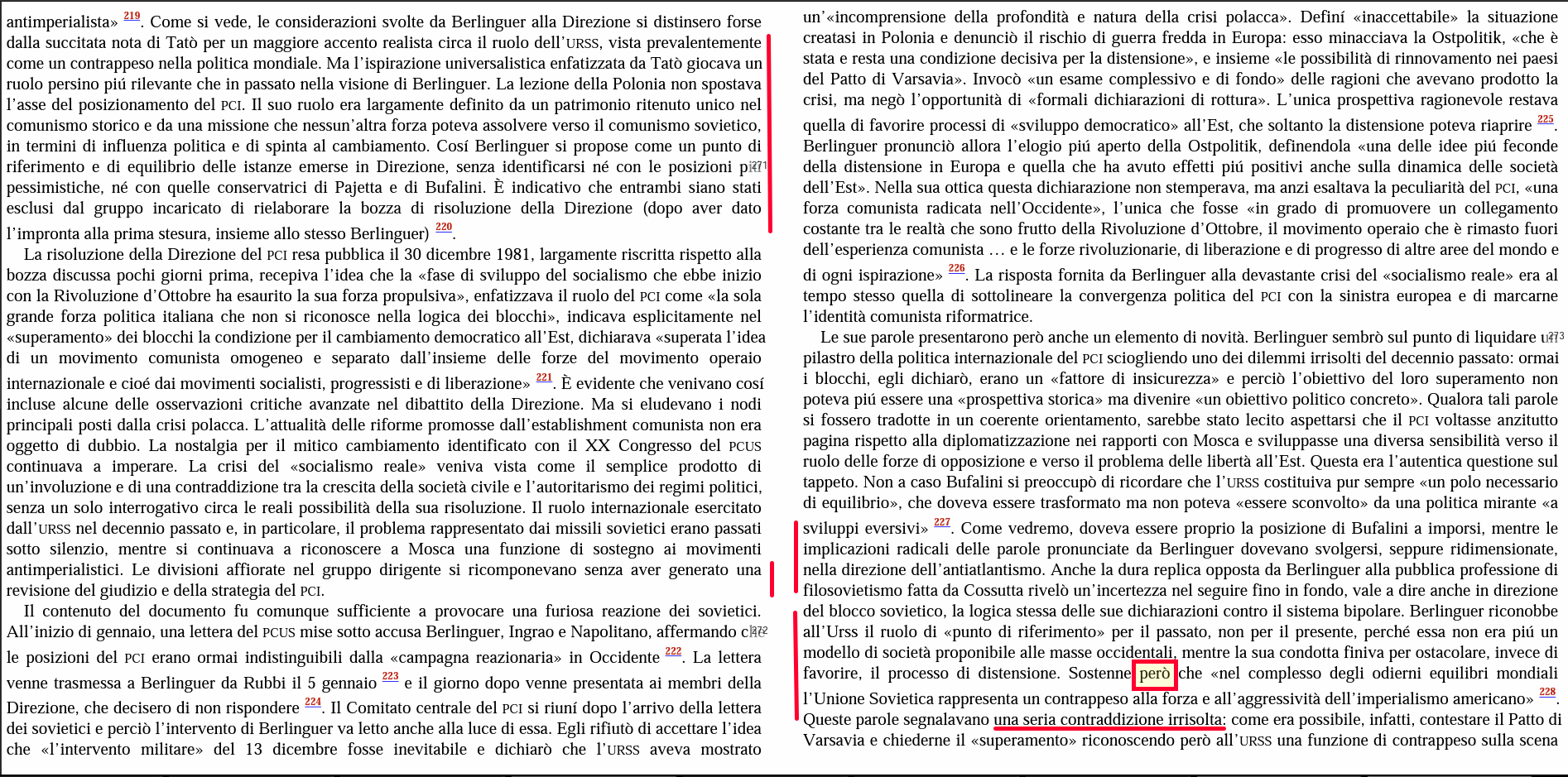
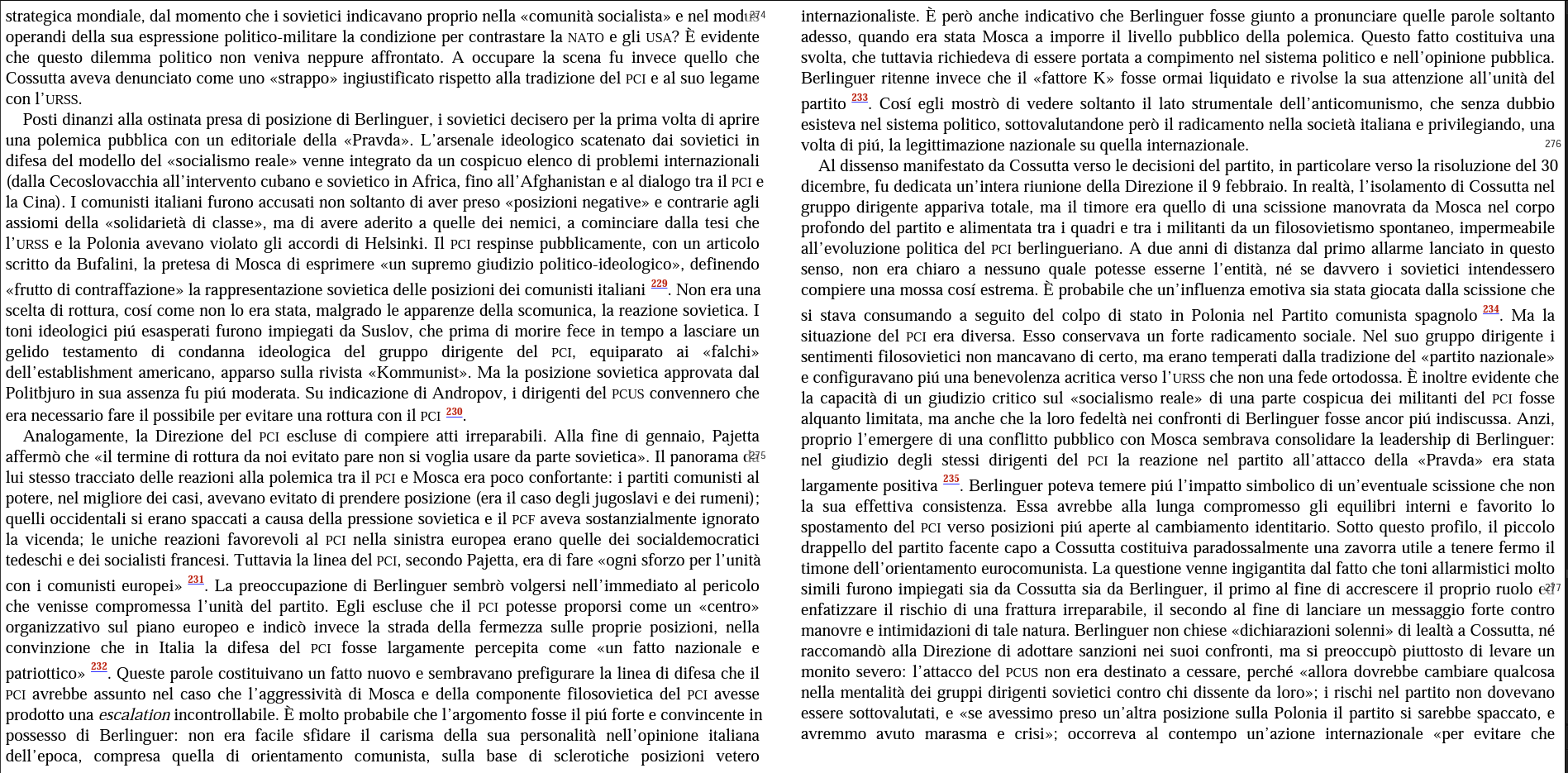
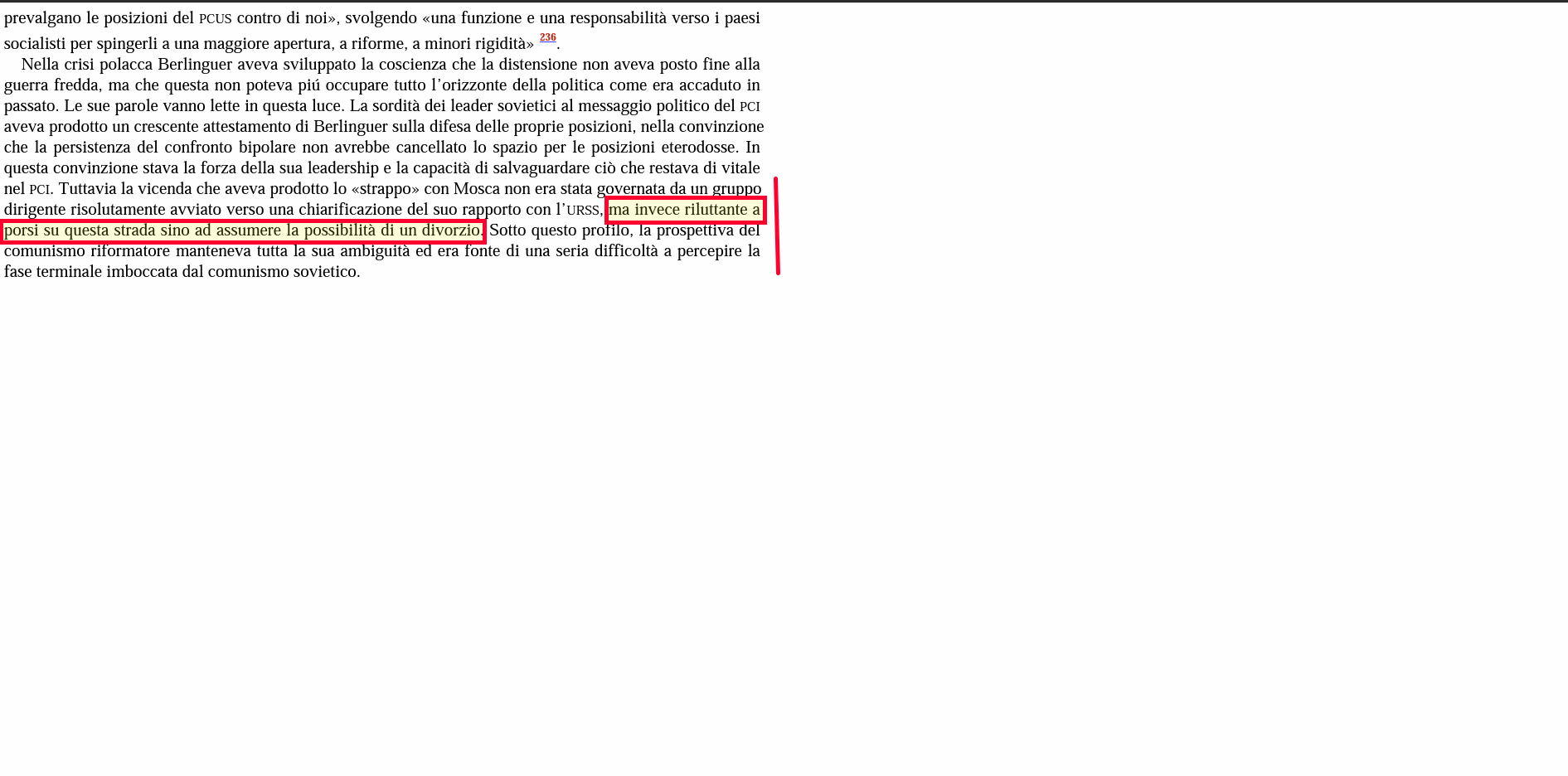
Tre passaggi che colpiscono:
-
il giudizio liquidatorio delle posizioni di Tatò, che pur di Berlinguer fu stretto consigliere;
-
la teoria, attribuita a Berlinguer, delle tre fasi storiche del movimento socialista: socialdemocratica (fino alla prima guerra mondiale?), sovietica, e -terza- quella auspicata con protagonista il "movimento operaio nell'Occidente europeo" (fase eurocomunista?). Teoria che appare piuttosto bislacca, e che, se fu realmente teorizzata, fu un wishful thinking per evitarsi il dilemma, in effetti ineludibile, tra 'ci siamo sbagliati fin dal 1917' e 'nonostante tutto l'URSS è meglio e da difendere';
-
tra le righe, il danno di non aver lasciato andare Cossutta, che nelle note qui non riprodotte Pons suggerisce chiaramente che abbia agito in combutta con Ponomariov.
I motivi della riluttanza dello «strappo» furono probabilmente molteplici, e principale alla fin fine quello che nessuno modifica completamente delle ben radicate convinzioni con cui si è identificato per gran parte della propria vita (se non forse per eventi traumatici o a seguito di circostanze eccezionali). Valse comunque, io credo, non tanto il timore di un ampia emorragia di militanti e/o elettori -che non ci sarebbe stata (semmai ebbe un qualche peso il mito dell'unità)-, ma la contezza della difficoltà di collocare, nel quadro interno oltre che in quello internazionale, un PCI completamente divorziato da Mosca. Per il quadro interno, un qualsiasi tentativo di (ri)collocazione nell'area socialista (e di iscrizione all'Internazionale Socialista) avrebbe richiesto una modifica molto articolata di convinzioni, prassi di comportamento e apparati che nessuno ebbe di fatto la lucidità di affrontare (perfino dopo il 1989, e il campo libero lasciato dal collasso di PSI e PSDI, quella ricollocazione è stata molto parziale). Per il quadro internazionale, nessuno -nemmeno nei circoli iper atlantici- sembra che fu mai veramente interessato a un modifica di collocazione internazionale del PCI, in particolare se pensata fuori dalle specifiche strategie dell'alleanza atlantica, anche solo per il timore di contracolpi non programmati negli equilibri dello scenario europeo.
